
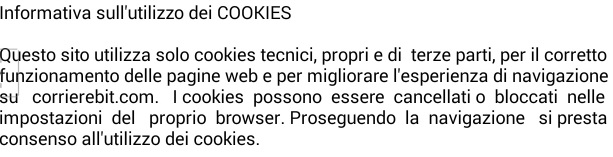

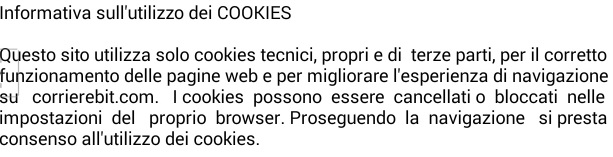
|
k
k
|
APRILE 2024 Un pomeriggio primaverile e soleggiato può essere ben speso, per chi abita a Milano, in un piacevole giro, in buona parte a piedi, che coniuga bellezze artistiche, storia e natura. Con la linea gialla della metropolitana siamo scesi al capolinea di San Donato Milanese; da qui, dopo una passeggiata di circa un quarto d’ora lungo il viale alberato – via Caviaga - che costeggia il vasto Parco Enrico Mattei, siamo arrivati alla grande piazza
dominata dalla chiesa di Santa Barbara, da cui
prende il nome. L’edificio,
costruito nel 1954 per Metanopoli su commissione
di Mattei, è un pregevole esempio di
architettura religiosa, dovuta al progetto
dell’architetto Mario Bacciocchi. La facciata a
capanna con i colori del Rinascimento
fiorentino, il campanile laterale alto e
stretto, il portone centrale in bronzo di
Arnaldo e Giò Pomodoro sono già ammirevoli:
l’interno stupisce per l’ampiezza della navata,
che presenta un bel soffitto a pannelli dipinti
di Andrea Cascella e uno stupendo, grandissimo
mosaico absidale, la Crocifissione di Fiorenzo
Tomea, ben illuminato dal lucernario, nonché
diverse opere d’arte quali la Via Crucis di
Pericle Fazzini e le pale di siamo arrivati alla grande piazza
dominata dalla chiesa di Santa Barbara, da cui
prende il nome. L’edificio,
costruito nel 1954 per Metanopoli su commissione
di Mattei, è un pregevole esempio di
architettura religiosa, dovuta al progetto
dell’architetto Mario Bacciocchi. La facciata a
capanna con i colori del Rinascimento
fiorentino, il campanile laterale alto e
stretto, il portone centrale in bronzo di
Arnaldo e Giò Pomodoro sono già ammirevoli:
l’interno stupisce per l’ampiezza della navata,
che presenta un bel soffitto a pannelli dipinti
di Andrea Cascella e uno stupendo, grandissimo
mosaico absidale, la Crocifissione di Fiorenzo
Tomea, ben illuminato dal lucernario, nonché
diverse opere d’arte quali la Via Crucis di
Pericle Fazzini e le pale di
 Bruno Cassinari.
Santa Barbara è considerata la patrona dei
minatori, e il nome fu scelto in quanto legato
alle attività minerarie dell’ENI. In questa
chiesa, la mattina del 29 ottobre 1962, fu dato
l’ultimo saluto al suo presidente Enrico Mattei,
insieme al pilota Irnerio Bertuzzi e
all’americano William MacHale, periti
nell’attentato di due giorni prima al Morane
Saulnier -decollato da Catania - su cui
volavano; le salme furono poi traslate a Roma
per i funerali di Stato. Mattei, infine, fu
sepolto nella tomba di famiglia del cimitero di
Matelica. Come scrisse all’epoca la Gazette de
Lausanne, Mattei “non era soltanto un grande
capitano d’industria, ma anche un uomo simpatico
ed integro; un uomo che è riuscito nel suo
compito”; pertanto, si conserverà di lui “un
ricordo incancellabile”. Bruno Cassinari.
Santa Barbara è considerata la patrona dei
minatori, e il nome fu scelto in quanto legato
alle attività minerarie dell’ENI. In questa
chiesa, la mattina del 29 ottobre 1962, fu dato
l’ultimo saluto al suo presidente Enrico Mattei,
insieme al pilota Irnerio Bertuzzi e
all’americano William MacHale, periti
nell’attentato di due giorni prima al Morane
Saulnier -decollato da Catania - su cui
volavano; le salme furono poi traslate a Roma
per i funerali di Stato. Mattei, infine, fu
sepolto nella tomba di famiglia del cimitero di
Matelica. Come scrisse all’epoca la Gazette de
Lausanne, Mattei “non era soltanto un grande
capitano d’industria, ma anche un uomo simpatico
ed integro; un uomo che è riuscito nel suo
compito”; pertanto, si conserverà di lui “un
ricordo incancellabile”.
Proseguendo, con una
camminata di una ventina di minuti si raggiunge,
in fondo a via Cesare Battisti, la piazza delle
Arti; qui si trova la Cascina Roma, restaurata
trent’anni fa e trasformata in un attivo centro
culturale. L’ingresso è gratuito e vi si possono
ammirare
Lasciata Cascina Roma, si
torna indietro per un tratto, portandosi sulla
via Emilia e seguendo una strada che consente di
oltrepassare la ferrovia e l’A1, tramite
sottopassi (meglio seguire le indicazioni del
navigatore satellitare, mancando la segnaletica
per percorsi pedonali o ciclabili). Questa parte della passeggiata è più impegnativa e richiede
almeno un’ora: la meta è la meravigliosa Abbazia
di Chiaravalle, che si raggiunge camminando tra
prati e pioppi, in un bel paesaggio
La passeggiata può anche prevedere l’inversione delle tappe (Abbazia di Chiaravalle – Cascina Roma - Chiesa di Santa Barbara), con l’andata a piedi e il ritorno in metropolitana dalla stazione di San Donato Milanese.25 aprile 2024, Anna Busca Un paio
di giorni, durante le vacanze pasquali, nella
Pianura Padana tra le province di Modena, Reggio
Emilia e Parma, sfiorando quella di Mantova, ci
ha consentito di scoprire dei veri tesori, un po’
nascosti e assolutamente meritevoli di maggiore
pubblicità per il turismo culturale. Partendo da
Milano in auto e percorrendo l’A1, siamo usciti
verso Verona/Brennero (E45/A22) al casello di
Carpi,
A
Baldassarre Peruzzi (1481-1536), noto architetto
e pittore toscano molto stimato a Roma, Alberto
III aveva commissionato, nel 1515, una serie di
lavori: una nuova facciata della chiesa romanica
di Santa Maria al Castello, il progetto del
Duomo e
Sulla piazza si affaccia anche il bel Teatro comunale, del colore arancione che connota molti edifici della città, inaugurato nel 1861, dopo la proclamazione del Regno d’Italia. Lasciata Carpi, ci siamo diretti nella vicina Correggio, città che ha dato l’appellativo al suo artista più famoso, il pittore Antonio Allegri (1489 –1534), cui è stato dedicato un bel monumento in marmo
bianco di Carrara, scolpito dal ticinese
Vincenzo Vela nel 1880: si trova in piazza San
Quirino, allargata per l’occasione. Di origine
medioevale, Correggio raggiunse il massimo
splendore nei secoli XV
–
XVI; la Corte ospitò l’Ariosto, il Bembo,
Ludovico il Moro. Divenne Principato nel 1616,
ma neppure vent’anni dopo questo fu annesso al
Ducato estense.
L’elegante Palazzo dei Principi,
sull’asse di corso Cavour, tra la bella basilica
di San Quirino e il Teatro Asioli, fu fatto
costruire dalla vedova del conte Borso da
Correggio, Francesca di Brandeburgo, e fu
completato nel 1507. La facciata, in cotto,
presenta bifore e monofore; il portale è
stupendo, con decorazioni a bassorilievo: viene
considerato uno tra i più significativi esempi
del
rinascimento emiliano. Il bel cortile cui è stato dedicato un bel monumento in marmo
bianco di Carrara, scolpito dal ticinese
Vincenzo Vela nel 1880: si trova in piazza San
Quirino, allargata per l’occasione. Di origine
medioevale, Correggio raggiunse il massimo
splendore nei secoli XV
–
XVI; la Corte ospitò l’Ariosto, il Bembo,
Ludovico il Moro. Divenne Principato nel 1616,
ma neppure vent’anni dopo questo fu annesso al
Ducato estense.
L’elegante Palazzo dei Principi,
sull’asse di corso Cavour, tra la bella basilica
di San Quirino e il Teatro Asioli, fu fatto
costruire dalla vedova del conte Borso da
Correggio, Francesca di Brandeburgo, e fu
completato nel 1507. La facciata, in cotto,
presenta bifore e monofore; il portale è
stupendo, con decorazioni a bassorilievo: viene
considerato uno tra i più significativi esempi
del
rinascimento emiliano. Il bel cortile
 d’onore è porticato; da qui si accede alla Sala
dei Putti, affrescata, e alla Biblioteca
comunale. Salendo uno scalone si giunge a
splendide stanze dove, oltre agli affreschi alle
pareti, si possono ammirare soffitti a
cassettone, come nella Sala del Camino. Al piano
nobile ha sede il Museo Civico “Il Correggio”,
con opere di pregio; qui sono esposti i pochi
lavori di Antonio Allegri conservati nella sua
città natale, ossia i dipinti a olio su tavola,
“La Pietà” (1512), “Il Volto di Cristo” (1518),
“Sant’Agata” (1523-1524), insieme a un disegno
bifacciale, con apostoli e angeli
–
che compariranno d’onore è porticato; da qui si accede alla Sala
dei Putti, affrescata, e alla Biblioteca
comunale. Salendo uno scalone si giunge a
splendide stanze dove, oltre agli affreschi alle
pareti, si possono ammirare soffitti a
cassettone, come nella Sala del Camino. Al piano
nobile ha sede il Museo Civico “Il Correggio”,
con opere di pregio; qui sono esposti i pochi
lavori di Antonio Allegri conservati nella sua
città natale, ossia i dipinti a olio su tavola,
“La Pietà” (1512), “Il Volto di Cristo” (1518),
“Sant’Agata” (1523-1524), insieme a un disegno
bifacciale, con apostoli e angeli
–
che compariranno
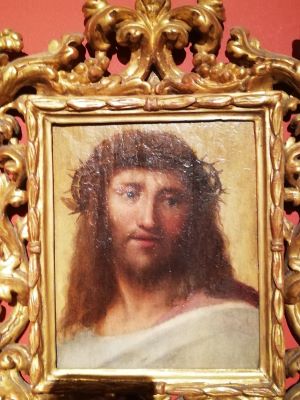 negli affreschi della cupola
del duomo di Parma
–
e alcuni suoi studi architettonici sul retro. Si
possono ammirare anche un prezioso dipinto di
Andrea Mantegna (1431-1506), ossia il Cristo
Redentore (1493), bellissimi arazzi fiamminghi,
ritratti, una statua lignea di Desiderio da
Settignano (1430-1464), una collezione di monete
della zecca di Correggio, e perfino il magnifico
fortepiano settecentesco appartenuto al
compositore correggese Bonifazio Asioli
(1769-1832),
di cui sono esposti spartiti e
opere. A Correggio abbiamo pernottato all’elegante
e tranquillo Phi Hotel dei Medaglioni, a pochi
passi dal Palazzo dei Principi, prenotato
tramite Booking, con un eccellente rapporto
qualità/prezzo. Il centro storico
–
con le sue case antiche dalle facciate colorate
in rosa, vermiglio, giallo, arancio, e i portici
medioevali
–
ha un notevole fascino anche di notte, grazie a
una sapiente illuminazione. Molto bello l’ottocentesco
Palazzo Cattini (o dell’Orologio)
su corso Mazzini. Per la cena abbiamo scelto
“La
Galera”,
originale ristopub nel sotterraneo di un
edificio storico, dove si possono gustare piatti
locali e ottimi taglieri di salumi e formaggi. negli affreschi della cupola
del duomo di Parma
–
e alcuni suoi studi architettonici sul retro. Si
possono ammirare anche un prezioso dipinto di
Andrea Mantegna (1431-1506), ossia il Cristo
Redentore (1493), bellissimi arazzi fiamminghi,
ritratti, una statua lignea di Desiderio da
Settignano (1430-1464), una collezione di monete
della zecca di Correggio, e perfino il magnifico
fortepiano settecentesco appartenuto al
compositore correggese Bonifazio Asioli
(1769-1832),
di cui sono esposti spartiti e
opere. A Correggio abbiamo pernottato all’elegante
e tranquillo Phi Hotel dei Medaglioni, a pochi
passi dal Palazzo dei Principi, prenotato
tramite Booking, con un eccellente rapporto
qualità/prezzo. Il centro storico
–
con le sue case antiche dalle facciate colorate
in rosa, vermiglio, giallo, arancio, e i portici
medioevali
–
ha un notevole fascino anche di notte, grazie a
una sapiente illuminazione. Molto bello l’ottocentesco
Palazzo Cattini (o dell’Orologio)
su corso Mazzini. Per la cena abbiamo scelto
“La
Galera”,
originale ristopub nel sotterraneo di un
edificio storico, dove si possono gustare piatti
locali e ottimi taglieri di salumi e formaggi.
Il
nostro giro è proseguito verso Finale Emilia,
purtroppo ancora segnata dal terremoto del 2012:
il 20 e il 29 maggio si ebbero
Ci siamo quindi spostati a
Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, su un
argine del Po, passando per zone di pianura
coltivata attraversate dalla Secchia.
Classificato come uno dei “borghi più belli
d’Italia”, lascia incantati per la straordinaria
piazza Il Palazzo era chiuso per Pasqua (peccato!) e non siamo riusciti a visitarlo. Al suo interno si trovano sale affrescate e collezioni  di dipinti e di costumi
teatrali; ospita un museo documentario e un
centro studi dedicati al grande pittore e
scultore naif Antonio Ligabue (1899-1965), che
giunse qui nell’agosto 1919 dalla natia Svizzera,
da cui era stato espulso per aver aggredito la
madre adottiva, e vi rimase
–
alternando il soggiorno, dal 1937 al 1945, a
diversi ricoveri nell’ospedale
psichiatrico di Reggio Emilia - fino alla morte.
La tomba, che reca la sua maschera funebre in
bronzo, opera dello scultore Andrea Mozzali, è
al cimitero di Gualtieri. di dipinti e di costumi
teatrali; ospita un museo documentario e un
centro studi dedicati al grande pittore e
scultore naif Antonio Ligabue (1899-1965), che
giunse qui nell’agosto 1919 dalla natia Svizzera,
da cui era stato espulso per aver aggredito la
madre adottiva, e vi rimase
–
alternando il soggiorno, dal 1937 al 1945, a
diversi ricoveri nell’ospedale
psichiatrico di Reggio Emilia - fino alla morte.
La tomba, che reca la sua maschera funebre in
bronzo, opera dello scultore Andrea Mozzali, è
al cimitero di Gualtieri.
Ripresa l’auto, abbiamo percorso belle strade tra pioppeti, fermandoci anche per una breve passeggiata a piedi lungo una golena del Po a Brescello, nei luoghi resi famosi dai film degli anni ‘50 di Peppone e don Camillo, interpretati dagli indimenticabili Gino Cervi e Fernandel. La nostra ultima meta
pasquale è stata Colorno: qui ci aspettava la
cosiddetta “Versailles dei Duchi di Parma”, una
meravigliosa Reggia, residenza dei Farnese, dei
Borbone e infine della seconda moglie di
Napoleone, Maria Luigia d’Austria. Nata dalla
trasformazione di un palazzo
Ci siamo chiesti perché una tale bellezza, facilmente raggiungibile, non venga pubblicizzata molto di più, essendo una meta culturale di inestimabile valore: purtroppo non abbiamo neppure visto, lungo la strada, cartelli che segnalassero il luogo, così come per Gualtieri. In ogni caso, è proprio vero che in Italia, ovunque si vada, anche per un paio di giorni soltanto, si possono trovare meraviglie. 4 aprile 2024, Anna Busca MARZO 2024 LA FINLANDIA È IL PAESE PIÙ FELICE DEL MONDO PER IL 7° ANNO CONSECUTIVO Aperte le candidature per volare a Helsinki e scoprire tutti i trucchi della felicità finlandese con la nuova masterclass di Visit Finland e Helsinki Partners!
Con un primato da record che vede la nazione aggiudicarsi il prestigioso titolo internazionale dal 2018, in molti si sono chiesti quale sia il segreto della felicità finlandese. Nessun mistero, solo la combinazione di elementi chiave che da sempre scandiscono l’esistenza di questo popolo, ovvero: la connessione con la natura, uno stile di vita equilibrato, cibo fresco e un approccio alla vita sostenibile. Secondo i finlandesi, infatti, la felicità non è un mistero ma piuttosto un insieme di trucchi e abilità da apprendere e mettere in pratica ogni giorno. Da una passeggiata nel bosco o un tuffo in mare dopo la sauna a un pasto preparato con ingredienti locali appena raccolti: ecco alcuni piccoli segreti per essere felici. Dopo il successo della prima Masterclass sulla Felicità lanciata nel 2023 nella magica regione dei laghi, la Finlandia torna ad ospitare dal 9 al 14 giugno 2024 un gruppo di fortunati provenienti da ogni angolo del globo a cui svelare i trucchi per essere felici. Per farlo, Visit Finland insieme ad Helsinki Partners, ha selezionato questa volta gli Helsinki Happiness Hacker: un team di hacker della felicità, composto da cinque helsinkiani, che guiderà il gruppo alla scoperta della capitale finlandese per apprendere tutti i trucchi per essere felici ogni giorno e trovare il finlandese che c’è in ognuno di loro. Come? Immergendosi nella vivace vita cittadina! A fare da filo conduttore della masterclass sui trucchi della felicità finlandese saranno quattro focus tematici: natura e stile di vita, salute ed equilibrio, design e quotidianità, alimentazione e benessere. La masterclass Helsinki Happiness Hacks con tanto di spedizione urbana nella capitale sarà interamente gratuita per i partecipanti selezionati e Visit Finland, insieme a Helsinki Partners, coprirà le spese di viaggio da e per la Finlandia. I fortunati vincitori potranno godere di un'esperienza di cinque giorni ideata e curata nei minimi dettagli dal team di hacker della felicità di Helsinki, che li guiderà alla scoperta del loro helsinkiano interiore. Le candidature alla masterclass sono aperte fino al 4 aprile 2024. Per candidarsi e trovare ulteriori informazioni, visita: https://www.visitfinland.com/it/helsinki-happiness-hacks-it/happiness-hackers-it/ · È possibile candidarsi fino al 4 aprile 2024. Gli interessati possono candidarsi partecipando alla challenge sui social e completando un modulo di iscrizione online disponibile sulla pagina web della campagna. · L'esperienza, organizzata da Visit Finland e Helsinki Partners, è completamente gratuita e prevede una masterclass di 5 giorni guidata da 5 helsinkiani, tra cui Lena Salmi (ex campionessa di nuoto e giornalista sportiva), Adela Pajunen (Biologa, scrittrice e sostenitrice del benessere attraverso la natura) e Luka Balac (rinomato esperto gastronomico e fondatore di 3 ristoranti di successo a Helsinki, tra cui il Nolla) Milano, 24 marzo 2024 c.stampa
UN SABATO A BOLOGNA Siamo riusciti a comprare online, sul sito di Flixbus, due biglietti andata/ritorno da Milano San Donato a Bologna, al prezzo – davvero vantaggioso! - di circa 10 euro ciascuno. Viaggio comodissimo, in perfetto orario: partenza alle 8.00 dal terminal, a poche decine di metri dal capolinea della linea gialla della metropolitana, e arrivo alle 10.20 alla Stazione delle Autolinee di Bologna, nei pressi della Stazione Centrale (ritorno alle 18.30, con arrivo a San Donato alle 20.45). La nostra meta principale era lo struggente Museo della Memoria di Ustica, raggiunto in neppure venti minuti a piedi percorrendo quasi in linea retta via Matteotti, via Ferrarese, fino a via di Saliceto 3/22 (www.mambo-bologna.org/museoustica ). Il museo ha sede nel quartiere della Bolognina, in un ex deposito tramviario, ed è visitabile gratuitamente sabato e domenica dalle 10 alle 18.30, oppure giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Questo luogo, dove si entra in silenzio restando profondamente commossi davanti all’installazione dell’artista Christian Boltanski – 81 lampadine, appese al soffitto, che si accendono e si spengono, come cuori pulsanti, e 81 specchi neri abbinati a registrazioni di voci sussurranti, tutti intorno al relitto dell’aereo- è stato voluto dall’”Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica”, fondata nel 1988 e presieduta da Daria Bonfietti, il cui fratello Alberto morì, a 37 anni, nel disastro. Erano circa le 21 della sera di venerdì 27 giugno 1980 quando i piloti del volo IH870, partito dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna alle 20.08, con due ore di ritardo, e diretto a Palermo, cessarono di rispondere alle torri di controllo, poco prima dell’atterraggio. L’aereo
era un DC-9 dell’Itavia, con a bordo 81 persone,
tra cui 13 bambini e 4 membri dell’equipaggio.
Le ricerche portarono ad avvistare, all’alba,
una chiazza oleosa, resti di corpi umani e
oggetti nella zona di mare tra Ustica e Ponza:
si parlò di cedimento strutturale, o di una
collisione in volo, oppure di una bomba a bordo,
tutte cause che furono poi scartate dalle
indagini successive. Depistaggi e omissioni,
bugie e smentite, nonché alcuni decessi
misteriosi di controllori di volo, militari e
piloti, collegati alla vicenda, confermarono che
la verità dietro il disastro era “indicibile”
per l’Aeronautica Militare italiana, anche se
alcuni coraggiosi giornalisti d’inchiesta, tra i
quali Andrea Purgatori, avevano proposto una
spiegazione plausibile quanto spaventosa.
Tracciati radar, faticosamente recuperati,
mostravano un traffico aereo insolito intorno al
DC-9, che a volte appariva come una doppia
traccia, perché un velivolo “si nascondeva”
utilizzandolo come schermo: si parlò quindi di
una possibile azione militare
franco-statunitense d’intercettamento, con
Phantom F4, partiti da una portaerei americana,
contro Mig libici nel cielo di Ustica. Uno dei
missili lanciati contro questi avrebbe dunque
finito per colpire e abbattere l’aereo di linea
dell’Itavia. Il ritrovamento in Calabria, sulla
Sila, del cadavere di un pilota libico e dei
resti del suo Mig-23 (ufficialmente il 18 luglio
1980) alimentò questa ipotesi. Nel 1987 e nel
1991 si svolsero due importanti campagne di
recupero dei resti del DC9, a 3700 m di
profondità: emersero circa 2500 pezzi. Nella
sala del museo il 96% del relitto
–
analizzato per l’inchiesta,
con
molti oblò ancora integri
che escludono l’esplosione interna
–
è stato ricomposto, come una sorta di fossile
gigante di 15 tonnellate e 31 m di lunghezza,
che ci parla di una storia del passato, ma
ancora vivissima per tutti: in una saletta si
può assistere alla proiezione di un commovente
filmato in cui si dà metaforicamente voce
all’aereo caduto. A tutt’oggi, né le dinamiche
esatte di quanto successo né i nomi dei
responsabili politici e militari dell’attacco,
sferrato come azione di guerra in tempo di pace,
in violazione di confini e diritti, senza alcun
riguardo e pietà nei confronti di 81 esseri
umani innocenti - solo 38 i corpi restituiti
alle loro famiglie - sono stati chiariti e resi
noti, nonostante decenni di inchieste
parlamentari e giudiziarie e la connessa
desecretazione di documenti importanti. L’aereo
era un DC-9 dell’Itavia, con a bordo 81 persone,
tra cui 13 bambini e 4 membri dell’equipaggio.
Le ricerche portarono ad avvistare, all’alba,
una chiazza oleosa, resti di corpi umani e
oggetti nella zona di mare tra Ustica e Ponza:
si parlò di cedimento strutturale, o di una
collisione in volo, oppure di una bomba a bordo,
tutte cause che furono poi scartate dalle
indagini successive. Depistaggi e omissioni,
bugie e smentite, nonché alcuni decessi
misteriosi di controllori di volo, militari e
piloti, collegati alla vicenda, confermarono che
la verità dietro il disastro era “indicibile”
per l’Aeronautica Militare italiana, anche se
alcuni coraggiosi giornalisti d’inchiesta, tra i
quali Andrea Purgatori, avevano proposto una
spiegazione plausibile quanto spaventosa.
Tracciati radar, faticosamente recuperati,
mostravano un traffico aereo insolito intorno al
DC-9, che a volte appariva come una doppia
traccia, perché un velivolo “si nascondeva”
utilizzandolo come schermo: si parlò quindi di
una possibile azione militare
franco-statunitense d’intercettamento, con
Phantom F4, partiti da una portaerei americana,
contro Mig libici nel cielo di Ustica. Uno dei
missili lanciati contro questi avrebbe dunque
finito per colpire e abbattere l’aereo di linea
dell’Itavia. Il ritrovamento in Calabria, sulla
Sila, del cadavere di un pilota libico e dei
resti del suo Mig-23 (ufficialmente il 18 luglio
1980) alimentò questa ipotesi. Nel 1987 e nel
1991 si svolsero due importanti campagne di
recupero dei resti del DC9, a 3700 m di
profondità: emersero circa 2500 pezzi. Nella
sala del museo il 96% del relitto
–
analizzato per l’inchiesta,
con
molti oblò ancora integri
che escludono l’esplosione interna
–
è stato ricomposto, come una sorta di fossile
gigante di 15 tonnellate e 31 m di lunghezza,
che ci parla di una storia del passato, ma
ancora vivissima per tutti: in una saletta si
può assistere alla proiezione di un commovente
filmato in cui si dà metaforicamente voce
all’aereo caduto. A tutt’oggi, né le dinamiche
esatte di quanto successo né i nomi dei
responsabili politici e militari dell’attacco,
sferrato come azione di guerra in tempo di pace,
in violazione di confini e diritti, senza alcun
riguardo e pietà nei confronti di 81 esseri
umani innocenti - solo 38 i corpi restituiti
alle loro famiglie - sono stati chiariti e resi
noti, nonostante decenni di inchieste
parlamentari e giudiziarie e la connessa
desecretazione di documenti importanti.
Nel giardino, grazie a un poster, si può accedere tramite Qr code all’importante archivio degli articoli di Andrea Purgatori sulla strage di Ustica (https://archivioandreapurgatori.it/ ). A breve distanza, la Stazione Centrale, di fine Ottocento: devastata dai bombardamenti angloamericani del 1945 e ricostruita, non si può dimenticare che subì un gravissimo attentato terroristico di matrice neofascista e piduista il 2 agosto 1980, a poco più di un mese dalla tragedia di Ustica. Una bomba nascosta in una valigia scoppiò alle 10.25 nella sala d’aspetto, distruggendo l’ala occidentale, sotto le cui macerie rimasero 85 vittime. I feriti furono duecento, numerosi con gravi mutilazioni. Il loro memoriale è la stazione stessa: l’orologio è rimasto fermo all’ora della strage, e una grande lapide riporta incisi i nomi dei morti. Anche in questo caso non si è ancora raggiunta la verità completa su mandanti ed esecutori.
Non poteva mancare l’ingresso alla vicina Basilica di San Petronio, dove, a pagamento, è imperdibile la Cappella Bolognini, o Cappella dei Magi: sulla parete di sinistra è affrescato un grandioso Giudizio Universale, opera del 1410 di Giovanni da Modena, artista autore anche delle magnifiche Storie dei Re magi sulla parete di destra. Le scene dell’Inferno, che richiamano la prima cantica della Divina Commedia, sono potenti e impressionanti: un gigantesco Lucifero peloso troneggia al centro, con due teste, una delle quali corrisponde anatomicamente ai genitali; entrambe le bocche divorano un dannato.
18 marzo 2024, Anna Busca SETTEMBRE 2023 (prima parte: da Montbéliard a Le Trèport) Due giorni prima di Ferragosto abbiamo lasciato il caldo afoso di Milano per un giro in auto – di un paio di settimane - nel nord della Francia, considerando la Normandia come nostra meta principale. Circa trent’anni fa un nostro lungo tour europeo (in Panda!) aveva toccato Mont-Saint-Michel, ma non ci eravamo spinti oltre; e in successivi viaggi avevamo esplorato altre zone francesi, senza più tornare in questa regione. Eccoci dunque, come prima tappa logistica, dopo l’attraversamento della Svizzera, in Franca-Contea, a Montbéliard, dominata dal bel castello dei duchi di Württemberg; una grande piazza deserta, vie vuote, tutto chiuso. Per fortuna abbiamo trovato una piccola brasserie aperta per una cena veloce, in mezzo alle case colorate del bel centro storico. La mattina, percorrendo strade di campagna solitarie e bellissime, in un silenzio quasi surreale, tra mucche al pascolo ed estese
coltivazioni, ci siamo fermati a Ronchamp, dove
l’architetto Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
noto universalmente come Le Corbusier, progettò,
tra il 1950 e il 1955, la Cappella di Notre Dame
de Haut, in cima a una collina. Qui, in
precedenza, sorgeva un piccolo santuario oggetto
di antica devozione. Dichiarata Patrimonio
UNESCO, è un capolavoro di architettura
religiosa brutalista, in calcestruzzo armato;
bianchissima, dalle forme sinuose, con un grande
tetto scuro a barca, presenta all’interno una
luce straordinaria, naturale, che giunge
dall’alto e da aperture laterali. Una sorta di
edificio-scultura, dove si percepisce la purezza
dell’arte e dello spirito. Nelle vicinanze si
trovano il Rifugio del pellegrino, che
originariamente accoglieva gli operai addetti
alla costruzione, la Casa del cappellano e la
Piramide della pace, simile a una piccola
piramide azteca, commissionata dai veterani di
Ronchamp che volevano ricordare i loro morti
sulla collina nel 1944. Renzo Piano, nel 2011,
vi aggiunse il Monastero, con un orto molto
curato, l’Oratorio e le portinerie all’ingresso.
Questa prima visita valeva già il viaggio! mucche al pascolo ed estese
coltivazioni, ci siamo fermati a Ronchamp, dove
l’architetto Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
noto universalmente come Le Corbusier, progettò,
tra il 1950 e il 1955, la Cappella di Notre Dame
de Haut, in cima a una collina. Qui, in
precedenza, sorgeva un piccolo santuario oggetto
di antica devozione. Dichiarata Patrimonio
UNESCO, è un capolavoro di architettura
religiosa brutalista, in calcestruzzo armato;
bianchissima, dalle forme sinuose, con un grande
tetto scuro a barca, presenta all’interno una
luce straordinaria, naturale, che giunge
dall’alto e da aperture laterali. Una sorta di
edificio-scultura, dove si percepisce la purezza
dell’arte e dello spirito. Nelle vicinanze si
trovano il Rifugio del pellegrino, che
originariamente accoglieva gli operai addetti
alla costruzione, la Casa del cappellano e la
Piramide della pace, simile a una piccola
piramide azteca, commissionata dai veterani di
Ronchamp che volevano ricordare i loro morti
sulla collina nel 1944. Renzo Piano, nel 2011,
vi aggiunse il Monastero, con un orto molto
curato, l’Oratorio e le portinerie all’ingresso.
Questa prima visita valeva già il viaggio!
Procedendo lungo strade
secondarie siamo poi passati da Luxeuil-les-Bains,
centro termale, con la bellissima abbazia gotica
di Saint-Pierre et Saint-Paul (XIV sec.),
fondata originariamente da San Colombano nel VI
sec., poi ricostruita più volte. Un incredibile
organo monumentale del 1617,  Fu costruita
nel 1928 ad opera dell’architetto Achille
Duchêne per omaggiare lo scrittore e politico
Maurice Barrès (1862-1923), autore del romanzo
“La collina ispirata”, ambientato proprio sul
colle di Sion. Sulla base della lanterna si
leggono iscrizioni che richiamano alcuni brani
del romanzo: “L’orizzonte che circonda questo
pianoro è quello che circonda tutta la vita; dà
un posto d’onore alla nostra sete d’infinito, e
allo stesso tempo ci ricorda i nostri limiti”.
Il panorama è fantastico, a quasi 360°; e il
silenzio assoluto, insieme a un vento piuttosto
forte, ha amplificato il nostro senso di totale
solitudine, portandoci quasi a un tuffo nello
spazio-tempo. Il nostro viaggio nella storia era
appena iniziato! Fu costruita
nel 1928 ad opera dell’architetto Achille
Duchêne per omaggiare lo scrittore e politico
Maurice Barrès (1862-1923), autore del romanzo
“La collina ispirata”, ambientato proprio sul
colle di Sion. Sulla base della lanterna si
leggono iscrizioni che richiamano alcuni brani
del romanzo: “L’orizzonte che circonda questo
pianoro è quello che circonda tutta la vita; dà
un posto d’onore alla nostra sete d’infinito, e
allo stesso tempo ci ricorda i nostri limiti”.
Il panorama è fantastico, a quasi 360°; e il
silenzio assoluto, insieme a un vento piuttosto
forte, ha amplificato il nostro senso di totale
solitudine, portandoci quasi a un tuffo nello
spazio-tempo. Il nostro viaggio nella storia era
appena iniziato!
Il pernottamento a Saint-Mihiel – in un curioso albergo ricavato da una vecchia stazione dismessa – ci ha consentito di iniziare un altro percorso storico, più recente. Dopo aver visitato la splendida chiesa di Saint-Michel, con la scultura lignea “La Pàmoison de la Vierge” (XVI sec.) di Ligier Richier, e aver camminato per le vie completamente deserte della cittadina, non riuscendo neppure a trovare un locale aperto per cenare, ci siamo imbattuti in un imponente monumento commemorativo dedicato “A nos morts, 1914-1918 / 1939-1945)”; e il giorno seguente, dopo pochi chilometri, eccoci alla “Nécropole nationale de Dieue”, un cimitero militare che conserva le spoglie di circa 300 soldati morti nella zona durante la Prima Guerra Mondiale. Croci bianche e perfino inquietanti sagome di
soldati a grandezza naturale tra le tombe ci
hanno introdotto alla successiva visita di una
città molto significativa: Verdun. Tutta la zona,
attraversata dalla Mosa, fiume a breve distanza
dalla linea del fronte, che si trovava più a est,
fu infatti teatro di una battaglia tra le più
importanti della Guerra ‘14-’18: i combattimenti
tra i francesi e i tedeschi ebbero qui inizio il
21 febbraio 1916 per concludersi dieci mesi dopo,
il 19 dicembre, con uno spaventoso bilancio di
morti, feriti e dispersi (circa un milione!).
Per ricordare e ripassare queste terribili
pagine di storia abbiamo visitato la Citadelle
Souterraine di Verdun, sull’Avenue du Soldat
Inconnu, un po’ fuori dal centro della città ma
raggiungibile agevolmente a piedi. Si tratta di
una lunga serie di gallerie scavate per circa 7
km, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del
XX, a scopo difensivo, essendo Verdun una città
fortificata di notevole importanza militare, una
piazzaforte considerata porta d’ingresso verso
Parigi. Le gallerie sono buie e davvero gelide
(la temperatura è inferiore a 10 °C, occorre
coprirsi bene anche in agosto!), e si percorrono
a bordo di una sorta di vagoncino automatico da
quattro posti, indossando una maschera-visore
per entrare nella realtà virtuale di un soldato
dell’epoca (Jean Rivière), insieme ai suoi
commilitoni. Si rivivono scene precedenti la
battaglia e poi i suoi momenti salienti. La
visita, piuttosto coinvolgente e impegnativa,
dura circa un’ora; l’ingresso è vietato ai
bambini minori di 8 anni. Croci bianche e perfino inquietanti sagome di
soldati a grandezza naturale tra le tombe ci
hanno introdotto alla successiva visita di una
città molto significativa: Verdun. Tutta la zona,
attraversata dalla Mosa, fiume a breve distanza
dalla linea del fronte, che si trovava più a est,
fu infatti teatro di una battaglia tra le più
importanti della Guerra ‘14-’18: i combattimenti
tra i francesi e i tedeschi ebbero qui inizio il
21 febbraio 1916 per concludersi dieci mesi dopo,
il 19 dicembre, con uno spaventoso bilancio di
morti, feriti e dispersi (circa un milione!).
Per ricordare e ripassare queste terribili
pagine di storia abbiamo visitato la Citadelle
Souterraine di Verdun, sull’Avenue du Soldat
Inconnu, un po’ fuori dal centro della città ma
raggiungibile agevolmente a piedi. Si tratta di
una lunga serie di gallerie scavate per circa 7
km, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del
XX, a scopo difensivo, essendo Verdun una città
fortificata di notevole importanza militare, una
piazzaforte considerata porta d’ingresso verso
Parigi. Le gallerie sono buie e davvero gelide
(la temperatura è inferiore a 10 °C, occorre
coprirsi bene anche in agosto!), e si percorrono
a bordo di una sorta di vagoncino automatico da
quattro posti, indossando una maschera-visore
per entrare nella realtà virtuale di un soldato
dell’epoca (Jean Rivière), insieme ai suoi
commilitoni. Si rivivono scene precedenti la
battaglia e poi i suoi momenti salienti. La
visita, piuttosto coinvolgente e impegnativa,
dura circa un’ora; l’ingresso è vietato ai
bambini minori di 8 anni. Nel bel centro storico
si può salire al Monument à la Victoire e aux
Soldats de Verdun, del 1929, e passare davanti
al bianco e massiccio Monument aux Morts et aux
Enfants (1928). Ma occorre spostarsi di qualche
chilometro dalla città per trovarsi davvero sul
campo di battaglia. Ci siamo recati all’Ossuaire
de Douaumont, luogo molto simbolico e commovente.
Progettato nel 1919, in stile art nouveau, in
cemento, e inaugurato nel 1932, raccoglie le
ossa di circa 130000 soldati senza nome
ritrovate nella zona alla fine della guerra. In
una galleria lunga 133 metri vi sono tombe
virtuali, mentre il vero ossario è sotterraneo:
crani, femori, vertebre, mandibole di coloro che
poco più di cent’anni fa erano ragazzi
giovanissimi, sani, protesi verso il futuro e
ricchi di speranza, maciullati invece
dall’insensatezza umana, si possono scorgere
ammassati attraverso i vetri di basse
finestrelle. Il sacrario ha la forma dell’elsa
di una spada interrata, ergendosi a metà della
galleria un’alta torre, una vera lanterna dei
morti, in cui si può salire per arrivare in cima.
E dall’alto il panorama è impressionante e
angoscioso: croci, croci e ancora croci, un
immenso cimitero, quindicimila croci bianche tra
l’erba verdissima. Douaumont fu completamente
distrutto e dichiarato “villaggio morto per la
Francia”, insieme ad altri cinque; il paesino di
Fleury-devant-Douaumont si può comunque “visitare”
camminando in un bosco, tra alberi, pietre e
lapidi che ricordano che in quel luogo vi era la
scuola, in un altro la chiesa, là il fornaio,
qui una fontana...Un vero parco della memoria,
per non dimenticare i suoi quattrocento abitanti,
che nel 1913 vi vivevano senza immaginare la
loro sorte. Nei pressi, sorge appunto il
Memoriale di Verdun, per chi volesse ancora
approfondire quanto accadde. Nel bel centro storico
si può salire al Monument à la Victoire e aux
Soldats de Verdun, del 1929, e passare davanti
al bianco e massiccio Monument aux Morts et aux
Enfants (1928). Ma occorre spostarsi di qualche
chilometro dalla città per trovarsi davvero sul
campo di battaglia. Ci siamo recati all’Ossuaire
de Douaumont, luogo molto simbolico e commovente.
Progettato nel 1919, in stile art nouveau, in
cemento, e inaugurato nel 1932, raccoglie le
ossa di circa 130000 soldati senza nome
ritrovate nella zona alla fine della guerra. In
una galleria lunga 133 metri vi sono tombe
virtuali, mentre il vero ossario è sotterraneo:
crani, femori, vertebre, mandibole di coloro che
poco più di cent’anni fa erano ragazzi
giovanissimi, sani, protesi verso il futuro e
ricchi di speranza, maciullati invece
dall’insensatezza umana, si possono scorgere
ammassati attraverso i vetri di basse
finestrelle. Il sacrario ha la forma dell’elsa
di una spada interrata, ergendosi a metà della
galleria un’alta torre, una vera lanterna dei
morti, in cui si può salire per arrivare in cima.
E dall’alto il panorama è impressionante e
angoscioso: croci, croci e ancora croci, un
immenso cimitero, quindicimila croci bianche tra
l’erba verdissima. Douaumont fu completamente
distrutto e dichiarato “villaggio morto per la
Francia”, insieme ad altri cinque; il paesino di
Fleury-devant-Douaumont si può comunque “visitare”
camminando in un bosco, tra alberi, pietre e
lapidi che ricordano che in quel luogo vi era la
scuola, in un altro la chiesa, là il fornaio,
qui una fontana...Un vero parco della memoria,
per non dimenticare i suoi quattrocento abitanti,
che nel 1913 vi vivevano senza immaginare la
loro sorte. Nei pressi, sorge appunto il
Memoriale di Verdun, per chi volesse ancora
approfondire quanto accadde.
Ci siamo dunque spostati più
a nord, nelle Ardenne, dove il pernottamento
nella bellissima Charleville-Mézières, fondata
all’inizio del ‘600 dal duca Carlo I di Gonzaga-Nevers,
che volle qui una Place Ducale davvero magnifica,
ci ha invece portato verso una parentesi più
letteraria che storica. È infatti la città che
ha dato i natali ad Arthur Rimbaud (1854-1891),
poeta straordinario, che appena sedicenne era in
grado di sconvolgere e sedurre con i suoi versi
gli intellettuali del tempo, tra cui Paul
Verlaine, di cui divenne amante (ma la relazione
fu burrascosa, tra ubriacature d’assenzio, colpi
di coltello e di pistola, risse furibonde). La tappa seguente,
Saint-Quentin, in Piccardia, si è rivelata
interessante soprattutto per la basilica
dedicata al santo stesso, martirizzato e
decapitato nei pressi, il cui cadavere, secondo
la leggenda, fu gettato nella Somme e poi
miracolosamente ritrovato. In parte ricostruita
dopo i danni della Prima Guerra Mondiale, la
basilica presenta una navata molto alta, belle
vetrate, un organo monumentale e un grande
labirinto bianco e nero sul pavimento, risalente
alla fine del ‘400.
Come in quasi tutta la Francia, il verde è curatissimo: si spende certo parecchio per la manutenzione di aiuole fiorite e decorazioni floreali, su ponti, lampioni, viali, praticamente ovunque. L’Italia, a parte qualche rara eccezione, è purtroppo lontana mille miglia da questa linea di pensiero, che è invece indice di grande civiltà e senso estetico per il paesaggio urbano. Chapeau per i sindaci francesi e per i loro cittadini! Tra gli alberi del Boulevard
Jules Verne, ecco un bel monumento in marmo,
scolpito da Albert Roze nel 1909 su commissione
dell’Accademia di Scienze e Lettere, dedicato al
geniale scrittore, che ne era membro: infatti ad
Amiens visse per più di trent’anni e vi morì.
Lasciata Amiens, dopo una sosta ad Abbeville, dove si può visitare la bella Collegiata di Saint-Vulfran, eccoci a Le Tréport: finalmente sul mare, o meglio sull’oceano, in Alta Normandia. [Hotel, prenotati tramite Booking: a Montbéliard: Kyriad Montbéliard Sochaux, 34 Avenue du Marechal Joffre a Saint-Mihiel: Hotel de la Gare, Place de la Gare a Charleville-Mézières: Cesar Hotel, 23 Avenue du Marechal Leclerc ad Amiens: Ibis Budget Amiens Centre Gare, 15 Rue Dejean] 15 settembre 2023, Anna Busca UN VIAGGIO NELLA STORIA (seconda parte: da Le Tréport a Cherbourg) Le coste dell’Alta Normandia, che si affacciano sulla Manica, sono una lunga sequenza di bianche falesie calcaree, simili a quelle più famose di Dover dalla parte inglese. Soggette alla continua erosione da parte delle onde - alzate dal vento che spesso soffia con una certa intensità – sono interrotte da spiagge di ciottoli, interessate per larghi tratti dalle maree, che qui presentano una notevole ampiezza. Le Tréport, che per noi ha costituito l’ingresso “ufficiale” nella regione, presenta tutte le caratteristiche di un borgo marino normanno: e per questo attrae molti turisti. Trovare il parcheggio non è stato
facile; ci siamo poi ritrovati a camminare tra
una fastidiosa folla vociante, spesso intenta a
scegliere souvenirs o pesce fresco da numerose
bancarelle. Nella parte più antica, che si
raggiunge salendo una scalinata, si può visitare
la chiesa di Saint-Jacques, al cui interno si
ritrovano simboli marinari, reti da pesca,
modellini di navi appese, ex voto di chi scampò
a un naufragio: il paese, prima di diventare
centro turistico, era un semplice villaggio di
pescatori. Ci siamo poi messi in coda per
prendere una funicolare
–
inaugurata nei primi anni del
‘900
e rimodernata - a ingresso gratuito, che in poco
più di un minuto porta in alto, sulla falesia,
sopra l’abitato. Molto bella la vista delle
case, del porticciolo e delle acque di color
verde-azzurro, tra grida di gabbiani, che ci
accompagneranno per tutto il nostro giro della
Normandia. Si può camminare lungo un sentiero e
ammirare un panorama davvero grandioso. Le
falesie appaiono imponenti a una trentina di
chilometri più a ovest, a Dieppe, dominata da un
castello-museo, con una spiaggia molto ampia e
un grande porto. Numerose le case storiche a
graticcio. Da visitare la chiesa gotica di (ancora!)
Saint-Jacques. La dedica a questo santo è
ricorrente sulle coste normanne: forse la
devozione a san Giacomo è legata al fatto che
sulle spiagge si trova spesso la famosa
conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a
Santiago di Compostela, che non è altro che il
guscio del mollusco bivalve
Pecten jacobaeus, o
capasanta. Trovare il parcheggio non è stato
facile; ci siamo poi ritrovati a camminare tra
una fastidiosa folla vociante, spesso intenta a
scegliere souvenirs o pesce fresco da numerose
bancarelle. Nella parte più antica, che si
raggiunge salendo una scalinata, si può visitare
la chiesa di Saint-Jacques, al cui interno si
ritrovano simboli marinari, reti da pesca,
modellini di navi appese, ex voto di chi scampò
a un naufragio: il paese, prima di diventare
centro turistico, era un semplice villaggio di
pescatori. Ci siamo poi messi in coda per
prendere una funicolare
–
inaugurata nei primi anni del
‘900
e rimodernata - a ingresso gratuito, che in poco
più di un minuto porta in alto, sulla falesia,
sopra l’abitato. Molto bella la vista delle
case, del porticciolo e delle acque di color
verde-azzurro, tra grida di gabbiani, che ci
accompagneranno per tutto il nostro giro della
Normandia. Si può camminare lungo un sentiero e
ammirare un panorama davvero grandioso. Le
falesie appaiono imponenti a una trentina di
chilometri più a ovest, a Dieppe, dominata da un
castello-museo, con una spiaggia molto ampia e
un grande porto. Numerose le case storiche a
graticcio. Da visitare la chiesa gotica di (ancora!)
Saint-Jacques. La dedica a questo santo è
ricorrente sulle coste normanne: forse la
devozione a san Giacomo è legata al fatto che
sulle spiagge si trova spesso la famosa
conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a
Santiago di Compostela, che non è altro che il
guscio del mollusco bivalve
Pecten jacobaeus, o
capasanta.
Le falesie diventano sempre
più scenografiche, lungo la Costa d’Alabastro.
Tappa d’obbligo, sulla bellissima strada,
Fécamp: qui abbiamo voluto acquistare un famoso
prodotto del luogo, il Bénédectine, un liquore
d’erbe considerato una sorta di elisir
medicinale, dalla formula misteriosa, prodotto
fin dal XVI secolo dai monaci dell’Abbazia della
Santissima Trinità e poi rielaborato e
commerciato tre secoli dopo. Si tratta in realtà
solo di un amaro dal gusto piacevolmente
aromatico...
Passeggiando, abbiamo scoperto resti delle mura di un castello, davanti alle quali un cartellone informativo recita: “ 1066-2016, 950° anniversario della battaglia di Hastings: qui, Guglielmo il Conquistatore, ancora bambino, fu presentato come erede del duca di Normandia”. E leggiamo ancora: “Il 13 gennaio 1035, una grande assemblea riunì a Fécamp l’arcivescovo di Rouen, i vescovi e i signori. Il duca di Normandia, Roberto I detto il Magnifico, fece riconoscere da tutti suo figlio Guglielmo, di 7 anni, come erede”. Tale evento è importante: può essere considerato il primo capitolo di una lunga storia che portò Guglielmo (1027-1087), trentun anni dopo, a combattere vittoriosamente, dopo la morte del re inglese Edoardo il Confessore, la famosa battaglia. Sconfisse Aroldo, un aristocratico pretendente al trono, e divenne quindi re d’Inghilterra. Scopriremo poi che il tutto è mirabilmente rappresentato nello straordinario “arazzo di Bayeux” (vedi in seguito). Un borgo romantico,
immortalato da Monet, e anche da Boudin,
Delacroix e Courbet, è Étretat, a circa 16 km da
Fécamp: qui le falesie mostrano forme
particolari dovute all’erosione. La tappa successiva non
poteva che essere Le Havre, Patrimonio Mondiale
UNESCO dal 2005, sull’estuario della Senna.
Bombardata più volte e completamente distrutta,
nella Seconda Guerra Mondiale, da un attacco
aereo alleato del settembre 1944 nel quale
perirono 3000 civili, fu ricostruita secondo il
progetto particolare dell’architetto modernista
Auguste Perret tra il 1946 e il 1964. La pianta
si basa su vie ortogonali tra loro, i palazzi
sono prevalentemente parallelepipedi uniformi,
della stessa altezza. L’atmosfera complessiva è
gradevole. Ci è piaciuta molto la chiesa di
Saint-Joseph, la cui altezza (107 m) domina il
centro della città: l’interno è illuminato da
migliaia di vetri colorati attraverso i quali
filtra la luce. La grande spiaggia è invece un
po’ triste: pullula di cabine abbastanza
squallide, in un certo disordine, tra sassi ed
erbacce, e si affaccia su un porto pieno di
navi, container e gru (è il secondo porto di
Francia dopo Marsiglia). L’acqua è torbida e
poco attraente. Nei pressi si incontra un
edificio grigio all’apparenza insignificante: è
invece il Museo d’Arte Moderna André Malraux
(MUMA di Le Havre), la cui visita è imperdibile,
perché ospita una straordinaria raccolta di
opere di Eugène Boudin insieme a molte altre dei
maggiori impressionisti francesi. Ad Albert
Marquet è stata dedicata una mostra temporanea,
“Marquet in Normandia” (fino al 24 settembre
2023). Il pittore scoprì la regione nel 1903 e
ne fece subito un campo di sperimentazione delle
sue ricerche pittoriche, ispirate al fauvismo:
splendidi i quadri esposti. Abbiamo pernottato all’interno, a Épaignes, nella deliziosa campagna normanna, non trovando camere libere sulla costa che non fossero a prezzi proibitivi. Per superare la Senna da Le Havre siamo passati sul Pont de Tancarville, un po’ somigliante al Golden Gate. Avremmo preferito in realtà scavalcare l’estuario sul famoso Pont de Normandie, il più grande ponte sospeso d’Europa, molto scenografico, ma seguendo il navigatore abbiamo percorso una strada sbagliata, arrivando all’imbarco di un piccolo traghetto, che abbiamo evitato. Pazienza! Abbiamo poi ammirato il Pont de Normandie da lontano. Nella graziosa Cormeilles abbiamo cenato in uno dei migliori ristoranti di tutto il viaggio, gustando piatti tipici della cucina locale e formaggi davvero squisiti, in particolare il Camembert, accompagnati da un buon bicchiere di sidro (Le Florida, 21 Rue de l’Abbaye). Il giorno seguente abbiamo
iniziato l’esplorazione della Bassa Normandia,
dal paesaggio molto diverso. Le spiagge sono
sabbiose, pulite, facilmente balneabili e spesso
attrezzate; molte facciate nei centri storici
sono a graticcio, perfettamente ristrutturate;
si respira un’aria piacevole, anche se più
turistica. La nostra prima visita, sulla Côte de
Grâce, ha riguardato Honfleur, considerato uno
dei luoghi più belli della Normandia. Purtroppo, per ragioni legate all’impossibilità di trovare parcheggio visto l’afflusso di turisti – complice una giornata di sole e cielo azzurrissimo – siamo stati costretti ad attraversare velocemente Deauville e Trouville, sulla Côte Fleurie, senza praticamente poterci fermare. Ne abbiamo tratto solo la fugace impressione di cittadine balneari eleganti e ben frequentate. Siamo dunque giunti a Caen, dove abbiamo pernottato. Ne abbiamo un po’ trascurato il centro storico, perché la nostra meta era il Memoriale, che abbiamo raggiunto all’apertura, il mattino seguente, per evitare lunghe code. Si trova nella periferia nord la “Cité de l’histoire pour la paix” (www.memorial-caen-fr), inaugurata dal presidente François Mitterrand nel giugno 1988, circondata da vasti prati e aiuole (i “giardini del ricordo”) con lapidi commemorative qua e là. È un edificio di notevoli dimensioni, su tre livelli. Arrivando
sull’Esplanade Général Eisenhower, davanti
all’ingresso, ecco numerose bandiere sventolanti
e un monumento molto significativo: la pistola
con la canna annodata, opera dell’artista
svedese Carl Fredrik Reuterswärd, bronzo
presente in tutto il mondo in una trentina di
copie, come simbolo universale della non
violenza (lo scultore ebbe l’idea del monumento
dopo l’assassinio di John Lennon, alla fine del
1980). Anche la grande scritta sulla facciata ci
accoglie, come simbolo di pace: “Il dolore mi ha
sbriciolato, la fraternità mi ha sollevato,
dalla mia ferita è sgorgato un fiume di
libertà”. La frase
–
riferita alla Normandia - è rimasta a lungo
anonima, ma pare che sia da attribuire a un
poeta di Caen, tale Paul Dorey, amico
dell’architetto progettista del Memoriale,
Jacques Millet. Entrando, il nostro viaggio nel
tempo diventa realtà: e dunque riprendiamo il
“cammino” iniziato a Verdun, questa volta
affrontando la Seconda Guerra Mondiale. La
visita dura circa tre ore ed è
interessantissima: si parte da “1918-1939, da
una guerra all’altra: il disastro”, per passare
alla “Francia degli anni bui”, alla “Guerra
totale”. Fotografie, documenti, reperti,
ricostruzioni e filmati si susseguono.
All’Italia fascista e al suo ruolo nel conflitto
è dedicato poco spazio: a parte qualche immagine
di Mussolini con Hitler, e poche testimonianze
sulla guerra d’Africa, non c’è molto altro. Una
copia di “Se questo è un uomo” di Primo Levi è
esposta in una bacheca, come testo tra i più
importanti di denuncia dell’Olocausto. Arrivando
sull’Esplanade Général Eisenhower, davanti
all’ingresso, ecco numerose bandiere sventolanti
e un monumento molto significativo: la pistola
con la canna annodata, opera dell’artista
svedese Carl Fredrik Reuterswärd, bronzo
presente in tutto il mondo in una trentina di
copie, come simbolo universale della non
violenza (lo scultore ebbe l’idea del monumento
dopo l’assassinio di John Lennon, alla fine del
1980). Anche la grande scritta sulla facciata ci
accoglie, come simbolo di pace: “Il dolore mi ha
sbriciolato, la fraternità mi ha sollevato,
dalla mia ferita è sgorgato un fiume di
libertà”. La frase
–
riferita alla Normandia - è rimasta a lungo
anonima, ma pare che sia da attribuire a un
poeta di Caen, tale Paul Dorey, amico
dell’architetto progettista del Memoriale,
Jacques Millet. Entrando, il nostro viaggio nel
tempo diventa realtà: e dunque riprendiamo il
“cammino” iniziato a Verdun, questa volta
affrontando la Seconda Guerra Mondiale. La
visita dura circa tre ore ed è
interessantissima: si parte da “1918-1939, da
una guerra all’altra: il disastro”, per passare
alla “Francia degli anni bui”, alla “Guerra
totale”. Fotografie, documenti, reperti,
ricostruzioni e filmati si susseguono.
All’Italia fascista e al suo ruolo nel conflitto
è dedicato poco spazio: a parte qualche immagine
di Mussolini con Hitler, e poche testimonianze
sulla guerra d’Africa, non c’è molto altro. Una
copia di “Se questo è un uomo” di Primo Levi è
esposta in una bacheca, come testo tra i più
importanti di denuncia dell’Olocausto.
 Tra i
reperti più interessanti, ecco un esemplare
della famosa macchina “Enigma M4”, a quattro
rotori, usata dai nazisti dal febbraio 1942 per
comporre e decrittare testi cifrati che venivano
trasmessi tra i sottomarini e i centri di
comando. Ma è lo sbarco degli alleati in
Normandia, il 6 giugno 1944, a dominare la
scena: al D-day (che i francesi chiamano “Jour
J”; noi dovremmo chiamarlo “Giorno G”!) è
dedicata un’ampia sala; si passa poi in un
cinema dove si proietta, ogni 30 minuti, il film
“Le Jour J et la Bataille de Normandie”. Un
settore del memoriale è dedicato alla “Guerra
fredda”; e si può concludere con un film
“immersivo”, a 360°, che riassume la storia
d’Europa dal 1914 al 1991. All’uscita, si ha
l’impressione di essere entrati fisicamente
nelle pagine di un libro di storia! Tra i
reperti più interessanti, ecco un esemplare
della famosa macchina “Enigma M4”, a quattro
rotori, usata dai nazisti dal febbraio 1942 per
comporre e decrittare testi cifrati che venivano
trasmessi tra i sottomarini e i centri di
comando. Ma è lo sbarco degli alleati in
Normandia, il 6 giugno 1944, a dominare la
scena: al D-day (che i francesi chiamano “Jour
J”; noi dovremmo chiamarlo “Giorno G”!) è
dedicata un’ampia sala; si passa poi in un
cinema dove si proietta, ogni 30 minuti, il film
“Le Jour J et la Bataille de Normandie”. Un
settore del memoriale è dedicato alla “Guerra
fredda”; e si può concludere con un film
“immersivo”, a 360°, che riassume la storia
d’Europa dal 1914 al 1991. All’uscita, si ha
l’impressione di essere entrati fisicamente
nelle pagine di un libro di storia!
Da Caen ci siamo spostati, in neppure mezz’ora di strada, a Courseulles-sur-Mer, la cui spiaggia è “Juno Beach”, una delle cinque utilizzate per lo sbarco; qui approdarono le truppe canadesi, che due anni prima, il 19 agosto 1942, avevano subìto forti perdite dopo un tentativo fallito d’invasione a Dieppe. Il nome in codice “Juno” fu scelto in quanto corrispondeva a quello della moglie di un tenente colonnello, un certo Dawnay (inizialmente doveva essere “Jelly”, medusa, ma evidentemente non piacque). La bandiera canadese sventola accanto a quella francese; nei pressi di un molo è stata eretta un’alta croce, e vi è anche un piccolo centro di visita, dall’architettura interessante. Ben 381 soldati canadesi perirono nel D-day; 5500 nella Battaglia di Normandia, 45000 complessivamente nella II Guerra Mondiale. Si può percorrere un sentiero commemorativo, con cartelloni esplicativi, lapidi, resti di bunker, a ridosso della bella spiaggia, che presenta dune e vegetazione sparsa. Juno Beach è in mezzo a “Sword” e “Gold”, le spiagge dello sbarco britannico, dal nome di pesci (pesce spada e pesce rosso!), che però non abbiamo visitato. La tappa a Bayeux, distante circa 20 km, ci ha permesso un’altra esplorazione storica, davvero eccezionale: mi riferisco al già citato arazzo (vedi più sopra, Fécamp), detto “Arazzo della regina Matilde”, costituito da nove pezze unite e lungo complessivamente circa 70 metri, tessuto nel 1077 da artisti ignoti (in realtà si tratta di un incredibile ricamo di fili di lana verde scuro, bordeaux, grigio, giallo oro e nero, su tela di lino). Non si sa neppure se chi l’ha ricamato fosse inglese o normanno: di certo vuole essere una sorta di documento a testimonianza della validità del dominio normanno in Inghilterra. Viene conservato nel museo della Tapisserie de Bayeux (13B Rue de Nesmond), perfettamente illuminato, sotto la copertura di un vetro protettivo. I visitatori vi camminano lentamente davanti, affascinati, fianco a fianco, in una specie di buia galleria. È un grandioso poema epico, una sorta di straordinario “fumetto” dell’XI secolo, che racconta le vicende di Aroldo e di Guglielmo il Conquistatore, legate alla successione al trono di Edoardo e alla conquista dell’Inghilterra da parte del duca di Normandia. Le scritte sono in latino medioevale; ma la visita si svolge con l’ausilio di un apparecchio audio multilingue (anche in italiano) che illustra via via le scene, quindi ci si può immergere con stupore e ammirazione nella storia narrata. La battaglia di Hastings del 1066 è riportata con crudo realismo: i cavalli, spesso imbizzarriti o feriti a morte, si mescolano ai cavalieri che combattono con spade, mazze e frecce. Manca una pezza finale, andata perduta, che probabilmente rappresentava l’incoronazione di Guglielmo. L’UNESCO ha inserito l’arazzo nel Registro della Memoria del Mondo: è in effetti un “memoriale” di mille anni fa! Bayeux è una delle città meglio conservate, poco danneggiata dai bombardamenti: presenta antiche case a graticcio e una stupenda cattedrale, quella di Notre Dame, in stile gotico-normanno, che fu consacrata proprio nel 1077 in presenza di Guglielmo; qui fu conservato per secoli il meraviglioso arazzo, che veniva periodicamente esposto. Ci siamo dunque spostati
nuovamente sulla costa per andare su un’altra
“spiaggia dello sbarco”: Omaha Beach,
catapultandoci ancora nel cuore tragico del XX
secolo.
Il nostro viaggio nella
storia è proseguito quindi lungo la penisola del
Cotentin, fino a Cherbourg, che si trova in
prossimità della punta. Non è una città che ci
abbia particolarmente colpito: ha un porto
interessante, sul quale si trovano concentrati
locali e ristoranti (in particolare davanti
all’”avant port”, intorno al Quai de Caligny) ma
non abbiamo notato monumenti di particolare
rilievo. Abbiamo trascurato la visita alla Cité
de la Mer (molto gettonata dai francesi) e al
Musée de la Liberation, che forse avremmo
considerato se avessimo avuto più tempo. Una
nota curiosa: qui fu girato un film musicale,
“Les parapluies de Cherbourg” (1963) con
Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo.
[Hotel, prenotati tramite Booking: a Dieppe, Brit Hotel Dieppe, 3 Rue Jacques Monod a Fécamp, Hotel Ibis Budget Fécamp, Boulevard Suzanne Clément a Épaignes, Hotel Le Tosny, 1 Route des Anglais Caen, Hotel Crocus Caen Memorial, 2 Rue de la Folie, Point du Débarquement a Cherbourg, Brit Hotel Cherbourg, 12 Rue Joliot Curie] 15 settembre 2023, Anna Busca UN VIAGGIO NELLA STORIA (terza parte: da Cherbourg a Metz) Lasciata Cherbourg, scendendo lungo la costa occidentale della penisola del Cotentin, abbiamo sostato a Carteret, per vedere se era possibile un’escursione giornaliera all’isola di Jersey, a un’ora di traghetto. Il luogo era piuttosto desolato: e alla stazione marittima, piuttosto squallida e assolutamente deserta, ci è stato detto dall’unica impiegata che i collegamenti settimanali erano solo tre e avremmo dovuto aspettare quattro giorni per imbarcarci... Evidentemente l’isola, noto paradiso fiscale britannico, non è un grande richiamo turistico per i francesi! Abbiamo quindi cambiato programma, riprendendo la nostra discesa della penisola e fermandoci a Coutances, un po’ all’interno. Un’altra splendida cattedrale (XIII-XIV sec.), con un organo maestoso, meritava senz’altro la nostra visita.
Riprendendo la strada verso
est, abbiamo deciso di dare un’occhiata a
Lisieux, considerato il secondo centro del
dipartimento del Calvados per ordine
d’importanza, dopo Caen. In realtà finisce per
essere una specie di Lourdes della Normandia:
nel 1937 fu qui inaugurata, da colui che sarebbe
stato poi papa Pio XII, un’enorme basilica in
stile neoromanico-neobizantino, meta di
pellegrinaggi.
Dopo circa un centinaio di km
in autostrada, abbiamo raggiunto Rouen, città
splendida, considerata a ragione la capitale
della Normandia, attraversata dalla Senna. Già
alla sera, cercando un locale per cenare,
abbiamo potuto fare un bel giro a piedi del
centro storico, assistendo a uno spettacolo
“suoni e luci” sulla facciata della magnifica
cattedrale di Notre Dame, di cui Monet fece ben
trentun dipinti considerati suoi capolavori. Ma
è il giorno seguente che siamo riusciti a
compiere un’interessantissima visita della
città. Dopo una bella passeggiata sul
LungoSenna, attraversando il ponte Boieldieu,
abbiamo trovato, sulla riva destra, una lapide:
“Nei pressi di questo luogo, il mercoledì 30
maggio 1431, dopo il supplizio del Mercato
Vecchio, le ceneri di Giovanna d’Arco furono
gettate nella Senna dall’alto dell’antico ponte
Matilde”. Eccoci dunque di nuovo a incontrare
l’eroina di Francia, che avevamo incrociato a
Vaucouleurs, quasi all’inizio del nostro
viaggio. Siamo infatti nella città che la vide
bruciare sul rogo, appena diciannovenne, a
seguito di un processo per eresia tenuto
dall’Inquisizione iniziato nel gennaio 1431;
Jeanne d’Arc era stata catturata sette mesi
prima a Compiègne, da Jean de Luxembourg, che
poi l’aveva venduta agli inglesi in cambio di un
ingente riscatto.
Dopo la visita della
cattedrale di Notre-Dame,
Da Rouen ci siamo poi diretti
verso est: prima tappa, Beauvais. La nostra meta
era, naturalmente, la sua cattedrale gotica,
dedicata a San Pietro: vanta il coro gotico più
alto della Piccardia, di 47 m., superando quello
di 42,5 m di Amiens e di 34 m di Saint-Quentin.
Costruita a partire dal 1225, rimase però
incompiuta: ha problemi di staticità, visto che
ha subìto nel corso dei secoli alcuni crolli,
forse in parte dovuti al terreno instabile su
cui poggiano le fondamenta. Richiede frequenti
interventi di ristrutturazione e consolidamento.
Per quanto delicata, è una costruzione maestosa.
All’interno, le colonne sono sorrette da travi
orizzontali di sostegno. Si può ammirare un
grande orologio astronomico. In una vasta piazza contornata da edifici storici si può ammirare il monumento dedicato a un’altra Jeanne: si tratta di Jeanne Hachette (ma il suo vero cognome era Fourquet o Laisné), eroina che, armata di accetta (“hachette”) uccise un soldato nemico che stava per scalare le mura della città, durante l’assedio del giugno 1472 da parte delle truppe del duca di Borgogna. Il gesto diede forza alla popolazione, che resistette all’assedio finché, un mese dopo, il duca si ritirò. Evidentemente il nome “Jeanne” era portato, all’epoca, da donne aventi un coraggio non comune! L’ultima visita di Beauvais ha riguardato l’ex Palazzo Vescovile, diventato il Museo dell’Oise; ospita alcuni dipinti e oggetti. Abbiamo pernottato a Compiègne, in un albergo sul fiume Aisne, che qui si unisce all’Oise (per poi diventare affluente della Senna). La città, di circa 40.000 abitanti, ha una storia lunga e complessa: antico nucleo gallo-romano, in una zona strategica, luogo di contese e battaglie, ha vissuto episodi come la cattura di Jeanne d’Arc il 23 maggio 1430 e l’incontro tra Luigi XVI e l’austriaca Maria Antonietta nel maggio 1770, pochi giorni prima delle loro nozze, decise per ragioni di alleanza; qui, nel meraviglioso castello, trascorsero molti mesi sia Napoleone che Napoleone III; e, per venire a tempi più recenti, Compiègne è stata sede di due importantissimi armistizi, nel 1918 e nel 1940.
Il parco, con prati immensi, aiuole fiorite, statue, alberi secolari, è bellissimo ed estremamente curato, quasi in continuità con la foresta circostante, che abbiamo poi raggiunto – in auto, con un tragitto di pochi minuti – per visitare i luoghi degli armistizi già citati, piuttosto isolati. Si arriva a un parcheggio da cui si raggiunge, nel fitto bosco, la Clairière, ossia la radura dove si trovava il famoso vagone ferroviario che ospitò i firmatari dell’armistizio dell’11 novembre 1918 tra Francia (e i suoi alleati) e la Germania; e il 22 giugno 1940 Hitler volle, per rivalsa, che si firmasse l’armistizio tra Francia e terzo Reich nello stesso luogo, e nello stesso vagone (che fu fatto uscire dal Memoriale in cui si trovava e riportato qui per lo scopo). Una roccia piatta con le scritte incise “Le Maréchal Foch” e “Les plénipotentiares allemands” segna in mezzo all’erba, tra i resti delle rotaie, la posizione originaria del vagone. Nei pressi, la statua del
maresciallo Foch, comandante in capo delle
truppe francesi, e quella commemorativa dei
caduti della I Guerra Mondiale. Si entra quindi
nel piccolo Musée Mémorial de l’Armistice, che
presenta, in 500 m2 di esposizione, immagini,
reperti e brevi video che spiegano molto bene
tutta la vicenda. Il vagone
–
qui vi è una sua copia esatta, ricostruita con
precisione–
era originariamente una carrozza ristorante che
apparteneva a treni che collegavano la stazione
di Montparnasse, a Parigi, con la Bretagna; fu
fatta produrre nel 1913 dalla Compagnia
internazionale dei vagoni-letto. La scelta della
radura di Compiègne per l’armistizio del 1918 fu
voluta dal maresciallo Foch per evitare la
presenza di politici, giornalisti e curiosi; al
contempo, era meglio che la delegazione tedesca
restasse riparata in un luogo isolato, in modo
che non fosse attaccata da manifestazioni
pubbliche. Non essendosi edifici, fu utilizzato
il vagone che vi era stato portato, allestito
opportunamente come un ufficio, con un tavolo e
otto sedie per i membri della delegazione. Nei pressi, la statua del
maresciallo Foch, comandante in capo delle
truppe francesi, e quella commemorativa dei
caduti della I Guerra Mondiale. Si entra quindi
nel piccolo Musée Mémorial de l’Armistice, che
presenta, in 500 m2 di esposizione, immagini,
reperti e brevi video che spiegano molto bene
tutta la vicenda. Il vagone
–
qui vi è una sua copia esatta, ricostruita con
precisione–
era originariamente una carrozza ristorante che
apparteneva a treni che collegavano la stazione
di Montparnasse, a Parigi, con la Bretagna; fu
fatta produrre nel 1913 dalla Compagnia
internazionale dei vagoni-letto. La scelta della
radura di Compiègne per l’armistizio del 1918 fu
voluta dal maresciallo Foch per evitare la
presenza di politici, giornalisti e curiosi; al
contempo, era meglio che la delegazione tedesca
restasse riparata in un luogo isolato, in modo
che non fosse attaccata da manifestazioni
pubbliche. Non essendosi edifici, fu utilizzato
il vagone che vi era stato portato, allestito
opportunamente come un ufficio, con un tavolo e
otto sedie per i membri della delegazione. L’armistizio segnava di fatto la fine della
guerra, anche se il trattato di pace fu firmato
solo l’anno successivo, a Versailles. Foch fu
lungimirante, perché affermò che, viste le
pesanti condizioni imposte alla Germania, non si
trattava di una vera pace, ma solo di una
tregua. Ventidue anni dopo, Hitler, il 21 giugno
1940, entrando nel vagone, prese il posto di
Foch: cancellava così, simbolicamente, la
sconfitta precedente, e occupava la posizione
del vincitore. L’armistizio era stato chiesto
dal generale francese Philippe Pétain
–
responsabile del fronte francese nella battaglia
di Verdun del 1916 - che divenne poi capo del
governo collaborazionista di Vichy, dal 1940
fino al 1944 (fu poi processato nel 1945 per
alto tradimento ed ebbe la condanna a morte
commutata nel carcere a vita). Hitler non
pronunciò parola; il generale Keitel lesse il
programma della convenzione per l’armistizio, e
dopo la lettura il Führer lasciò il vagone. Non
assistette quindi ai negoziati, che furono
siglati il giorno seguente. La carrozza fu
portata poi a Berlino; la sua distruzione
avvenne in circostanze oscure, in Turingia, non
si sa se nel corso di bombardamenti alleati o
perché fatta saltare dai nazisti, nel 1945. L’armistizio segnava di fatto la fine della
guerra, anche se il trattato di pace fu firmato
solo l’anno successivo, a Versailles. Foch fu
lungimirante, perché affermò che, viste le
pesanti condizioni imposte alla Germania, non si
trattava di una vera pace, ma solo di una
tregua. Ventidue anni dopo, Hitler, il 21 giugno
1940, entrando nel vagone, prese il posto di
Foch: cancellava così, simbolicamente, la
sconfitta precedente, e occupava la posizione
del vincitore. L’armistizio era stato chiesto
dal generale francese Philippe Pétain
–
responsabile del fronte francese nella battaglia
di Verdun del 1916 - che divenne poi capo del
governo collaborazionista di Vichy, dal 1940
fino al 1944 (fu poi processato nel 1945 per
alto tradimento ed ebbe la condanna a morte
commutata nel carcere a vita). Hitler non
pronunciò parola; il generale Keitel lesse il
programma della convenzione per l’armistizio, e
dopo la lettura il Führer lasciò il vagone. Non
assistette quindi ai negoziati, che furono
siglati il giorno seguente. La carrozza fu
portata poi a Berlino; la sua distruzione
avvenne in circostanze oscure, in Turingia, non
si sa se nel corso di bombardamenti alleati o
perché fatta saltare dai nazisti, nel 1945.
Ripresa la strada, ormai
lungo la via del ritorno, non potevamo non far
sosta a Metz (pronuncia francese: Mess). Il
nostro hotel era affacciato sulla stazione
ferroviaria, la Gare de Metz-Ville, considerata
monumento storico e più volte eletta come
stazione più bella di Francia.
Prima di ripartire abbiamo
dedicato due ore a un museo straordinario: il
Cèntre Pompidou-Metz, del 2010,
architettonicamente molto singolare, in quanto
chi lo progettò, ossia il giapponese Shigenu Ban
insieme al francese Jean de Gastines, immaginò
una copertura simile a un bianco copricapo
cinese.  Splendida la galleria di
ritratti, tra cui spicca quello del giovane Erik
Satie- già “incontrato” a Honfleur! - con cui
ebbe una relazione di alcuni mesi, dal 1893.
L’anno seguente, la Valadon fu la prima donna ad
essere ammessa nella Société Nationale des Beaux
Arts. Speriamo che la mostra venga portata
presto a Milano! Avrebbe un successo strepitoso
e meritatissimo. Splendida la galleria di
ritratti, tra cui spicca quello del giovane Erik
Satie- già “incontrato” a Honfleur! - con cui
ebbe una relazione di alcuni mesi, dal 1893.
L’anno seguente, la Valadon fu la prima donna ad
essere ammessa nella Société Nationale des Beaux
Arts. Speriamo che la mostra venga portata
presto a Milano! Avrebbe un successo strepitoso
e meritatissimo.
Ripresa quindi la strada
verso est, ci siamo fermati a Saint-Avold per
fare rifornimento, scoprendo casualmente che qui
si trova il più grande cimitero militare
americano d’Europa. Visitarlo ci è parso
d’obbligo, per chiudere, in un certo senso, un
altro percorso ad anello, a conclusione del
nostro viaggio nella storia. Ed eccoci quindi,
unici visitatori, in un parco-camposanto
dall’erba perfettamente rasata, gelidamente
silenzioso e angosciante. Davanti a quasi 11000
croci bianche sventola alta la bandiera a stelle
e strisce. In un edificio presso l’entrata
alcune lapidi ricordano gli sbarchi del 6 giugno
1944 e le operazioni belliche che ne seguirono,
in Europa occidentale, fino all’8 maggio 1945,
giorno in cui fu firmato l’atto di resa della
Germania.
[Hotel, prenotati tramite Booking: a Rouen, Ibis Rouen Centre Rive Gauche Mermoz, 13 Rue de la Motte a Compiègne, Hotel de Flandre, 16 Quai de la République a Metz, Campanile Metz-Centre Gare, 30 Rue aux Arènes a Mulhouse, Hotel Le Strasbourg, 17 Avenue de Colmar 15 Settembre 2023, Anna Busca AGOSTO 2023 L'Irlanda del sud in (soli) 8 giorni Questa volta ho voluto provare il brivido del viaggio organizzato in Europa. Finora ho viaggiato in questa maniera solo in paesi esotici; in Europa sempre in modo autonomo, a parte alcune crociere fluviali. Quando vedevo i pullman scaricar frotte di pensionati, pensavo che non avrei mai viaggiato a quel modo. E invece adesso, con un po' di capelli bianchi in testa e qualche giuntura dolorante, penso che dopotutto la cosa ha i suoi vantaggi, specie sotto ferragosto: niente stress a cercar alberghi, a cercar un buco per parcheggiare (e trovarlo se va bene lontano chilometri), a far code alle biglietterie, a guidare la sera dopo giornate faticose, eccetera. Qui poi bisogna aggiungere la guida a sinistra: l'ho già sperimentata in Scozia, ma allora eravamo in tre a darci il cambio al volante ed erano giusto quei trent'anni fa. Gli svantaggi sono che devi accettare una disciplina necessaria a convivere con altri, ed un itinerario che non sempre passa dove vorresti tu. E poi c'è la durata. A voler vedere tutta l'Irlanda ci va un mese. Con una sola settimana i tagli sono inevitabili; ed i tagli sono soggettivi. A me ad esempio piacciono di più città, paesini e paesaggi di campagna; meno quelli marini e le scogliere, che invece sono generalmente più gettonati. Pur accettando il pacchetto, è stato un peccato aver escluso Cork e Limerick. I villaggi rifatti di Bunratty Folk Park e Kerry Bog per contro si sono rivelati interessanti sì, ma un po' “disneyani” perché sono ricostruiti, pur se con pezzi originali. Per fortuna non sono arrivati a farvi circolare gente in costume d'epoca come visto in villaggi del genere negli USA. Una scoperta inaspettata, fatta sul posto, è che si poteva visitare anche l'Irlanda del nord: avevamo escluso i viaggi combinati Eire + Ulster per i tempi biblici di rinnovo del passaporto. Invece il problema c'è solo se si arriva nel nord con un volo diretto, o dall'Inghilterra. Dall'Eire invece non ci sono controlli di frontiera. Oggi la convivenza fra le due componenti cattolico-indipendentista e protestante-filobritannica non è più così problematica come anni fa, ma la situazione non è risolta e nel nord ancora se le danno. Nel sud i protestanti sono pochi e la situazione in genere è tranquilla. Ma dappertutto ci si trova circondati da reminiscenze della lotta per l'indipendenza, ed il sentimento anti-inglese è forte. Molti nomi inglesi sono stati cambiati, i cartelli sono sempre bilingui, la colonna di Nelson a Dublino è stata abbattuta nel '66 e da tempo è stato adottato il sistema metrico decimale; e ovviamente non dimentichiamo l'ingresso nella UE (ma non nell'area Schengen, come si scopre all'aeroporto) e l'uso dell'Euro. Per ragioni facili a capirsi rimane invece la guida a sinistra. Altra memoria inglese mantenuta sono gli autobus a due piani, che si vedono dappertutto, anche nei paesi. E per fortuna ne hanno mantenuto la lingua, perché quella gaelica è perfettamente incomprensibile. L'organizzazione Boscolo è stata efficiente ed i partecipanti sempre puntuali ai vari appuntamenti; non ci sono stati intralci al programma. Un plauso particolare alla guida Niccolò Magro, che si è fatto in quattro per tenere il gruppo e accontentare tutti, facendosi benvolere. Durante i viaggi l'abbiamo visto passare ore al telefono a preparar visite o a cercar di sistemare 31 persone nei pub più caratteristici sotto ferragosto, impresa titanica e un paio di volte non riuscita, ma comunque quando era del tutto impossibile. Come sempre, non descriverò qui i tesori d'arte: questo è compito delle guide; dirò solo delle impressioni e delle curiosità che mi hanno colpito. Cominciamo con Dublino, inevitabile inizio e fine del viaggio per la presenza dell'aeroporto internazionale. Arriviamo all'una e subito troviamo la navetta per l'albergo. Pomeriggio libero, intanto che gli altri componenti del gruppo arrivano man mano, in momenti diversi secondo gli aerei: c'è tempo perciò di farsi un'idea sommaria della città. La vista comincia l'indomani con l'inizio del viaggio vero e proprio. La città è carina ma non spettacolare. Ci sono naturalmente le attrattive storiche e artistiche: cattedrali e chiese minori, palazzi, musei e quant'altro. Ma più che dedicarsi a queste è bene respirare un po' l'aria locale ed inoltrarsi nei quartieri tipici, anche se sono proprio questi a correre i maggiori rischi di globalizzazione. Cominciamo quindi con la
visita “culturale” della città, con una guida
locale che parla italiano, a partire dalla
cattedrale di S. Patrizio. Nel pomeriggio -libero- ci
diamo al colore locale ed eccoci La cena è libera e si decide di tentare tutti assieme il pub più antico della città; ma trovar posto per 31 sotto ferragosto è un'impresa sovrumana, e rimediamo col pub di fronte, comunque caratteristico. Poi, un'ultima passeggiata nei quartieri a nord per vedere da vicino i segni, ancora conservati in O'Connell street, delle sparatorie del 1916. Un piccolo inconveniente al ritorno: una parte del gruppo si perde nella folla del Temple Bar, e il bravo Niccolò ha il suo bel daffare a raccattarli tutti. Intanto che lui rimane sul posto a telefonare e cercare, noialtri, d'accordo con lui, rientriamo in albergo per conto nostro. Lasciamo Dublino per passare sulla costa opposta. Subito una campagna verdissima, che fa onore al colore nazionale. Come in quella inglese i campi son per lo più pascoli verde-chiaro, bordati da filari di siepi o altra vegetazione più scura, e popolati di mucche e pecore, che ci perseguiteranno per tutto il viaggio. Le prime soprattutto nelle zone interne, le seconde più numerose sul mare. Come in tutto il nord Europa sono libere, e non chiuse in stalla come da noi. Più avanti nel paesaggio cominciano a comparire vaste torbiere, che si vedranno ancora spesso nelle pianure, rappresentando una curiosa alternativa ai pascoli. Ci fermiamo a visitare il
Clonmacnoise, la più
Galway, la nostra meta, è
una città portuale. Una curiosità è il fiume
Corrib, che appare impetuoso: strano, per
L'albergo è un po' lontano dal centro, e questo non era ben chiaro sul programma. La prima sera siamo stati portati in città per la cena in un locale tipico, un posto strano e pittoresco, con una quantità di scale e scalette per guadagnare la saletta riservata; ma la seconda non c'era disponibile il pullman (l'autista aveva sforato le ore regolamentari) e chi voleva andare in città ha dovuto scarpinare o pagarsi il taxi. L'escursione successiva ci porta sul Connemara, regione costiera con panorami grandiosi. Si passa per Cong, celebre per esser stato il principale scenario del film Un uomo tranquillo; c'è anche il monumento con John Wayne e Maureen O'Hara e non manca il museo apposito. È un villaggio delizioso, con fiumicello, in mezzo al verde, uno dei posti dove mi sarebbe piaciuto fermarmi in un viaggio libero. Ma il pacchetto non prevede soste qui. Dovunque i prati sono
punteggiati di pecore al
Si costeggia un fiordo di
aspetto norvegese; più avanti, pausa-pranzo alla
Altra sosta a Clifden, il grazioso capoluogo locale. Segue un paesaggio ancora aspro, ma adesso all'interno e con una successione di laghi e laghetti; poi si torna sulla costa, con vista delle basse isole Aran. Si riparte l'indomani con un lungo giro attorno al golfo: dopo più di un'ora dalla partenza abbiamo ancora Galway di fronte. Paesaggio via via più aspro e grandioso; la strada corre un po' lungo il mare e un po' all'interno; ancora le isole Aran, adesso vicine. Ed eccoci alle celebri
scogliere di Moher. Arrivandovi
dall'interno, in un dolce paesaggio di prati
frequentati come sempre da mucche e pecore al
pascolo, fa meraviglia di trovare questo
precipizio, che in certi punti tocca i 200 m e
continua per chilometri, sul mare.
La quale viene invece evitata con un tunnel sotto il fiume. La sosta a Charleville è dovuta solo alla necessità di frazionar opportunamente le tappe: anche quest'albergo, pur bello e dotato di piscina e spa, è lontano dal centro, e il paese è senza interesse. Una sosta di puro relax, il cui carattere forse andava meglio chiarito nel programma. Continuiamo verso sud-ovest e questa è a parer mio la zona più bella dal punto di vista “bucolico”. Ci fermiamo a Killarney, ma solo per motivi tecnici. Cittadina graziosa e dintorni con ville e parchi grandiosi, trasformati in alberghi. Sosta successiva al Red Fox Inn (ottimo il suo irish coffee); la quantità di pullman turistici mi fa pensare che questo locale sponsorizzi i vari viaggi. Anche l'adiacente villaggio di Kerry Bog è ricostruito, sempre con pezzi originali, cani e pony compresi, ed a modo suo interessante anche perché illustra la lavorazione della torba (“bog”). Forse si poteva barattare la sosta con un giro a Killarney. Siamo qui sull'anello del
Kerry, un itinerario circolare tutt'attorno
alla penisola di Iveragh. Sembra che i
numerosissimi pullman turistici lo percorrano,
come noi, tutti in senso antiorario per evitar
d'incrociarsi su quella stradina. A sinistra le
montagne, per lo più a prati sempre punteggiati
di bestie; a destra il mare con scorci continui.
A Cahersiveen, paese natale di Daniel O'Connell,
c'è una curiosità: la chiesa -moderna- è
consacrata a lui, caso unico per un laico.
Pausa-pranzo a Waterville, sulla spiaggia, dove
veniva in vacanza Charlie Chaplin (c'è il
monumento, manco a dirlo); poi altre soste
fotografiche. La costa è frastagliatissima,
bordata di isole, isolette e scogli; il mare qui
potrebbe sembrare
Avvicinandosi a Killarney, ricominciano i grandi parchi con ville e alberghi di lusso visti stamattina. Sosta tecnica in uno di questi, il Muckross garden. Ne approfitto per un'occhiata rapidissima alla villa-castello. Gran traffico sulla strada, e si va a singhiozzo. Evitiamo la città e chiudiamo l'anello tornando sulla strada di stamattina, ma per poco, perché poi si procede verso Cork; è ormai tardi e la stanchezza si sente. Meglio sarebbe stato far l'ultima tappa a Cork, che evitiamo passando sulla tangenziale, invece che nell'anonima Garryvoe, che si trova altri 30-40 km al di là. Si sarebbe così anche evitato di infliggere almeno altri tre quarti d'ora di viaggio ai partecipanti: la tappa di oggi era già abbastanza lunga. Idem per quella di domani, dove bisogna ripassare da Cork per prender l'autostrada. Il tempo risparmiato doppiamente poteva servire per un breve giro in città. Lasciamo definitivamente il mare diretti a Dublino. Ma prima ci sono due fermate importanti. La rock of Cashel si
presenta già da lontano come una fungaia di
torri, soprelevata in bella posizione a far da
sfondo al paese. È un assieme di chiese,
castello, torre e altri edifici minori, tutti
diroccati perché pure qui Cromwell -ancora lui-
ha lasciato il segno. La cattedrale è
scoperchiata e richiama un po' quella di
Jumièges sulla Senna, e la nostra S. Galgano. La
tor
Queste due ultime visite erano senza guida, con una documentazione un po' approssimativa. Passiamo poi al castello,
dove la visita è libera. Fuori ci sono due
suonatori
Si rientra a Dublino allietati da un ingorgo sull'autostrada; è pur sempre l'ora di punta serale. Evidentemente non abbiamo noi l'esclusiva degli imbottigliamenti stradali. Ma con quello di ieri sono stati gli unici due; forse un viaggio simile da noi ne avrebbe incontrati molti di più. La serata prevede la cena in un locale tipico, fuori città, con spettacolo folkloristico. Fortuna che la differenza di lingua ci ha messi al riparo dall'esser coinvolti nello show, com'è invece capitato ad una turista australiana del tavolo a fianco. Ormai il viaggio è finito ed è la volta dei saluti; secondo gli orari dei vari aerei del rientro, i trasferimenti all'aeroporto iniziano già in piena notte. Noi siamo fortunati a partire verso sera, così ci avanza una mattinata libera per le ultime visite. La mattina dopo sembra autunno: piove in continuazione, tira vento e siamo sui 14°. Poteva essere questo il clima medio durante la vacanza; invece abbiamo avuto solo pochi e brevi sprazzi di pioggia, abbastanza sole e mai un freddo come adesso: ci è andata davvero bene. La pioggia consiglia i musei, finora snobbati. Visitiamo il Little Museum, un gioiellino sulla recente vita dublinese, tutto costituito di oggetti e cimeli donati dalla popolazione: foto, manifesti, libri, arredi e altri pezzi di vita famigliare. Molti parlano inevitabilmente della lotta per l'indipendenza; gli Inglesi come sempre non ci fanno una bella figura. Passiamo quindi alla birreria Guinness, che dicono essere il luogo più visitato d'Irlanda: a giudicare dalla gente dentro, concordo pienamente. Per fortuna i più devono aver preso il biglietto in anticipo: nessuna coda. Dentro sono illustrate, anche con filmati d'epoca, sia la preparazione della birra, sia quella, forse più curiosa, delle botti. Dappertutto, macchinari d'ogni sorta ed epoca, comprese le piccole locomotive dei treni in servizio interno. Il prezzo del biglietto -salato- comprende anche una pinta di birra; se l'avessi saputo avrei avuto cura di mangiar qualcosa appena prima, per non ingollarla a stomaco vuoto. I bar ci sono, ma lontano dalla sala dove la servono. Questa sala è in alto e consente un panorama a 360° sulla città. A proposito della cucina locale: non ricordo niente di eclatante: fish & chips, stufati e patate in tutte le maniere; e poi ostriche, spigole e salmone, il mio preferito. Sono buoni non tanto per la ricetta; è buona la materia prima che c'è sotto. Va ricordato poi che la patata ha avuto una grande importanza nella vita irlandese, perché è stata la sua mancanza per un parassita a metà '800 a provocare la grande carestia e la conseguenze emigrazione negli USA. Ho sempre ordinato piatti locali, perché nei viaggi mi par giusto dimenticare la cucina italiana per mangiare e bere ciò che mangiano e bevono quelli del posto, almeno nei limiti del possibile, cioè fatti salvi certi piatti tremendi tipo l'Haggis scozzese o gli intrugli asiatici a base d'insetti. La regina del settore gastronomico è stata senza dubbio la birra scura Guinness, che a rigore non è la mia preferita (assegno il primato alla Pilsen), ma che ho sempre ordinato per le ragioni anzidette. Fatti tutti i conti, devo averne trangugiati fra i sei e i sette litri in otto giorni, al ritmo d'una pinta (0,56 l) alla volta. E neanche il più piccolo mal di testa, nemmeno dopo l'ultima, tracannata come detto a stomaco vuoto. Ed eccoci all'aeroporto con grande anticipo; in compenso è in ritardo l'aereo: all'inizio si parla di un'ora, ma al decollo saranno due e mezza! Si arriva così a mezzanotte, nell'ancor caldo abbraccio della Valpadana. 28 agosto 2023 Giovanni Saccarello UNA SETTIMANA “LETTERARIA” IN VENETO Un soggiorno nella campagna tra i Colli Euganei e i Colli Berici ci ha portato a riscoprire lo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro (1842 – 1911), attraverso splendidi luoghi che hanno ispirato alcune sue opere. La scelta della località dove abbiamo soggiornato – Montegalda, in posizione strategica tra Padova e Vicenza– in realtà è stata abbastanza casuale: cercavamo
un posto tranquillo, lontano dagli affollamenti
agostani, una sorta di locus amoenus, e abbiamo
trovato qui, tramite Booking, una bellissima
villa ottocentesca immersa in un vasto parco,
con una splendida piscina: Villa Lioy
–
Faresin. La doppia denominazione nasce dal fatto
che la storica Villa Lioy è stata acquistata
qualche anno fa da Marco Faresin, classe 1934,
stimato commercialista di Vicenza, che ha deciso,
con grande coraggio e risolutezza, di preservare
l’edificio e il prezioso patrimonio arboreo (vi
si trovano, su quasi due ettari, cercavamo
un posto tranquillo, lontano dagli affollamenti
agostani, una sorta di locus amoenus, e abbiamo
trovato qui, tramite Booking, una bellissima
villa ottocentesca immersa in un vasto parco,
con una splendida piscina: Villa Lioy
–
Faresin. La doppia denominazione nasce dal fatto
che la storica Villa Lioy è stata acquistata
qualche anno fa da Marco Faresin, classe 1934,
stimato commercialista di Vicenza, che ha deciso,
con grande coraggio e risolutezza, di preservare
l’edificio e il prezioso patrimonio arboreo (vi
si trovano, su quasi due ettari,
 farnie
secolari, cedri, bagolari) altrimenti destinati
al degrado. Non è raro che a salvare beni
artistici e bellezze naturali, in Italia,
intervengano i privati, che vi investono energie
e denaro, consentendone poi un utilizzo, in
diverse forme: in particolare il Veneto, che ha
un’immensa ricchezza in ville e castelli,
beneficia di iniziative che testimoniano la
volontà di singoli cittadini in tal senso; e
Faresin ne è senz’altro un esempio. farnie
secolari, cedri, bagolari) altrimenti destinati
al degrado. Non è raro che a salvare beni
artistici e bellezze naturali, in Italia,
intervengano i privati, che vi investono energie
e denaro, consentendone poi un utilizzo, in
diverse forme: in particolare il Veneto, che ha
un’immensa ricchezza in ville e castelli,
beneficia di iniziative che testimoniano la
volontà di singoli cittadini in tal senso; e
Faresin ne è senz’altro un esempio.
La famiglia Lioy, di antica nobiltà pugliese, acquistò la villa nel 1919; il suo più noto esponente, Paolo (1834 – 1911) , nato a Vicenza, naturalista, autore di saggi e studi importanti, di vasta rinomanza all’epoca, impegnato anche in politica, ebbe numerose cariche pubbliche: fu eletto deputato e poi senatore del Regno, nel 1905. Paolo Lioy frequentava i salotti letterari vicentini e conobbe presto il più giovane Fogazzaro, con il quale strinse amicizia. A Montegalda la famiglia Fogazzaro aveva una residenza, citata in Piccolo Mondo Moderno, una delle ultime opere dello scrittore, come “Villa Flores”, e ora Villa Fogazzaro – Roi – Colbachini, risalente al XV sec. ma più volte ampliata. Ha un Giardino all’Italiana e un Parco Romantico; ospita il Museo delle campane. Pur essendo vicinissima a Villa Lioy non siamo tuttavia riusciti a visitarla, in quanto aperta solo il sabato alle 10, su prenotazione. Antonio soggiornava a Montegalda soprattutto nel periodo della vendemmia; fu eletto consigliere comunale e il Comune, nel 2009, gli ha dedicato una lapide commemorativa, ricordandolo
come “insigne cantore di questa terra, dove,
nell’appassionata ricerca di fede, narrò la
natura, i luoghi, e profuse per la gente
munifica generosa liberalità”. Il fratello Luigi
fu il primo sindaco di Montegalda dopo l’unità
d’Italia. In Piccolo Mondo Moderno le vicende
sono ambientate anche a Teolo, nell’Abbazia di
Praglia, che abbiamo visitato, guidati da un
monaco benedettino appassionato di storia
dell’arte, trovandola di grande interesse. “Praglia”deriva
da “pratàlea”, che significa “località tenuta a
prati”: e l’abbazia spicca in effetti tra campi
e prati molto estesi, alle pendìci
settentrionali dei Colli Euganei. Risale alla
fine dell’XI secolo, anche se dell’originale
complesso medioevale resta solo la torre
campanaria: fu ampliata e ristrutturata nel XV
secolo. Presenta quattro chiostri, uno detto “botanico”,
con le colonne di marmo rosa di Verona alternate
a quelle bianche di pietra d’Istria, secondo uno
stile prettamente veneziano, un altro pensile,
con un ingegnoso sistema di raccolta dell’acqua
piovana; un terzo chiostro ha un doppio loggiato
e uno più piccolo è associato alla foresteria.
All’angolo sud - est del chiostro pensile si può
ammirare il panorama della campagna circostante
dalla Loggetta Belvedere, cinquecentesca,
dedicata proprio ad Antonio Fogazzaro: è
riportato su una lapide affissa nella loggetta
un passo del romanzo in cui viene citata.
Bellissimo il refettorio, con una stupenda
Crocifissione di fine Quattrocento di Bartolomeo
Montagna e un elegante pulpito coevo. Gli stalli
settecenteschi, i medaglioni e le tele alle
pareti, raffiguranti episodi biblici, rendono la
sala davvero preziosa. La chiesa abbaziale,
consacrata nel 1547, è un notevole esempio di
architettura rinascimentale veneta: ha tre
navate e cappelle laterali con affreschi del
Campagnola, e opere di Paolo Veronese, Luca
Longhi, Giovanbattista Zelotti; spicca un bel
crocifisso ligneo in stile giottesco. ricordandolo
come “insigne cantore di questa terra, dove,
nell’appassionata ricerca di fede, narrò la
natura, i luoghi, e profuse per la gente
munifica generosa liberalità”. Il fratello Luigi
fu il primo sindaco di Montegalda dopo l’unità
d’Italia. In Piccolo Mondo Moderno le vicende
sono ambientate anche a Teolo, nell’Abbazia di
Praglia, che abbiamo visitato, guidati da un
monaco benedettino appassionato di storia
dell’arte, trovandola di grande interesse. “Praglia”deriva
da “pratàlea”, che significa “località tenuta a
prati”: e l’abbazia spicca in effetti tra campi
e prati molto estesi, alle pendìci
settentrionali dei Colli Euganei. Risale alla
fine dell’XI secolo, anche se dell’originale
complesso medioevale resta solo la torre
campanaria: fu ampliata e ristrutturata nel XV
secolo. Presenta quattro chiostri, uno detto “botanico”,
con le colonne di marmo rosa di Verona alternate
a quelle bianche di pietra d’Istria, secondo uno
stile prettamente veneziano, un altro pensile,
con un ingegnoso sistema di raccolta dell’acqua
piovana; un terzo chiostro ha un doppio loggiato
e uno più piccolo è associato alla foresteria.
All’angolo sud - est del chiostro pensile si può
ammirare il panorama della campagna circostante
dalla Loggetta Belvedere, cinquecentesca,
dedicata proprio ad Antonio Fogazzaro: è
riportato su una lapide affissa nella loggetta
un passo del romanzo in cui viene citata.
Bellissimo il refettorio, con una stupenda
Crocifissione di fine Quattrocento di Bartolomeo
Montagna e un elegante pulpito coevo. Gli stalli
settecenteschi, i medaglioni e le tele alle
pareti, raffiguranti episodi biblici, rendono la
sala davvero preziosa. La chiesa abbaziale,
consacrata nel 1547, è un notevole esempio di
architettura rinascimentale veneta: ha tre
navate e cappelle laterali con affreschi del
Campagnola, e opere di Paolo Veronese, Luca
Longhi, Giovanbattista Zelotti; spicca un bel
crocifisso ligneo in stile giottesco.
Un’altra visita senz’altro
consigliabile è quella all’Eremo di San Cassiano,
in uno scenario di stupende rocce calcaree,
davvero imponenti, che creano un paesaggio
simile a quello delle Meteore. Per giungere
all’Eremo, incassato in
 collezione di
fossili - attraverso una suggestiva scalinata
coperta, usata dai pellegrini. Abbiamo
attraversato la magnifica piazza dei Signori,
con la Basilica Palladiana e il palazzo del
Capitaniato, capolavori di Andrea Palladio, e le
vie adiacenti, riscoprendo angoli e monumenti
davvero pregevoli che fanno di Vicenza una città
d’arte di grande importanza. Anche i dintorni
sono molto interessanti: fra tutti il lago di
Fimon - ricco di ninfee e uccelli acquatici - di
cui abbiamo percorso un giro completo in circa
un’ora e mezzo di cammino, tra una bella
vegetazione, su un piacevole circuito
ciclopedonale. Ci siamo poi rimessi “sulle
tracce di Fogazzaro” recandoci a Velo d’Astico,
un paese che si può raggiungere in neppure
mezz’ora di autostrada, la A31. collezione di
fossili - attraverso una suggestiva scalinata
coperta, usata dai pellegrini. Abbiamo
attraversato la magnifica piazza dei Signori,
con la Basilica Palladiana e il palazzo del
Capitaniato, capolavori di Andrea Palladio, e le
vie adiacenti, riscoprendo angoli e monumenti
davvero pregevoli che fanno di Vicenza una città
d’arte di grande importanza. Anche i dintorni
sono molto interessanti: fra tutti il lago di
Fimon - ricco di ninfee e uccelli acquatici - di
cui abbiamo percorso un giro completo in circa
un’ora e mezzo di cammino, tra una bella
vegetazione, su un piacevole circuito
ciclopedonale. Ci siamo poi rimessi “sulle
tracce di Fogazzaro” recandoci a Velo d’Astico,
un paese che si può raggiungere in neppure
mezz’ora di autostrada, la A31.
 Qui si trovano
la Villa Fogazzaro detta “La Montanina”,
costruita nel 1907 in stile Liberty, in mezzo a
un grande parco, dove Fogazzaro ambientò
“Leila”, il suo ultimo romanzo, del 1910
–
ora appartenente a un’organizzazione
religiosa - e la settecentesca (1752) Villa Velo
Zabeo (collegata alla precedente) costruita dai
conti Velo, trasformata da Fogazzaro in
“Villa
Cortis”
nel romanzo
“Daniele
Cortis”.
Qui una colonna di porfido spezzata
–
la colonna egizia, portata dalle Terme di
Caracalla
–
diventa, per il protagonista del romanzo,
simbolo dell’amore
infelice per la cugina Elena. Noi siamo entrati
nel cortile dal cancello aperto, seguendo
fiduciosi l’indicazione
stradale
“Villa
Velo
–
Villa Cortis, Itinerario fogazzariano”
: ma l’edificio
era deserto, con masserizie e amache un po’
ovunque che davano purtroppo un’impressione
di disordine, tanto che ne siamo usciti in
fretta alquanto delusi. Forse sono ancora in
fieri i lavori di restauro iniziati dall’ultimo
proprietario! Qui si trovano
la Villa Fogazzaro detta “La Montanina”,
costruita nel 1907 in stile Liberty, in mezzo a
un grande parco, dove Fogazzaro ambientò
“Leila”, il suo ultimo romanzo, del 1910
–
ora appartenente a un’organizzazione
religiosa - e la settecentesca (1752) Villa Velo
Zabeo (collegata alla precedente) costruita dai
conti Velo, trasformata da Fogazzaro in
“Villa
Cortis”
nel romanzo
“Daniele
Cortis”.
Qui una colonna di porfido spezzata
–
la colonna egizia, portata dalle Terme di
Caracalla
–
diventa, per il protagonista del romanzo,
simbolo dell’amore
infelice per la cugina Elena. Noi siamo entrati
nel cortile dal cancello aperto, seguendo
fiduciosi l’indicazione
stradale
“Villa
Velo
–
Villa Cortis, Itinerario fogazzariano”
: ma l’edificio
era deserto, con masserizie e amache un po’
ovunque che davano purtroppo un’impressione
di disordine, tanto che ne siamo usciti in
fretta alquanto delusi. Forse sono ancora in
fieri i lavori di restauro iniziati dall’ultimo
proprietario!
Una villa che invece ci ha
entusiasmato è stata Villa dei Vescovi, donata
al FAI nel 2005 dagli ultimi padroni di casa, i
coniugi Olcese. Nella porzione nord-est del
Parco Regionale dei Colli Euganei, a Luvigliano,
sorge su una sommità, circondata da ettari di
verde; la sua fondazione è dovuta al vescovo
Francesco Pisani, che la volle far costruire nel
1535, su progetto di Giovanni Maria Falconetto.
Dopo la visita ci siamo
spostati a Padova, città stupenda già più volte
Essendoci spostati nel
padovano non potevamo mancare un’altra meta “letteraria”
fondamentale: Arquà Petrarca. Qui il sommo
autore del Canzoniere si trasferì nel 1370,
avendo avuto in dono una casa dal signore
Nella vicinissima Monselice
siamo saliti al seicentesco Santuario Giubilare
Per ultimo ci siamo riservati
un luogo davvero magico: il Castello del Catajo,
a pochi minuti di auto da Monselice, a Battaglia
Terme. Il nome deriverebbe da “Ca’ del Tajo”,
dove per “Tajo”, ossia “taglio”, si intenderebbe
uno scavo nella roccia per le acque del canale
che attraversa i suoi appezzamenti di terreno,
estesi per circa 40 ettari, e che confluisce nel
rio Rialto. Gasparo degli Obizzi, appartenente a
una nobile famiglia originaria della Borgogna e
trasferitasi nella Repubblica di Venezia, fece
costruire qui una residenza, tra il 1530 e il
1541, che divenne un vero centro culturale anche
grazie alla sua vedova, Beatrice; qui erano
graditi ospiti i più importanti letterati del
tempo, quali Ludovico Ariosto e Torquato Tasso.
Su progetto dell’architetto
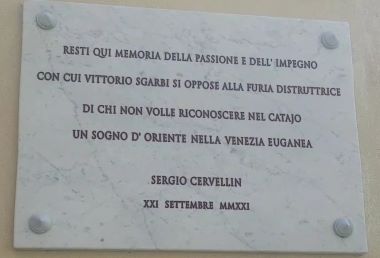 Vittorio Sgarbi:
"Resti qui memoria
della passione e dell’impegno
con cui Vittorio Sgarbi si oppose alla furia
distruttrice di chi non volle riconoscere nel
Catajo un sogno d’oriente
nella Venezia euganea". Nel 2017 infatti è stato
assurdamente proposto dall’Amministrazione
comunale di Due Carrare il progetto di un grande
centro commerciale che doveva sorgere nelle
vicinanze: la lotta di Sgarbi in difesa di un “luogo
sublime che soltanto menti malate e perverse
possono pensare di contaminare” ha avuto per il
momento successo. Il centro commerciale non è
stato costruito. Spetta certo a tutti noi
vigilare sempre per evitare che ignoranza e
avidità attentino al nostro patrimonio artistico
e paesaggistico, realmente inestimabile. Vittorio Sgarbi:
"Resti qui memoria
della passione e dell’impegno
con cui Vittorio Sgarbi si oppose alla furia
distruttrice di chi non volle riconoscere nel
Catajo un sogno d’oriente
nella Venezia euganea". Nel 2017 infatti è stato
assurdamente proposto dall’Amministrazione
comunale di Due Carrare il progetto di un grande
centro commerciale che doveva sorgere nelle
vicinanze: la lotta di Sgarbi in difesa di un “luogo
sublime che soltanto menti malate e perverse
possono pensare di contaminare” ha avuto per il
momento successo. Il centro commerciale non è
stato costruito. Spetta certo a tutti noi
vigilare sempre per evitare che ignoranza e
avidità attentino al nostro patrimonio artistico
e paesaggistico, realmente inestimabile.
12 Agosto 2023, Anna Busca LUGLIO 2023 UNA PAUSA RIGENERANTE IN TOSCANA Siamo fuggiti dalla calura
milanese di luglio per ritagliarci quattro notti
sulle colline toscane, tra le province di Siena
e di Grosseto. Abbiamo
Arrivati venerdì nel tardo
pomeriggio, ci siamo poi recati per la cena
all’Agriturismo Fonte di Braca di Campagnatico (meglio
prenotare, cell. 3283786075). La cena, a prezzo
fisso (30 euro), comprendeva ottimi piatti
serviti a tavoli all’aperto, con bella vista sul
tramonto, e un concerto di una cover band di
Lucio Battisti, i Divi Tardivi. La prima visita ha
riguardato, nella giornata di sabato, la vetta
del Monte Amiata, raggiungibile in auto tramite
diverse strade, oppure, per chi lo preferisce,
salendo in seggiovia dal Prato delle Macinaie.
Noi abbiamo usato l’auto, attraversando la
splendida faggeta: il percorso è un po’ tortuoso
ma
 come il pulpito, con
l’Ultima cena e la Resurrezione di Cristo,
oppure il Battesimo di Cristo davanti al fonte
battesimale, incantano il visitatore. Da vedere
anche la chiesa della Madonna delle Nevi (detta
Pescina), che presenta un pavimento di vetro
sotto il quale si può vedere l’acqua delle
sorgenti del fiume Fiora, che alimentano la
vicina peschiera, una grande vasca cinta da un
muro di trachite, voluta dagli Sforza nel XVI
secolo. Il paese è ricco di edifici storici e
chiese; essendo arroccato, la visita è un po’
faticosa soprattutto in una calda giornata
estiva, dovendo salire e scendere scale e ripide
viuzze piuttosto assolate. Ci siamo fermati per
una tappa anche ad Arcidosso, altro borgo
medioevale arroccato, con un bel castello
aldobrandesco, purtroppo chiuso. come il pulpito, con
l’Ultima cena e la Resurrezione di Cristo,
oppure il Battesimo di Cristo davanti al fonte
battesimale, incantano il visitatore. Da vedere
anche la chiesa della Madonna delle Nevi (detta
Pescina), che presenta un pavimento di vetro
sotto il quale si può vedere l’acqua delle
sorgenti del fiume Fiora, che alimentano la
vicina peschiera, una grande vasca cinta da un
muro di trachite, voluta dagli Sforza nel XVI
secolo. Il paese è ricco di edifici storici e
chiese; essendo arroccato, la visita è un po’
faticosa soprattutto in una calda giornata
estiva, dovendo salire e scendere scale e ripide
viuzze piuttosto assolate. Ci siamo fermati per
una tappa anche ad Arcidosso, altro borgo
medioevale arroccato, con un bel castello
aldobrandesco, purtroppo chiuso.
Abbiamo dedicato il giorno seguente, domenica, alla visita di un luogo straordinario, che coniuga perfettamente arte e natura: il Giardino di Daniel Spoerri, vicino a Seggiano (tel. 0564 950 553, www.danielspoerri.org). Aperto tutti i giorni da aprile a ottobre, richiede invece un appuntamento per la visita negli altri mesi dell’anno. Il parco, curato dalla Fondazione svizzera Hic terminus haeret (“Qui aderiscono i confini”, da un passo dell’Eneide), si estende per ben 16 ettari ed
ospita 115 sculture, sia di Spoerri che di
cinquantacinque altri artisti contemporanei.
Daniel Feinstein, nato in Romania nel 1930 e
naturalizzato svizzero, adottò il cognome della
madre, Lydia Spoerri; trasferitosi a Zurigo
appena dodicenne, orfano di padre - trucidato
dai nazisti - iniziò a studiare danza classica.
La sua biografia è incredibile, in quanto rivela
un talento artistico completo e una grande
creatività (anche se la negò in più occasioni
sostenendo che non faceva che “mettere un po’ di
colla su oggetti”): è stato ballerino,
coreografo, aiuto regista, poeta, editore,
artista figurativo cofondatore ed esponente del
Nouveau Réalisme, scultore, ideatore della
corrente artistica detta Eat Art, docente
universitario e perfino ristoratore in Germania,
muovendosi tra Parigi, New York, Milano, vivendo
per lunghi periodi prima in Grecia e poi in
Toscana, in questo luogo da lui molto amato. Ha
conosciuto e frequentato artisti quali Marcel
Duchamp estende per ben 16 ettari ed
ospita 115 sculture, sia di Spoerri che di
cinquantacinque altri artisti contemporanei.
Daniel Feinstein, nato in Romania nel 1930 e
naturalizzato svizzero, adottò il cognome della
madre, Lydia Spoerri; trasferitosi a Zurigo
appena dodicenne, orfano di padre - trucidato
dai nazisti - iniziò a studiare danza classica.
La sua biografia è incredibile, in quanto rivela
un talento artistico completo e una grande
creatività (anche se la negò in più occasioni
sostenendo che non faceva che “mettere un po’ di
colla su oggetti”): è stato ballerino,
coreografo, aiuto regista, poeta, editore,
artista figurativo cofondatore ed esponente del
Nouveau Réalisme, scultore, ideatore della
corrente artistica detta Eat Art, docente
universitario e perfino ristoratore in Germania,
muovendosi tra Parigi, New York, Milano, vivendo
per lunghi periodi prima in Grecia e poi in
Toscana, in questo luogo da lui molto amato. Ha
conosciuto e frequentato artisti quali Marcel
Duchamp
 e Man Ray, è stato insignito di premi
prestigiosi. Le sue opere
–
soprattutto in bronzo, ma anche in ferro, marmo,
pietra e altri materiali - colpiscono ed
emozionano: quasi al centro del parco si può
entrare nella sua Chambre N°13 de l’Hotel
Carcassonne, oppure, più a sinistra rispetto
all’ingresso, nell’Ombelico del mondo
–
Unicorni, da cui si ammira il paesaggio
circostante; bellissimo, all’inizio
della visita, il Sentiero murato labirintiforme
(da un petroglifo precolombiano). Tra le opere
di altri artisti si segnalano Dies irae
–
Jour de colère di Olivier Estoppey, dove 160
oche in cemento armato a grandezza naturale si
dirigono, insieme a tre suonatori di tamburi e a
un bambino, verso un luogo imprecisato,
marciando come soldati in guerra, e le splendide
teste in bronzo di Eva Aeppli, che rievocano
simbolicamente i pianeti, lo zodiaco, le
debolezze umane. La visita completa richiede
almeno tre ore, ma è meglio pensare di dedicarne
di più, viste la bellezza e la ricchezza
artistica del luogo, una sorta di enorme museo a
cielo aperto; lungo i percorsi, tra prati e zone
alberate, si possono trovare panchine per una
sosta. Meglio avere un copricapo, scarpe comode
e una borraccia (un bar-bistrot è vicino alla
biglietteria, dopo il parcheggio). L’ingresso
costa 12 euro (studenti 9 euro, bambini fino a 8
anni gratis). e Man Ray, è stato insignito di premi
prestigiosi. Le sue opere
–
soprattutto in bronzo, ma anche in ferro, marmo,
pietra e altri materiali - colpiscono ed
emozionano: quasi al centro del parco si può
entrare nella sua Chambre N°13 de l’Hotel
Carcassonne, oppure, più a sinistra rispetto
all’ingresso, nell’Ombelico del mondo
–
Unicorni, da cui si ammira il paesaggio
circostante; bellissimo, all’inizio
della visita, il Sentiero murato labirintiforme
(da un petroglifo precolombiano). Tra le opere
di altri artisti si segnalano Dies irae
–
Jour de colère di Olivier Estoppey, dove 160
oche in cemento armato a grandezza naturale si
dirigono, insieme a tre suonatori di tamburi e a
un bambino, verso un luogo imprecisato,
marciando come soldati in guerra, e le splendide
teste in bronzo di Eva Aeppli, che rievocano
simbolicamente i pianeti, lo zodiaco, le
debolezze umane. La visita completa richiede
almeno tre ore, ma è meglio pensare di dedicarne
di più, viste la bellezza e la ricchezza
artistica del luogo, una sorta di enorme museo a
cielo aperto; lungo i percorsi, tra prati e zone
alberate, si possono trovare panchine per una
sosta. Meglio avere un copricapo, scarpe comode
e una borraccia (un bar-bistrot è vicino alla
biglietteria, dopo il parcheggio). L’ingresso
costa 12 euro (studenti 9 euro, bambini fino a 8
anni gratis).
La nostra meta successiva, il
lunedì, è stata Grosseto, che non conoscevamo, a
circa venti minuti di superstrada da Paganico.
Parcheggiata l’auto a ridosso delle mura medicee,
siamo entrati nel centro storico dalla Porta
Nuova, camminando per corso Carducci; in piazza
Dante (detta anche piazza delle Catene) spicca
la facciata a bicromia bianco-rosata del Duomo,
la
 che ci è
parso il meno impegnativo vista la calura.
Abbiamo camminato per qualche chilometro in un
bosco di lecci, immersi in un’aria
davvero
balsamica, sia per la vegetazione, che presenta
essenze aromatiche spontanee della macchia
mediterranea, sia per il mare, vicinissimo, al
di là delle alture. A tratti si incontrano aree
di sosta, a volte con interessanti tavole
didattiche sulle specie vegetali e sulla fauna
locale. che ci è
parso il meno impegnativo vista la calura.
Abbiamo camminato per qualche chilometro in un
bosco di lecci, immersi in un’aria
davvero
balsamica, sia per la vegetazione, che presenta
essenze aromatiche spontanee della macchia
mediterranea, sia per il mare, vicinissimo, al
di là delle alture. A tratti si incontrano aree
di sosta, a volte con interessanti tavole
didattiche sulle specie vegetali e sulla fauna
locale.
 La passeggiata ad anello, pur piuttosto
semplice, ci ha richiesto una certa fatica per
il caldo eccessivo: la temperatura di circa 37°C
non è affatto mitigata dalla lecceta, e si suda
abbondantemente soprattutto sulle salite. I rovi
sui sentieri esigono anche pantaloni lunghi e
calzature adeguate. Vista l’esperienza, valida
ma stancante, abbiamo dedotto che la meta più
adatta sarebbe stata la Spiaggia di Collelungo,
a Marina di Alberese, dove avremmo potuto
rinfrescarci con un bel tuffo… Ma incautamente
non ci eravamo attrezzati per attività balneari:
la prossima volta saremo senz’altro più
previdenti. E in ogni caso, al ritorno al Casale
delle Rose, eccoci a nuotare nella grande
piscina, tutta per noi, per un paio d’ore. Puro
relax in Maremma! La passeggiata ad anello, pur piuttosto
semplice, ci ha richiesto una certa fatica per
il caldo eccessivo: la temperatura di circa 37°C
non è affatto mitigata dalla lecceta, e si suda
abbondantemente soprattutto sulle salite. I rovi
sui sentieri esigono anche pantaloni lunghi e
calzature adeguate. Vista l’esperienza, valida
ma stancante, abbiamo dedotto che la meta più
adatta sarebbe stata la Spiaggia di Collelungo,
a Marina di Alberese, dove avremmo potuto
rinfrescarci con un bel tuffo… Ma incautamente
non ci eravamo attrezzati per attività balneari:
la prossima volta saremo senz’altro più
previdenti. E in ogni caso, al ritorno al Casale
delle Rose, eccoci a nuotare nella grande
piscina, tutta per noi, per un paio d’ore. Puro
relax in Maremma!
21 luglio 2023, Anna Busca APRILE 2023 TRA ALTO PIEMONTE E VAL D’AOSTA Un sereno weekend primaverile
può essere sfruttato per un bellissimo tour tra
arte e natura, in luoghi tranquilli e non troppo
turistici. Da Milano abbiamo raggiunto, in
neppure due ore (autostrada A4 Milano-Torino,
uscita Carisio in direzione Cossato) la
splendida Oasi Zegna, patrocinata dal FAI. Si
tratta di un’area montagnosa del Biellese, di
circa 100 km2, ad accesso libero; l’altitudine
varia tra gli 800 e i 2000 m. Fu progettata e
riforestata negli anni ‘30
dall’industriale-mecenate Ermenegildo Zegna
 ci
ha permesso di ammirare il bel centro storico,
con il Duomo e il Battistero romanico. Siamo
dunque ripartiti per raggiungere la nostra meta
in Val d’Aosta: Challand-Saint-Anselme, un
piccolo comune della Val d’Ayas dove avevamo
prenotato una stanza tramite Booking (Hotel Le
Soleil); l’ottima cena in albergo -molto
accogliente - ci ha fatto gustare una squisita
carbonade valdostana con polenta e le tipiche
tegole dolci. Abbiamo dedicato la mattina
seguente a un’altra passeggiata, molto facile e
tutta in piano, alle cascate di Arlaz, che si
raggiungono seguendo un lungo e stretto canale
di irrigazione, in mezzo al bosco. La zona è
splendida, sia per il paesaggio circostante che
per i prati verdissimi; avendo tempo si può
camminare verso piccoli laghi e altre cascate.
Noi invece abbiamo scelto di recarci per uno
spuntino a Gressoney-La-Trinité, per poi
spostarci a Gressoney-Saint-Jean dove abbiamo
ammirato il Castel Savoia, costruito tra il 1899
e il 1904, simile a un castello delle fiabe; la
regina Margherita, innamorata di questi luoghi,
che era solita frequentare, vi trascorse lunghi
periodi estivi con la sua corte, per una ventina
d’anni. Lasciata la Val d’Aosta, eccoci nel ci
ha permesso di ammirare il bel centro storico,
con il Duomo e il Battistero romanico. Siamo
dunque ripartiti per raggiungere la nostra meta
in Val d’Aosta: Challand-Saint-Anselme, un
piccolo comune della Val d’Ayas dove avevamo
prenotato una stanza tramite Booking (Hotel Le
Soleil); l’ottima cena in albergo -molto
accogliente - ci ha fatto gustare una squisita
carbonade valdostana con polenta e le tipiche
tegole dolci. Abbiamo dedicato la mattina
seguente a un’altra passeggiata, molto facile e
tutta in piano, alle cascate di Arlaz, che si
raggiungono seguendo un lungo e stretto canale
di irrigazione, in mezzo al bosco. La zona è
splendida, sia per il paesaggio circostante che
per i prati verdissimi; avendo tempo si può
camminare verso piccoli laghi e altre cascate.
Noi invece abbiamo scelto di recarci per uno
spuntino a Gressoney-La-Trinité, per poi
spostarci a Gressoney-Saint-Jean dove abbiamo
ammirato il Castel Savoia, costruito tra il 1899
e il 1904, simile a un castello delle fiabe; la
regina Margherita, innamorata di questi luoghi,
che era solita frequentare, vi trascorse lunghi
periodi estivi con la sua corte, per una ventina
d’anni. Lasciata la Val d’Aosta, eccoci nel
 Canavese,
un’area geografica dai confini incerti, tra la
Serra d’Ivrea, il Po, le Alpi Graie, la Stura di
Lanzo; comprende parte del Parco Nazionale del
Gran Paradiso ed è ricca di laghi e oasi
naturali. Una tappa a Ivrea, capoluogo del
Canavese, è d’obbligo: anch’essa città
dell’UNESCO, famosa per lo storico “Carnevale
delle arance”, vanta un bellissimo castello e un
sito di valore
architettonico-urbanistico-industriale, l’ex
Olivetti. Abbiamo pernottato a San Giorgio
Canavese, centro soprannominato “l’Atene del
Canavese” perché parecchi intellettuali e
artisti vi sono nati, nel XVIII-XIX secolo, o vi
hanno eletto la propria residenza. Il nostro bed
& breakfast, prenotato su Booking, si chiamava
proprio così (è gestito dai gentilissimi
proprietari dell’omonima casa editrice). Canavese,
un’area geografica dai confini incerti, tra la
Serra d’Ivrea, il Po, le Alpi Graie, la Stura di
Lanzo; comprende parte del Parco Nazionale del
Gran Paradiso ed è ricca di laghi e oasi
naturali. Una tappa a Ivrea, capoluogo del
Canavese, è d’obbligo: anch’essa città
dell’UNESCO, famosa per lo storico “Carnevale
delle arance”, vanta un bellissimo castello e un
sito di valore
architettonico-urbanistico-industriale, l’ex
Olivetti. Abbiamo pernottato a San Giorgio
Canavese, centro soprannominato “l’Atene del
Canavese” perché parecchi intellettuali e
artisti vi sono nati, nel XVIII-XIX secolo, o vi
hanno eletto la propria residenza. Il nostro bed
& breakfast, prenotato su Booking, si chiamava
proprio così (è gestito dai gentilissimi
proprietari dell’omonima casa editrice).
 Canali,
un castello, bei palazzi (stupenda la Villa
Malfatti, con un immenso parco, costruita
all’inizio dell’Ottocento dalla cantante lirica
Teresa Belloc-Giorgi, al secolo M.Teresa Ottavia
Faustina Trombetta, e poi passata ai baroni
Malfatti) connotano la cittadina, il cui punto
di forza è la vicinanza al meraviglioso Castello
Ducale di Agliè, aperto solo da venerdì a
domenica. La prenotazione per la visita è
obbligatoria
(drm-pie.aglie.prenotazioni@cultura.gov.it; tel.
0124 330102, servizio attivo da lunedì a sabato
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00).
Siamo rimasti stupefatti per la ricchezza e la
bellezza delle sale, che rendono il sito un
gioiello unico nel panorama storico-artistico
non solo piemontese ma di tutta Italia. Il parco,
vastissimo, non era accessibile per lavori di
manutenzione; siamo invece riusciti a visitare i
giardini. Di origine antica (il nucleo
originario risale al XII secolo) il castello
subì numerose trasformazioni; Canali,
un castello, bei palazzi (stupenda la Villa
Malfatti, con un immenso parco, costruita
all’inizio dell’Ottocento dalla cantante lirica
Teresa Belloc-Giorgi, al secolo M.Teresa Ottavia
Faustina Trombetta, e poi passata ai baroni
Malfatti) connotano la cittadina, il cui punto
di forza è la vicinanza al meraviglioso Castello
Ducale di Agliè, aperto solo da venerdì a
domenica. La prenotazione per la visita è
obbligatoria
(drm-pie.aglie.prenotazioni@cultura.gov.it; tel.
0124 330102, servizio attivo da lunedì a sabato
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00).
Siamo rimasti stupefatti per la ricchezza e la
bellezza delle sale, che rendono il sito un
gioiello unico nel panorama storico-artistico
non solo piemontese ma di tutta Italia. Il parco,
vastissimo, non era accessibile per lavori di
manutenzione; siamo invece riusciti a visitare i
giardini. Di origine antica (il nucleo
originario risale al XII secolo) il castello
subì numerose trasformazioni; fu il re Carlo Felice a decidere gli ultimi
interventi, nel 1825, affidati agli artisti di
corte. Nella Sala Tuscolana sono collocati
antichi reperti romani provenienti dalla Villa
Rufinella presso Frascati e collezionati da
Carlo Felice e dalla regina Maria Cristina.
Magnifica la Sala da ballo. Una curiosità: fu
ambientata in questo castello la prima stagione
della fortunata serie televisiva “Elisa di
Rivombrosa”, trasmessa tra il 2003 e il 2005,
che ebbe un enorme successo di pubblico. Da
Agliè in breve tempo abbiamo raggiunto il Parco
naturale del lago di Candia - ultima nostra meta
del tour - zona di notevole importanza
faunistica e botanica; il lago si trova tra
boschi e canneti e offre numerose aree di
nidificazione per uccelli migratori (circa 200
le specie censite). Qualche spiaggetta
–
cui si accede da bar
fu il re Carlo Felice a decidere gli ultimi
interventi, nel 1825, affidati agli artisti di
corte. Nella Sala Tuscolana sono collocati
antichi reperti romani provenienti dalla Villa
Rufinella presso Frascati e collezionati da
Carlo Felice e dalla regina Maria Cristina.
Magnifica la Sala da ballo. Una curiosità: fu
ambientata in questo castello la prima stagione
della fortunata serie televisiva “Elisa di
Rivombrosa”, trasmessa tra il 2003 e il 2005,
che ebbe un enorme successo di pubblico. Da
Agliè in breve tempo abbiamo raggiunto il Parco
naturale del lago di Candia - ultima nostra meta
del tour - zona di notevole importanza
faunistica e botanica; il lago si trova tra
boschi e canneti e offre numerose aree di
nidificazione per uccelli migratori (circa 200
le specie censite). Qualche spiaggetta
–
cui si accede da bar
 o
ristoranti - consente un po’
di relax. Non esistono percorsi pedonali che
consentano un circuito ad anello; i sentieri
sono solo tra la vegetazione nella zona delle
paludi. Noi abbiamo optato per una breve
camminata su una strada asfaltata, che ci ha
comunque permesso di cogliere belle vedute del
paesaggio. Il lago di Candia è stato scelto dal
regista Gianluca Mangiasciutti come
ambientazione del suo film “L’uomo sulla strada”
(2022): ed è stata proprio la visione di questo,
con le sue immagini suggestive, a darci lo
spunto per la visita! E torneremo presto
senz’altro in questa bella regione per nuove
mete e altre scoperte. o
ristoranti - consente un po’
di relax. Non esistono percorsi pedonali che
consentano un circuito ad anello; i sentieri
sono solo tra la vegetazione nella zona delle
paludi. Noi abbiamo optato per una breve
camminata su una strada asfaltata, che ci ha
comunque permesso di cogliere belle vedute del
paesaggio. Il lago di Candia è stato scelto dal
regista Gianluca Mangiasciutti come
ambientazione del suo film “L’uomo sulla strada”
(2022): ed è stata proprio la visione di questo,
con le sue immagini suggestive, a darci lo
spunto per la visita! E torneremo presto
senz’altro in questa bella regione per nuove
mete e altre scoperte.
Milano, 15 aprile 2023 Anna Busca SETTEMBRE 2022 di Giovanni SaccarelloLa zona scelta è una striscia nella parte centrale della Francia: Alvernia, Aquitania, Occitania. È stata aggiunta una puntata a nord fino alla bassa Loira, per includere Angers e Nantes, omesse nel precedente viaggio dei castelli, ed un solo accesso al mare (La Rochelle). Ci siamo spinti a sud-ovest fino a Bordeaux. A parte le città maggiori, sono zone piuttosto ignorate da noi; infatti si sono incontrati pochissimi connazionali, come sapevamo già. Ci siamo dedicati soprattutto alle città (tranne alcune pur notevoli, come Lione, Clermont-Ferrand, Le Puy, Bourges, Sarlat, già viste in viaggi precedenti) ed ai castelli ed abbazie isolati. L'auto era inevitabile, specie per raggiungere questi ultimi e per i panorami; sono stati 3.500 km in totale. Abbiamo sempre preso alberghi (tutti prenotati, vista la piena estate) in pieno centro città, con le sole eccezioni di Issoire e Grignan, perché la comodità della visita a piedi compensa la difficoltà del parcheggio. Due notti di fila solo ad Angers, Bordeaux e Périgueux, quest'ultima per l'escursione nella vicina valle della Vézère dove sono concentrati in poco spazio numerosi punti d'interesse, a cominciare dalla grotta di Lascaux. Per brevità abbiamo tagliato musei, escursioni naturalistiche o balneari, e strutture moderne tipo il Futuroscope di Poitiers o il viadotto autostradale di Millau. Naturalmente c'è stato da fare i conti col riscaldamento globale. Quest'estate mezza Francia è andata arrosto; eppure nel nostro viaggio, pur avendo sfiorato le Lande ed il Médoc, non abbiamo visto incendi in corso, tranne estese tracce a sud-ovest di Cahors, arrivandovi da Moissac, e qualcosina attorno a Grignan. Invece dalle parti di Rocamadour la vegetazione appariva bruciata non dal fuoco ma dalla siccità, e presentava un aspetto autunnale del tutto fuori stagione. Partiti e rientrati sotto un sole tremendo ed un caldo insopportabile, per tutta la parte centrale del viaggio abbiamo goduto di un tempo variabile, con piogge e fresco. Prima del riscaldamento globale si sarebbe detto “goduto” parlando del bel tempo, ma adesso dobbiamo ammettere che le nuvole sono meglio del sole; le piogge, poi, si sono scatenate per lo più di notte o durante i tragitti in macchina, e ci hanno disturbato ben poco. Non descriverò qui i tesori d'arte: questo è compito delle guide; dirò solo delle impressioni e delle curiosità. Una costante: quasi dovunque si capitava, si era sul Cammino di Santiago di Compostela. Vien da pensare: lo stiamo seguendo; eppure per lo più la nostra direzione era perpendicolare. E allora? La verità è che sono tanti itinerari (sarebbe più corretto parlarne al plurale), ma soprattutto che è un richiamo turistico, e nessuna città vuole star fuori da questo nuovo business. Volevamo escludere la zona alpina per non mettere troppa carne al fuoco; abbiamo perciò scelto Grenoble come prima tappa solo per spezzare le distanze. Si è deciso infatti di contenere le tappe entro i 300 km,, e questa è stata l'unica eccezione toccando i 370, ma era l'unica tappa tutta di autostrada. Per la verità l'ultima è stata ben più lunga (465 km), ma era quella di rientro e non c'era il problema di trovar alberghi e parcheggi litigando con le zone pedonali in città sconosciute, per tacere poi del successivo riposo totale. Grenoble ha un centro storico piccolo rispetto alle dimensioni attuali della città, ed i massimi punti d'interesse sono tutti ben raccolti. Perfino la telecabina per la Cittadella, il punto panoramico sulla città, parte a pochi passi dalla chiesa di St. André. Su e giù per le colline fra Delfinato e Rodano si arriva all'abbazia di Saint-Antoine, che domina il paese come una fortezza. L'ingresso est ha tetti e torrette a vivaci colori; ad ovest uno scalone sale alla chiesa. Più a nord-ovest c'è il
“palazzo ideale” di Hauterives.
È l'opera fantasiosa del postino del paese che
l'ha fabbricata dal 1879 al 1912, con le pietre
Vienne conserva diversi reperti romani (teatro, tempio d'Augusto), ma qualche anno fa, a Sainte-Colombe, l'abitato sulla riva opposta del Rodano, è stata scoperta per caso una vera Piccola Pompei. Tutti i siti che ne parlano la ritengono una scoperta sensazionale, per vastità e stato di conservazione, eppure nessuno dice se sia visitabile; niente informazioni in loco per questioni d'orario. Pare dunque che si dovrà aspettare. Più ad ovest tocchiamo Le Puy-en-Velay, ma la conoscevamo già e facciamo una breve sosta solo per il suo straordinario panorama, con gli incredibili picchi vulcanici, il più aguzzo dei quali ha una chiesa sulla cima. E siamo sul Cammino. Proseguiamo in un ambiente via via più alpestre fino a toccare La Chaise-Dieu e visitare la sua celebre abbazia benedettina (la “casa Dei”) con arazzi ed una notevole danza macabra. Montpeyroux, arroccato in cima al colle, ricorda un po' un paese dell'Italia centrale anche per le belle case. Issoire vanta una chiesa con interni policromi e segni zodiacali all'esterno dell'abside, un soggetto che non ci si aspetterebbe di trovare in un santuario.
Tutt'attorno il paesaggio, al culmine del Massiccio Centrale, è caratteristico: dossi arrotondati alternati a crateri vulcanici, tutti a prati alle quote alte, con panorami sterminati, e coperti di foreste più in basso. Ad Aubusson, la capitale dell'arazzo, abbiamo trovato un albergo (hotel de France) che risale al settecento. La cittadina ha numerose case a graticcio e con la sua posizione incassata fra le colline offre belle vedute. Un gran campanile fra le colline annuncia di lontano Saint-Léonard-de-Noblat; il centro è pieno di belle case a graticcio. All'ingresso della chiesa, la conchiglia sul selciato ricorda che ci troviamo sul Cammino. Limoges ha
due centri storici Poitiers occupa un'altura circondata dai fiumi Clain e Boivre, un po' incassati, il che fornisce panorami, anche se non ci sono terrazze. Nel centro medievale spicca la chiesa di Notre-Dame-la-Grande, dalla magnifica facciata romanica. Pure interessante il complicato palazzo di giustizia che occupa una parte dell'antico castello. Anche di qui passa il Cammino. Dirigendosi verso Angers, facciamo una deviazione al castello di Oriol, ma la fretta ci costringe a guardarlo solo da fuori. Anche alla vicina Thouars ci accontentiamo di un giro con un paio di soste per ammirarne la bella posizione, specie dal ponte sul Thouet, dominato dal castello e dalle case antiche attorno.
Angers è attraversata dalla Maine, un fiume maestoso eppure brevissimo: formatosi pochi km a monte dall'unione di Mayenne, Sarthe e Loir, finisce pochi km a valle nella Loira. La città possiede case a graticcio, una cattedrale gotica ed un grande castello con mura a grosse torri cilindriche, purtroppo mozzate nei secoli, e che contiene fra l'altro una lunga serie di arazzi sul tema dell'Apocalisse conservati in un locale moderno che da fuori stona parecchio fra gli elementi del castello. Un'escursione serale d'una decina di km porta ai Ponts-de-Cé, dove la strada che esce verso sud scavalca i vari bracci della Loira, più un paio d'affluenti, su una serie di ponti di fila, di antica origine, con strette isole fra l'uno e l'altro. Oggi qualche braccio è stato interrato, un altro è in secca assoluta, ma il luogo, vigilato anche da un castellotto, è comunque interessante.
Nessuna sosta in Vandea, dove non ci sono -o non sono rimaste- vestigia storiche particolari, né paesaggi tipici. L'interesse di questa zona è soprattutto balneare, e la cosa non era nelle nostre intenzioni. La Rochelle
vanta un bel porto vecchio, il cui ingresso dal
mare è
Nella vicina Surgères il castello è ridotto ad una cinta di mura, con torri; l'interno è un parco e contiene la chiesa di Notre-Dame, vari edifici ed un arco che dava accesso ad un recinto interno.
La chiesa romanica di St. Pierre ad Aulnay, isolata dal paese, è riccamente decorata e circondata da un cimitero con curiose lastre tombali. Indovinate cosa passa di qua. A Saintes si conserva un arco romano privo di strada d'accesso: infatti è stato ricostruito dov'è oggi nell'800; in origine era collegato al ponte sulla Charente, che doveva esser rifatto. Bella la chiesa un po' periferica di St. Eutrope, con la cripta dove riposa il santo titolare. Siamo sempre perseguitati dal Cammino.
Saint-Émilion si trova su un colle in mezzo ai vigneti; i dintorni per chilometri e chilometri pullulano di aziende vinicole. La cittadina è però notevole per la chiesa monolitica, tutta scavata nella roccia.
Périgueux era una vecchia conoscenza, ma vista frettolosamente. Adesso giriamo con più calma per il bel centro storico. Abbiamo incrociato un'altra volta il Cammino. Ci fermiamo a Les Eyzies-de-Tayac a prenotare la visita di Lascaux (è necessario); il grazioso paese è un po' il centro museale delle grotte della zona e qui c'è la “mediateca”: chi come noi non è capace di operare da sé, trova il modo di prenotare al computer, cortesemente assistito dal paziente personale. Siamo entrati nella boscosa e zigzagante valle della Vézère, e le attrazioni sono una in fila all'altra, a poca distanza, tutte sul tema dei cavernicoli. Non mancano i “parchi a tema”, forse un po' in stile Disneyland, ma era inevitabile. Si possono visitare insediamenti alla Madeleine, fra i boschi, e alla Roque-Saint-Cristophe, su una parete di roccia poi fortificata. Invece Saint-Léon-sur-Vezère è un bellissimo paesino medievale, con castello però inaccessibile. Ci si può rifare col vicino castello di Losse, affacciato con una terrazza sul fiume. All'ora stabilita eccoci alla
grotta di Lascaux-2, una
replica dell'originale, chiusa fin dal '63 per
bloccarne il degrado. Ci si deve accontentare
quindi
Nel viaggio verso Moissac incontriamo il castello di Bonaguil che si presenta scenograficamente appollaiato su un dirupo. È un castello medievale in piena regola e non una dimora rinascimentale come più spesso succede. Altra scoperta dell'origine d'una parola: la casamatta viene dallo spagnolo “casa donde se mata”, la casa dove si uccide. Procedendo a sud l'aspetto dei paesi diventa via via più “mediterraneo” ed i tetti sono sempre più a tegole e sempre meno di ardesia.
Cahors
occupa il centro di una delle numerose anse del
fiume Lot, a forma di “U” allungata. La maggiore
attrattiva è lo scenografico e turrito Pont
Se si arriva da nord a Millau, la città si presenta con lo sfondo dell'elegante viadotto autostradale, che non la sfigura, anzi ne costituisce un'attrattiva. È la capitale del guanto, e ha diverse piccole curiosità: una torre multipla, quadrata e massiccia sotto, ottagonale e slanciata sopra, con attaccata un'altra cilindrica e sottile; una porta con casa incorporata, ed un bel ponte mozzato sul Tarn.
Grignan è il classico paese dominato dal suo bravo castello, in mezzo ad amene colline. Questo castello è stato ricostruito dalle rovine solo un secolo fa; adesso fa la sua bella figura anche per i begli arredi e i ricordi della sua illustre inquilina, la scrittrice M.me de Sévigné, moglie del castellano. Una nota finale sul mangiare. Dappertutto abbiamo trovato nei menu dei ristoranti la mozzarella, la burrata, e nel dessert, il tiramisù. In Francia è scoppiata la mania di questi nostri prodotti e tutti ne vanno matti: l'Italia è riuscita ad entrare nel mercato alimentare francese sconfiggendo il Camembert. Ho anche saputo di turisti francesi che, arrivati in Italia, ordinavano il tiramisù e si stupivano di non trovarlo sempre, avendo dato per scontato che fosse diffuso come la pizza. 15 settembre 2022 Giovanni Saccarello La partenza del nostro tour – durato circa due settimane - il giorno di Ferragosto, dopo l’attraversamento autostradale della Svizzera, è stata la Foresta Nera. Un delizioso albergo a Dachsberg (Landgasthof Klosterweiherhof, www.klosterweiherhof.com ) ci ha accolto, di fronte a un laghetto,
dove si può nuotare tra le anatre, in mezzo a
boschi di conifere, nella tranquillità più
totale. Una breve passeggiata su una stradina
nei pressi ci ha portato verso una miniera
risalente all’ ‘800 (la “Friedrich-August-Grube”),
dove si estraevano soprattutto minerali
contenenti nichel. Si può entrare liberamente
per un percorso di una decina di metri,
illuminato e in totale sicurezza. Alcuni
tabelloni esplicativi informano del fatto che si
tratta di un “parco giochi minerario” in una
riserva naturale: con scopi anche didattici, il
luogo si presta ad attività ludiche di vario
genere (pure musicali, con xilofoni un po’
particolari). Il giorno seguente il nostro
itinerario ha toccato la graziosa Todtnau, dove
una facile escursione di circa un’ora, su un
sentiero ad anello che parte dalla zona dietro
la chiesa (piazza del Mercato) e attraversa la
faggeta, conduce a una cascata, monumento
naturale tedesco dal 1987: qui chi soffre il
caldo può rinfrescarsi immergendosi in pozze
laterali, sui gradini di granito dei salti
d’acqua. Una sosta a Triberg ci ha poi
consentito di immergerci nell’atmosfera tipica
della Schwarzwald, circondati da negozi che
vendono migliaia di orologi a cucù di tutte le
dimensioni. laghetto,
dove si può nuotare tra le anatre, in mezzo a
boschi di conifere, nella tranquillità più
totale. Una breve passeggiata su una stradina
nei pressi ci ha portato verso una miniera
risalente all’ ‘800 (la “Friedrich-August-Grube”),
dove si estraevano soprattutto minerali
contenenti nichel. Si può entrare liberamente
per un percorso di una decina di metri,
illuminato e in totale sicurezza. Alcuni
tabelloni esplicativi informano del fatto che si
tratta di un “parco giochi minerario” in una
riserva naturale: con scopi anche didattici, il
luogo si presta ad attività ludiche di vario
genere (pure musicali, con xilofoni un po’
particolari). Il giorno seguente il nostro
itinerario ha toccato la graziosa Todtnau, dove
una facile escursione di circa un’ora, su un
sentiero ad anello che parte dalla zona dietro
la chiesa (piazza del Mercato) e attraversa la
faggeta, conduce a una cascata, monumento
naturale tedesco dal 1987: qui chi soffre il
caldo può rinfrescarsi immergendosi in pozze
laterali, sui gradini di granito dei salti
d’acqua. Una sosta a Triberg ci ha poi
consentito di immergerci nell’atmosfera tipica
della Schwarzwald, circondati da negozi che
vendono migliaia di orologi a cucù di tutte le
dimensioni.
 I
più belli costano almeno 2000-3000 euro, fino ad
arrivare a cifre davvero esorbitanti! Anche a
Triberg si trova una famosa cascata, ma per
vederla l’ingresso è a pagamento. Attraversando
villaggi e percorrendo la suggestiva strada
nella foresta siamo giunti a Freudenstadt (“Città
della gioia”): centro termale, è da visitare
soprattutto per la bellissima Marktplatz
–
la più grande della Germania- su cui si affaccia
l’imponente e interessante chiesa evangelica.
Fontane e fiori rendono lo spazio urbano molto
piacevole. Abbiamo trascorso la notte nella
vicina Baiersbronn, base di partenza per molte
escursioni (alloggio al Cafe Rundblick,
www.cafe-rundblick.de
), per ripartire la mattina alla volta di
Baden-Baden. Città molto elegante, circondata da
boschi, presenta un centro ricco di edifici in
stile neoclassico e attraversato dalla splendida
Lichtentaler Allee, un lunghissimo viale
alberato che costeggia il fiume Oos, con aiuole,
bordure fiorite e fontane. Il nome della città
richiama la sua storia di “capitale tedesca
delle terme”: le sue sorgenti erano note fin
dall’epoca romana. Nel 1838 fu aperto il
magnifico casinò frequentato dalla nobiltà
europea (Kurhaus), di cui si può visitare, a
pagamento, il Salone Rosso. I
più belli costano almeno 2000-3000 euro, fino ad
arrivare a cifre davvero esorbitanti! Anche a
Triberg si trova una famosa cascata, ma per
vederla l’ingresso è a pagamento. Attraversando
villaggi e percorrendo la suggestiva strada
nella foresta siamo giunti a Freudenstadt (“Città
della gioia”): centro termale, è da visitare
soprattutto per la bellissima Marktplatz
–
la più grande della Germania- su cui si affaccia
l’imponente e interessante chiesa evangelica.
Fontane e fiori rendono lo spazio urbano molto
piacevole. Abbiamo trascorso la notte nella
vicina Baiersbronn, base di partenza per molte
escursioni (alloggio al Cafe Rundblick,
www.cafe-rundblick.de
), per ripartire la mattina alla volta di
Baden-Baden. Città molto elegante, circondata da
boschi, presenta un centro ricco di edifici in
stile neoclassico e attraversato dalla splendida
Lichtentaler Allee, un lunghissimo viale
alberato che costeggia il fiume Oos, con aiuole,
bordure fiorite e fontane. Il nome della città
richiama la sua storia di “capitale tedesca
delle terme”: le sue sorgenti erano note fin
dall’epoca romana. Nel 1838 fu aperto il
magnifico casinò frequentato dalla nobiltà
europea (Kurhaus), di cui si può visitare, a
pagamento, il Salone Rosso.
 A una ventina di km
si raggiunge Rastatt, che vanta due bellissimi
castelli: uno nel cuore della città (Residenzschloss)
risalente all’inizio del ‘700, voluto dal
Margravio Luigi Guglielmo di Baden-Baden,
l’altro, a breve distanza, in un parco stupendo
(Schloss Favorite), residenza estiva fatta
erigere pochi anni dopo dalla vedova Sybilla di
Sassonia. Gli edifici, entrambi barocchi, hanno
appartamenti dagli arredi e decorazioni di gusto
raffinatissimo e meritano senz’altro una visita
(obbligatoriamente guidata). A una ventina di km
si raggiunge Rastatt, che vanta due bellissimi
castelli: uno nel cuore della città (Residenzschloss)
risalente all’inizio del ‘700, voluto dal
Margravio Luigi Guglielmo di Baden-Baden,
l’altro, a breve distanza, in un parco stupendo
(Schloss Favorite), residenza estiva fatta
erigere pochi anni dopo dalla vedova Sybilla di
Sassonia. Gli edifici, entrambi barocchi, hanno
appartamenti dagli arredi e decorazioni di gusto
raffinatissimo e meritano senz’altro una visita
(obbligatoriamente guidata).
Da Rastatt arrivare in
Francia, oltrepassando il Reno, è questione di
pochi
 parecchi nidi di questi splendidi
uccelli, in cima ad alti pali opportunamente
predisposti. Tutta la zona è ambiente di
nidificazione di questi migratori, che sono
anche il simbolo dell’Alsazia. Il nostro viaggio
è proseguito facendo sosta alla Citadelle de
Bitche, vero capolavoro di arte militare:
ricostruita più volte fino alla struttura
definitiva, del XVIII secolo, la fortezza è
gigantesca ed è monumento storico dal 1979.
La visita è multimediale e molto interessante:
grazie a filmati proiettati in modo parecchi nidi di questi splendidi
uccelli, in cima ad alti pali opportunamente
predisposti. Tutta la zona è ambiente di
nidificazione di questi migratori, che sono
anche il simbolo dell’Alsazia. Il nostro viaggio
è proseguito facendo sosta alla Citadelle de
Bitche, vero capolavoro di arte militare:
ricostruita più volte fino alla struttura
definitiva, del XVIII secolo, la fortezza è
gigantesca ed è monumento storico dal 1979.
La visita è multimediale e molto interessante:
grazie a filmati proiettati in modo
 suggestivo
nelle diverse sale, si rivive l’assedio di 230
giorni che seguì la dichiarazione di guerra del
19 luglio 1870 da parte della Francia contro la
Prussia. L’8 agosto seguente, le truppe
prussiane circondarono la Citadelle, che
occupava un sito strategico. L’eroica resistenza
si protrasse fino al 27 marzo 1871, ossia ben
più due mesi dopo l’armistizio del 18 gennaio e
la fine del Secondo impero di Napoleone III. Il
10 maggio il trattato di Francoforte segnò in
modo definitivo la sconfitta dei Francesi e la
costituzione dell’impero tedesco; Bitche tornò
alla Francia nel 1918. suggestivo
nelle diverse sale, si rivive l’assedio di 230
giorni che seguì la dichiarazione di guerra del
19 luglio 1870 da parte della Francia contro la
Prussia. L’8 agosto seguente, le truppe
prussiane circondarono la Citadelle, che
occupava un sito strategico. L’eroica resistenza
si protrasse fino al 27 marzo 1871, ossia ben
più due mesi dopo l’armistizio del 18 gennaio e
la fine del Secondo impero di Napoleone III. Il
10 maggio il trattato di Francoforte segnò in
modo definitivo la sconfitta dei Francesi e la
costituzione dell’impero tedesco; Bitche tornò
alla Francia nel 1918.
Passando nuovamente il
confine e tornando in Germania, il nostro tour
non
 successivi,
diventando importante centro commerciale e sede
vescovile in epoca carolingia, vivendo fasti per
tutto il medioevo e oltre. Fu pesantemente
bombardata nella II guerra mondiale ed è in gran
parte ricostruita. Bellissima la Hauptmarkt, la
piazza del Mercato; il Duomo di San Pietro e
l’adiacente Liebfrauenkirche, dalle forme
romaniche e gotiche, sono di grande interesse e
hanno interni suggestivi, ricchi di opere d’arte.
In Brückenstrasse si trova la casa in cui nacque,
il 5 maggio 1818, Karl Marx. Trasformata in
casa-museo, si possono osservare arredi,
documenti, testi, disegni, dipinti, statue,
fotografie, che servono al visitatore per
ripercorrere le tappe fondamentali della vita
del grandissimo Marx-filosofo-sociologo-economista-giornalista.
Ci si può accomodare, per un dialogo immaginario,
davanti alla poltrona di velluto su cui sedeva
per il suo lavoro e le sue letture e su cui morì,
a Londra, il 14 marzo 1883. La casa fu
confiscata dai nazisti nel 1933 e restò una loro
sede fino al 1945. successivi,
diventando importante centro commerciale e sede
vescovile in epoca carolingia, vivendo fasti per
tutto il medioevo e oltre. Fu pesantemente
bombardata nella II guerra mondiale ed è in gran
parte ricostruita. Bellissima la Hauptmarkt, la
piazza del Mercato; il Duomo di San Pietro e
l’adiacente Liebfrauenkirche, dalle forme
romaniche e gotiche, sono di grande interesse e
hanno interni suggestivi, ricchi di opere d’arte.
In Brückenstrasse si trova la casa in cui nacque,
il 5 maggio 1818, Karl Marx. Trasformata in
casa-museo, si possono osservare arredi,
documenti, testi, disegni, dipinti, statue,
fotografie, che servono al visitatore per
ripercorrere le tappe fondamentali della vita
del grandissimo Marx-filosofo-sociologo-economista-giornalista.
Ci si può accomodare, per un dialogo immaginario,
davanti alla poltrona di velluto su cui sedeva
per il suo lavoro e le sue letture e su cui morì,
a Londra, il 14 marzo 1883. La casa fu
confiscata dai nazisti nel 1933 e restò una loro
sede fino al 1945.
Sulla strada per Bonn, il giorno seguente, ci siamo fermati all’abbazia cistercense di Himmerod: una sosta piacevole e interessante, come quella successiva alla Meerfeld Maar, tranquillo lago in un parco naturale. Bonn ci è piaciuta per l’atmosfera gradevole, di città moderna ma con ritmi non frenetici, con un bel centro storico curato. La scelta dell’albergo è caduta sull’Hotel Baden ( https://www.hotel-baden.de) a pochi minuti a piedi dalla bella casa natale di Beethoven (Bonngasse 20): qui il geniale
compositore nacque nel dicembre 1770. Ci si
immerge nella sua biografia e nelle sue opere;
in una saletta si possono ascoltare, con cuffie,
anche brani registrati di sinfonie e concerti.
La casa-museo è utilizzata anche per eventi
musicali, mostre, didattica della musica.
Passeggiare nel centro ci ha portato a vedere il
Münster St. Martin, chiesa tardoromanica
ricostruita, e il Rathaus sulla piazza del
Mercato; bello anche il lungofiume, con panorami
sul Reno; uscendo dalla città abbiamo invece
visitato il Kunstmuseum (dei qui il geniale
compositore nacque nel dicembre 1770. Ci si
immerge nella sua biografia e nelle sue opere;
in una saletta si possono ascoltare, con cuffie,
anche brani registrati di sinfonie e concerti.
La casa-museo è utilizzata anche per eventi
musicali, mostre, didattica della musica.
Passeggiare nel centro ci ha portato a vedere il
Münster St. Martin, chiesa tardoromanica
ricostruita, e il Rathaus sulla piazza del
Mercato; bello anche il lungofiume, con panorami
sul Reno; uscendo dalla città abbiamo invece
visitato il Kunstmuseum (dei
 primi anni ‘90),
che raccoglie opere del pittore espressionista
August Macke e pezzi interessanti di arte
contemporanea, in collezioni permanenti e mostre
temporanee. Molto particolari gli allestimenti
esterni, con alte strutture azzurre a forma di
cono, su una terrazza panoramica, dalla quale si
può scendere utilizzando un lungo scivolo di
metallo. Raggiungibile in auto in circa mezz’ora,
data la vicinanza, è la magnifica Colonia
(Köln). Abbiamo trovato qualche difficoltà nella
ricerca dell’alloggio, dati i prezzi davvero
alti e volendo trascorrervi almeno due notti:
alla fine siamo riusciti a trovare una
sistemazione nei pressi del centro, davanti alla
chiesa di san Maurizio ( Mauritius Hotel &
Therme,
https://mauritius-ht.de
), in un “albergo benessere” con sauna, piscina
e spa (a pagamento), di cui però non abbiamo
usufruito, e con terrazza-solarium panoramica.
La vicinanza al centro ci ha consentito di
raggiungerlo comodamente a piedi, dopo aver
parcheggiato l’auto
–
non senza difficoltà! - nelle vie limitrofe,
sfruttando anche la gratuità della domenica. È
da sottolineare che il costo dei parcheggi su
strada, nei giorni feriali, è molto alto, e
risulta più conveniente lasciare l’auto in
quelli privati. La città è senza dubbio stupenda,
piena di vita, dinamica, ricca di musei,
monumenti, ristoranti e negozi, e percorrerla a
piedi è un vero piacere. primi anni ‘90),
che raccoglie opere del pittore espressionista
August Macke e pezzi interessanti di arte
contemporanea, in collezioni permanenti e mostre
temporanee. Molto particolari gli allestimenti
esterni, con alte strutture azzurre a forma di
cono, su una terrazza panoramica, dalla quale si
può scendere utilizzando un lungo scivolo di
metallo. Raggiungibile in auto in circa mezz’ora,
data la vicinanza, è la magnifica Colonia
(Köln). Abbiamo trovato qualche difficoltà nella
ricerca dell’alloggio, dati i prezzi davvero
alti e volendo trascorrervi almeno due notti:
alla fine siamo riusciti a trovare una
sistemazione nei pressi del centro, davanti alla
chiesa di san Maurizio ( Mauritius Hotel &
Therme,
https://mauritius-ht.de
), in un “albergo benessere” con sauna, piscina
e spa (a pagamento), di cui però non abbiamo
usufruito, e con terrazza-solarium panoramica.
La vicinanza al centro ci ha consentito di
raggiungerlo comodamente a piedi, dopo aver
parcheggiato l’auto
–
non senza difficoltà! - nelle vie limitrofe,
sfruttando anche la gratuità della domenica. È
da sottolineare che il costo dei parcheggi su
strada, nei giorni feriali, è molto alto, e
risulta più conveniente lasciare l’auto in
quelli privati. La città è senza dubbio stupenda,
piena di vita, dinamica, ricca di musei,
monumenti, ristoranti e negozi, e percorrerla a
piedi è un vero piacere.
 La cattedrale gotica
(Dom), altissima -le due torri raggiungono i 157
m- appare maestosa e incredibile anche a chi
dovesse giungere a Colonia in treno, dato che la
stazione centrale è proprio, curiosamente,
dietro di essa. Patrimonio dell’UNESCO,
costruita in ben 632 anni (dal 1248 al 1880),
con pietre calcaree e basalto, che ne danno un
aspetto scuro e annerito, presenta guglie,
pinnacoli, audaci archi rampanti, vetrate
preziose; all’interno, nelle navate alte 40 m,
il coro, gli affreschi, le tombe, le statue,
rendono la visita affascinante. L’abside è
rivolta al Reno e al lungo ponte, sia
ferroviario che pedonale, che lo attraversa.
Camminare nei quartieri lungo il fiume, tra il
verde, le fontane e i localini per un aperitivo
o un’ottima birra con Bratwurst und kartoffeln,
è un must per chi visita Colonia. Tra i musei,
c’è solo l’imbarazzo della scelta (occorre però
considerare che lunedì è giorno di chiusura per
la maggior parte) . Noi abbiamo optato in primis
per il meraviglioso Wallraf-Richartz-Museum-Fondazione
Corboud. La collezione di dipinti vanta
capolavori del Medioevo tedesco, fiammingo,
italiano e opere straordinarie dei secoli
successivi. Il Museum Ludwig, moderno, ospita
invece opere del ‘900, in particolare
statunitensi, ma anche britanniche, russe,
tedesche; surrealismo, dadaismo, espressionismo
sono correnti molto ben rappresentate: anche in
questo caso è una meta obbligata. Siamo riusciti
pure a visitare il museo archeologico (Römisch-Germanisches
Museum), trasferito in tempi recenti in
Cäcilienstrasse 46, davanti al Museum Schnütgen,
che invece abbiamo purtroppo dovuto tralasciare
per ragioni di tempo. Lo spazio espositivo è
ridotto ed è ancora in fase di allestimento:
molto interessanti i reperti romani dell’epoca
di Colonia Agrippina, fondata precedentemente (I
sec. a.C.) con il nome di Ara Ubiorum, sulla
sponda sinistra del Reno, e luogo di nascita di
Agrippina minore, moglie dell’imperatore
Claudio, nonché figlia di Germanico e madre di
Nerone. La cattedrale gotica
(Dom), altissima -le due torri raggiungono i 157
m- appare maestosa e incredibile anche a chi
dovesse giungere a Colonia in treno, dato che la
stazione centrale è proprio, curiosamente,
dietro di essa. Patrimonio dell’UNESCO,
costruita in ben 632 anni (dal 1248 al 1880),
con pietre calcaree e basalto, che ne danno un
aspetto scuro e annerito, presenta guglie,
pinnacoli, audaci archi rampanti, vetrate
preziose; all’interno, nelle navate alte 40 m,
il coro, gli affreschi, le tombe, le statue,
rendono la visita affascinante. L’abside è
rivolta al Reno e al lungo ponte, sia
ferroviario che pedonale, che lo attraversa.
Camminare nei quartieri lungo il fiume, tra il
verde, le fontane e i localini per un aperitivo
o un’ottima birra con Bratwurst und kartoffeln,
è un must per chi visita Colonia. Tra i musei,
c’è solo l’imbarazzo della scelta (occorre però
considerare che lunedì è giorno di chiusura per
la maggior parte) . Noi abbiamo optato in primis
per il meraviglioso Wallraf-Richartz-Museum-Fondazione
Corboud. La collezione di dipinti vanta
capolavori del Medioevo tedesco, fiammingo,
italiano e opere straordinarie dei secoli
successivi. Il Museum Ludwig, moderno, ospita
invece opere del ‘900, in particolare
statunitensi, ma anche britanniche, russe,
tedesche; surrealismo, dadaismo, espressionismo
sono correnti molto ben rappresentate: anche in
questo caso è una meta obbligata. Siamo riusciti
pure a visitare il museo archeologico (Römisch-Germanisches
Museum), trasferito in tempi recenti in
Cäcilienstrasse 46, davanti al Museum Schnütgen,
che invece abbiamo purtroppo dovuto tralasciare
per ragioni di tempo. Lo spazio espositivo è
ridotto ed è ancora in fase di allestimento:
molto interessanti i reperti romani dell’epoca
di Colonia Agrippina, fondata precedentemente (I
sec. a.C.) con il nome di Ara Ubiorum, sulla
sponda sinistra del Reno, e luogo di nascita di
Agrippina minore, moglie dell’imperatore
Claudio, nonché figlia di Germanico e madre di
Nerone.
Il nostro itinerario ci ha quindi condotto ad Aquisgrana (Aachen), dove abbiamo pernottato all’Hotel Platinium ( http://platiniumhotel.de ), in una posizione che ci ha consentito di
raggiungere il centro a piedi senza fatica.
Fondata dai Romani con il nome di Aquae Granni,
in omaggio alle sue benefiche sorgenti termali
di acquee sulfuree e al dio celtico della
salute, Granno, la città conserva un certo
fascino che le viene soprattutto dalla sua
storia medioevale. Patrimonio dell’Umanità è il
duomo, che incorpora la Cappella Palatina voluta
da Carlo Magno, che qui fu ebbe la tomba; vi fu
aggiunto un presbiterio gotico e rimase sede
dell’incoronazione di trenta re del Sacro Romano
Impero, dal 936 al 1531. Un enorme lampadario
circolare in rame, a forma di corona, pende al
centro della cappella, dal soffitto riccamente
decorato: voluto da Federico Barbarossa come
simbolo della Gerusalemme celeste, risale al
1160. L’altare, il pulpito, i sarcofagi in oro
sono stupefacenti. Il vicino museo del duomo,
con un preziosissimo tesoro che comprende
eccezionali reliquiari, compreso quello di Carlo
Magno, capolavori di oreficeria medioevale,
dipinti e oggetti in avorio scolpito, è
assolutamente da visitare. posizione che ci ha consentito di
raggiungere il centro a piedi senza fatica.
Fondata dai Romani con il nome di Aquae Granni,
in omaggio alle sue benefiche sorgenti termali
di acquee sulfuree e al dio celtico della
salute, Granno, la città conserva un certo
fascino che le viene soprattutto dalla sua
storia medioevale. Patrimonio dell’Umanità è il
duomo, che incorpora la Cappella Palatina voluta
da Carlo Magno, che qui fu ebbe la tomba; vi fu
aggiunto un presbiterio gotico e rimase sede
dell’incoronazione di trenta re del Sacro Romano
Impero, dal 936 al 1531. Un enorme lampadario
circolare in rame, a forma di corona, pende al
centro della cappella, dal soffitto riccamente
decorato: voluto da Federico Barbarossa come
simbolo della Gerusalemme celeste, risale al
1160. L’altare, il pulpito, i sarcofagi in oro
sono stupefacenti. Il vicino museo del duomo,
con un preziosissimo tesoro che comprende
eccezionali reliquiari, compreso quello di Carlo
Magno, capolavori di oreficeria medioevale,
dipinti e oggetti in avorio scolpito, è
assolutamente da visitare.
Dalla bella Aquisgrana ci è
stato semplice scegliere come proseguire il
viaggio: trovandoci proprio al confine con i
Paesi Bassi e con il Belgio, abbiamo deciso di
varcare quello olandese e, dopo un passaggio
nella graziosa Valkenburg e una tappa
particolare al Drielandenpunt (la triplice
frontiera) in mezzo ai boschi, sul Vaalsenberg,
siamo giunti a Maastricht. È
Il nostro breve giro della
Vallonia ha poi compreso Theux, con
un’interessante chiesa fortificata, e Spa,
rinomato ed elegante centro termale che ha dato
il nome ai centri benessere di tutto il mondo.
Belle fontane ottocentesche in bronzo consentono
al visitatore di dissetarsi; giardini dai
perfetti prati all’inglese e aiuole dai mille
colori appagano la vista. E non poteva mancare
un casinò! L’ultima nostra tappa belga ha
riguardato Eupen e il suo lago artificiale
creato da un’imponente diga sul Vesdre, in mezzo
ai boschi. Ed eccoci subito di nuovo in
Germania: non potevamo mancare
 (le
cuffie in dotazione si attivano quando si passa
davanti allo schermo), scelti tra i più famosi;
dopo questa immersione nella musica rock e pop e
nei colori abbaglianti dei filmati, si seguono
percorsi che portano a vedere la torre
dell’acqua, risalente al 1917, tra le più grandi
al mondo, le fornaci, gli impianti di
sinterizzazione, le pompe, i siti di stoccaggio
del carbone e dei minerali ferrosi, fino a
salire su piattaforme a 45 m di altezza, per
ammirare tutto il complesso. Una meraviglia!
Abbiamo poi concluso la giornata nell’hotel più
bello di tutto il nostro viaggio, dall’arredo a
tratti stupefacente (Hotel Restaurant Rössle in
Dobel,
www.roessle-dobel.de
), in un paese di poco più di 2000 abitanti,
base di partenza di gradevoli passeggiate nella
Foresta Nera settentrionale, dove sembra di
poter incontrare, prima o poi, i sette nani o
Biancaneve... Il nostro “zig-zag” ci ha poi
condotto a rivedere città da noi precedentemente
già visitate, prima fra tutte Tubinga, deliziosa
città universitaria sul fiume Neckar su cui si
affacciano affascinanti case a graticcio. Siamo
saliti in cima alla torre campanaria della
splendida Collegiata di san Giorgio, al cui
interno si trovano opere d’arte e sepolcri,
soprattutto cinquecenteschi, dei duchi del
Wüttemberg, per ammirare il panorama. Lungo il
tragitto abbiamo raggiunto il castello di
Hohenzollern, in cima a un rilievo boscoso a
circa 850 m di altezza. È considerato uno dei
castelli più belli della Germania, anche se in
realtà dell’edificio originario medioevale resta
solo una cappella: tutto il resto è una
ricostruzione ottocentesca. Appare certo
fiabesco e merita una passeggiata lungo il
sentiero-scaletta tra gli alberi; è previsto un
servizio navetta,dal parcheggio sottostante, per
chi acquista il biglietto. È questo il punto
dolente: l’ingresso costa ben 22 euro a persona!
Abbiamo incontrato anche turisti tedeschi che si
lamentavano del prezzo eccessivo... Ci siamo
dunque limitati a guardare il castello
dall’esterno. Dopo una sosta
–
e ottima cena! - a Bonndorf im Schwarzwald (Gasthaus
zum Kranz,
www.kranz-bonndorf.de
) eccoci a Friburgo in Brisgovia, dove si erge,
in una grande piazza, il magnifico Münster; poi
a Breisach, sede di un’interessante abbazia
arroccata; e infine, tornando in Francia,
abbiamo rivisto con piacere la bellissima
Colmar, fiore all’occhiello dell’Alsazia, e
Mulhouse, per il nostro ultimo pernottamento
(Brit Hotel Mulhouse Centre,
https://mulhouse.brithotel.com
). Sulla strada del ritorno, a Basilea, non
potevamo perdere un altro triplice confine:
quello di Francia-Germania-Svizzera, il
Dreiländereck, sul Reno, contrassegnato da un
alto pinnacolo con le tre bandiere. E qui, in un
punto geografico dove il principio
d’indeterminazione sembra farsi realtà, abbiamo
considerato concluso il nostro fantastico
viaggio. (le
cuffie in dotazione si attivano quando si passa
davanti allo schermo), scelti tra i più famosi;
dopo questa immersione nella musica rock e pop e
nei colori abbaglianti dei filmati, si seguono
percorsi che portano a vedere la torre
dell’acqua, risalente al 1917, tra le più grandi
al mondo, le fornaci, gli impianti di
sinterizzazione, le pompe, i siti di stoccaggio
del carbone e dei minerali ferrosi, fino a
salire su piattaforme a 45 m di altezza, per
ammirare tutto il complesso. Una meraviglia!
Abbiamo poi concluso la giornata nell’hotel più
bello di tutto il nostro viaggio, dall’arredo a
tratti stupefacente (Hotel Restaurant Rössle in
Dobel,
www.roessle-dobel.de
), in un paese di poco più di 2000 abitanti,
base di partenza di gradevoli passeggiate nella
Foresta Nera settentrionale, dove sembra di
poter incontrare, prima o poi, i sette nani o
Biancaneve... Il nostro “zig-zag” ci ha poi
condotto a rivedere città da noi precedentemente
già visitate, prima fra tutte Tubinga, deliziosa
città universitaria sul fiume Neckar su cui si
affacciano affascinanti case a graticcio. Siamo
saliti in cima alla torre campanaria della
splendida Collegiata di san Giorgio, al cui
interno si trovano opere d’arte e sepolcri,
soprattutto cinquecenteschi, dei duchi del
Wüttemberg, per ammirare il panorama. Lungo il
tragitto abbiamo raggiunto il castello di
Hohenzollern, in cima a un rilievo boscoso a
circa 850 m di altezza. È considerato uno dei
castelli più belli della Germania, anche se in
realtà dell’edificio originario medioevale resta
solo una cappella: tutto il resto è una
ricostruzione ottocentesca. Appare certo
fiabesco e merita una passeggiata lungo il
sentiero-scaletta tra gli alberi; è previsto un
servizio navetta,dal parcheggio sottostante, per
chi acquista il biglietto. È questo il punto
dolente: l’ingresso costa ben 22 euro a persona!
Abbiamo incontrato anche turisti tedeschi che si
lamentavano del prezzo eccessivo... Ci siamo
dunque limitati a guardare il castello
dall’esterno. Dopo una sosta
–
e ottima cena! - a Bonndorf im Schwarzwald (Gasthaus
zum Kranz,
www.kranz-bonndorf.de
) eccoci a Friburgo in Brisgovia, dove si erge,
in una grande piazza, il magnifico Münster; poi
a Breisach, sede di un’interessante abbazia
arroccata; e infine, tornando in Francia,
abbiamo rivisto con piacere la bellissima
Colmar, fiore all’occhiello dell’Alsazia, e
Mulhouse, per il nostro ultimo pernottamento
(Brit Hotel Mulhouse Centre,
https://mulhouse.brithotel.com
). Sulla strada del ritorno, a Basilea, non
potevamo perdere un altro triplice confine:
quello di Francia-Germania-Svizzera, il
Dreiländereck, sul Reno, contrassegnato da un
alto pinnacolo con le tre bandiere. E qui, in un
punto geografico dove il principio
d’indeterminazione sembra farsi realtà, abbiamo
considerato concluso il nostro fantastico
viaggio.
Anna Busca, 6 settembre 2022 LUGLIO 2022 di Anna BuscaDieci giorni di vacanza organizzati all’ultimo momento a metà luglio possono dare grandi piaceri e soddisfazioni, se le mete scelte consentono un magnifico mix di arte, cultura, bellezze naturali, nuotate in acque cristalline ed elioterapia dall’alba al tramonto. Immergendoci in paesaggi incantevoli, ammirando capolavori di pittura e scultura, compiendo veri viaggi nel tempo antico, siamo riusciti a caricarci di energie positive, utilissime come non mai per affrontare i tempi difficili che stiamo vivendo. Non un’evasione dai problemi, quindi, ma una necessaria rigenerazione personale. NAPOLI Il treno ad alta velocità Italo ci ha consentito di raggiungere Napoli in neppure quattro ore e mezza, partendo alle 10.26 da Milano Rogoredo e arrivando a Napoli Centrale alle 14.53. Puntualità e grande comodità rendono questo mezzo davvero validissimo, anche per il risparmio di tempo e denaro rispetto ad automobile e aereo. A piedi, con una bella passeggiata da piazza Garibaldi fino a via dei Tribunali (uno dei decumani, praticamente parallelo a Spaccanapoli), abbiamo raggiunto l’albergo dove avevamo prenotato tre notti (con colazione inclusa): l’Hotel Neapolis in via Francesco del Giudice 13 (tel.0814420815), nel cuore del centro storico, al terzo piano di un palazzo (c’è l’ascensore!) da cui si gode una bella vista della città. La posizione eccellente e l’ottimo rapporto qualità/prezzo connotano questo indirizzo, davvero consigliabile per chi desidera visitare i luoghi irrinunciabili di Napoli senza usare mezzi pubblici, ma semplicemente camminando. E le mete “irrinunciabili” sono tante: ma se si resta a Napoli solo tre giorni certamente occorre compiere una selezione, anche in base agli orari di apertura di chiese e musei. La nostra prima visita ha riguardato il Museo di Arte contemporanea Donnaregina (MADRE), in un bell’edificio di via Settembrini 79 (chiuso il martedì). La collezione permanente include opere di Mimmo Paladino, Jeff Koons, Rebecca Horn, Lawrence Carroll; interessanti anche le mostre, in particolare “Clement Cogitore, Ferdinandea” (fino al 12 settembre) con lavori (anche brevi filmati) ispirati alle vicende dell’omonima isola vulcanica, emersa nel canale di Sicilia nel 1831, fino a 65 m sopra il livello del mare, e poi sprofondata sei mesi dopo. In quel breve lasso di tempo fu contesa dal Regno delle Due Sicilie, dalla Francia e dalla Gran Bretagna, che intendevano colonizzarla… Vicino all’albergo, in via
dei Tribunali 253, ecco una meta st Davanti al Pio Monte si trova la Guglia di San Gennaro, opera seicentesca in marmo, un ex voto offerto dai napoletani in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 1631; e oltre si vede parte della fiancata laterale destra del Duomo, dedicato a Maria Assunta, con un ingresso secondario. Entrando nella grande cattedrale ci si rende conto delle modifiche subite nel corso dei secoli, fin dal periodo della sua fondazione in epoca angioina (XIII-XIV secolo). Un’ampia cappella (Santa Restituta), che si apre nella navata sinistra, era in origine una basilica paleocristiana, incorporata nell’edificio; riccamente decorata nel XVII secolo, ha un bellissimo mosaico trecentesco. Sul lato destro, con ingresso a pagamento, l’antico Battistero di san Giovanni in Fonte del IV-V secolo rivela altri splendidi mosaici, per lo più frammentati, dal colore blu predominante . La cappella del Tesoro di san Gennaro, sulla navata destra è meta di veri e propri pellegrinaggi, perché conserva un busto-reliquiario del santo, risalente al 1305- a mille anni dalla sua decapitazione, risalente appunto al 305 d.C. sotto Diocleziano - in oro e argento, opera di tre maestri orafi provenzali su commissione di Carlo II d’Angiò. La testa del busto, con le fattezze dell’arcivescovo Domont, all’epoca potentissimo, ha una calotta mobile, e al suo interno si trovano alcune ossa craniche. Nella cappella sono anche custodite due ampolle sigillate, di cui una viene esposta dal vescovo al pubblico di fedeli il 19 settembre, festa del patrono, e portata in processione; il contenuto è un miscuglio rossastro, da sempre considerato “sangue coagulato di san Gennaro”, la cui “liquefazione miracolosa” sarebbe segno di buoni auspici per la città. Se invece tale fenomeno non avviene, allora è interpretato come presagio di sventure... Un vero invito, purtroppo, alla superstizione! Occorre ricordare che un lavoro sperimentale di alcuni ricercatori del CICAP, già trent’anni fa, dimostrò che una semplice sospensione colloidale di idrossido ferrico e ioni sodio e cloruro (sale da cucina disciolto) ha colore, proprietà e comportamento tissotropico analogo al contenuto delle teche, passando da gel a sol e viceversa, in base a movimenti subìti dal contenitore… Da ricordare che nel museo adiacente, al n.149 di via Duomo – aperto al pubblico dal 2003 - è esposto il preziosissimo tesoro di san Gennaro, dal valore inestimabile, frutto di cospicue donazioni di monarchi e famiglie aristocratiche: noi lo ammireremo la prossima volta!In via dei Tribunali 316 si entra in San Lorenzo Maggiore, complesso monumentale fatto erigere da Carlo I d’Angiò nel 1265; bellissima l’abside a nove cappelle – qui si ammirano il sepolcro di Caterina d’Austria, del 1323 circa, e gli affreschi di un allievo di Giotto . Magnifico anche il chiostro, che ha accanto un’area di scavi archeologici che hanno messo in luce resti dell’antica città greco-romana.Abbiamo poi dedicato quasi
un’intera giornata alla Reggia-Museo e al Bosco
Reale di Capodimonte (chiusura: mercoledì),
percorrendo a piedi,
Usciti a malincuore dalla
Reggia-Museo, lungo la strada in discesa ci
siamo fermati alle
A due passi dall’hotel, non potevamo mancare la Cappella Sansevero, voluta dal principe Raimondo de Sangro (1710-1771), figura incredibile di inventore geniale, massone, dedito alla letteratura come all’alchimia, alla filosofia come all’ingegneria idraulica, all’architettura, alle arti militari. Fin dagli ultimi anni del ‘500 esisteva una cappelletta costruita su un luogo considerato miracoloso, e la famiglia dei de Sangro, principi di Sansevero, aveva cominciato, nel ‘600, modificandola, a utilizzarla come tomba di famiglia: si trovava infatti proprio adiacente al loro palazzo. Raimondo, nel 1749, decise di ampliarla e di renderla una sorta di tempio, con sculture e decorazioni di grande pregio, che la rendono un vero gioiello d’arte. Tra queste, il famosissimo e straordinario Cristo velato di Giuseppe Sammartino (1753), invidiato anche da Antonio Canova. Meravigliose le statue della Pudicizia, di Antonio Corradini, e del Disinganno, di Francesco Queirolo. Poco oltre, un’altra meta
imperdibile: il Complesso Monumentale di
Un altro complesso monumentale da non mancare è Sant’Anna dei Lombardi, in piazza Monteoliveto, nei pressi della bella via Toledo. Qui i capolavori sono la sagrestia, dipinta da Giorgio Vasari , e il “Compianto del Cristo morto”, opera straordinaria in terracotta di Guido Mazzoni (1492), con otto figure a grandezza naturale . Un giro più ampio della città ci ha portato a vedere San Gregorio Armeno , il Maschio Angioino (Castel Nuovo), ora in fase di restauro, la vasta e splendida piazza del Plebiscito, con la Basilica di San Francesco di Paola e Palazzo Reale, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, piazza Dante. Abbiamo preso la metropolitana alla stazione Toledo per ammirarne la scenografica decorazione di William Kentridge e Bob Wilson (2013): sembra di immergersi nelle acque blu del golfo di Napoli! Purtroppo la nostra necessaria selezione ha escluso il Vomero, zona notevolissima per musei e punti panoramici: torneremo senz’altro per esplorarla.
La nostra visita si è in realtà conclusa il giorno del rientro a Milano, quando siamo tornati, a piedi, dal porto alla Stazione Centrale, passando per una piazza storica, piazza del Mercato. La piazza è molto ampia: noi l’abbiamo vista completamente deserta, nella calura estiva, e questo forse ha influenzato la nostra impressione, che è stata, ahimè, negativa. Ci è parsa trascurata, con rifiuti qua e là e chiese in fase di ristrutturazione ma abbandonate; molti gli edifici fatiscenti intorno. Insomma, il degrado è evidente . E pensare che in questo luogo si sono vissuti episodi importanti per i napoletani: la decapitazione del giovanissimo Corradino di Svevia, l’ultimo degli Hohenstaufen regnanti, sconfitto dall’esercito angioino nella battaglia di Tagliacozzo (1268), la rivolta di Masaniello (1647), le esecuzioni capitali di coloro – come il giurista Mario Pagano e la letterata Eleonora Fonseca Pimentel - che avevano sostenuto l’effimera Repubblica Napoletana (1799), filofrancese e antagonista dei Borbone; e nella vicina Basilica del Carmine Maggiore, il cui campanile svetta sulla piazza, si svolsero i funerali del mitico e indimenticabile Totò, nel 1967.ISCHIA Dell’Arcipelago Campano, cui appartengono Capri e Procida, Ischia è l’isola maggiore, di circa 46 km2, con una popolazione residente di 60.000 abitanti. E’ vulcanica, dominata dal Monte Epomeo, alto 787 m, che è in realtà ha origini anche tettoniche, in quanto corrisponde al sollevamento di rocce vulcaniche sotto la pressione del magma della camera magmatica di un vulcano sottomarino quiescente. Il monte si trova all’interno di una caldera, quindi è un “blocco risorgente”, di notevolissima altezza. L’ultima violenta eruzione risale al febbraio del 1302 (eruzione dell’Arso), ma la più imponente, responsabile della formazione detta “Tufo Verde” e della caldera, avvenne 55.000 anni fa. L’isola è interessata da fenomeni sismici: nel 1883 Casamicciola fu distrutta da un terremoto di magnitudo 5.8 che provocò 2000 vittime – vi perirono anche i genitori e la sorella del filosofo Benedetto Croce – e nel 2017 la stessa località ha subìto un evento di magnitudo 4.0.Dal Molo Beverello di Napoli – praticamente davanti al Maschio Angioino - con un aliscafo dell’Alilauro, siamo arrivati a Forìo, sulla costa occidentale dell’isola, in poco più di un’ora, partendo alle 11.20 e sbarcando, dopo una bella traversata, alle 12.35. Dal porticciolo, un autobus della linea CS (Circolare Sinistra) ci ha poi portato in una quindicina di minuti in prossimità dell’hotel che avevamo prenotato, il Parco Maria
Terme di Cuotto (info@parcomaria.it). Vi abbiamo
trascorso una settimana splendida, all’insegna
del relax: l’hotel è costituito da edifici
immersi in un grande parco molto curato; ha tre
ampie piscine termali, a diverse temperature, un
centro benessere, un ristorante all’aperto dove
si possono gustare ottimi piatti ( a scelta tra
quattro opzioni del menù). Consigliabile la
mezza pensione! La nostra camera, molto spaziosa,
si affacciava sulla Baia di Citara: la vista del
tramonto è impagabile . Parco Maria
Terme di Cuotto (info@parcomaria.it). Vi abbiamo
trascorso una settimana splendida, all’insegna
del relax: l’hotel è costituito da edifici
immersi in un grande parco molto curato; ha tre
ampie piscine termali, a diverse temperature, un
centro benessere, un ristorante all’aperto dove
si possono gustare ottimi piatti ( a scelta tra
quattro opzioni del menù). Consigliabile la
mezza pensione! La nostra camera, molto spaziosa,
si affacciava sulla Baia di Citara: la vista del
tramonto è impagabile .
 Ogni giorno una
navetta gratuita porta gli ospiti alla spiaggia,
una delle più belle dell’isola. Si può anche
scendere a piedi percorrendo la strada
–
un po’
trafficata
–
in neppure 20 minuti, però la salita, al ritorno,
risulta certamente più faticosa. La spiaggia
sabbiosa ha una parte libera, un po’ in pendenza,
adiacente ai famosi Giardini Poseidon - un
complesso di una ventina di vasche termali
all’interno di un parco, con lido privato, dove
però non siamo entrati in quanto il costo del
biglietto d’ingresso, 40 euro a persona (45 ad
agosto), ci è parso troppo alto. Il mare è
bellissimo, abbiamo sempre trovato acque limpide,
di un bel colore verde-azzurro (meglio andare la
mattina per evitare l’affollamento). Ogni giorno una
navetta gratuita porta gli ospiti alla spiaggia,
una delle più belle dell’isola. Si può anche
scendere a piedi percorrendo la strada
–
un po’
trafficata
–
in neppure 20 minuti, però la salita, al ritorno,
risulta certamente più faticosa. La spiaggia
sabbiosa ha una parte libera, un po’ in pendenza,
adiacente ai famosi Giardini Poseidon - un
complesso di una ventina di vasche termali
all’interno di un parco, con lido privato, dove
però non siamo entrati in quanto il costo del
biglietto d’ingresso, 40 euro a persona (45 ad
agosto), ci è parso troppo alto. Il mare è
bellissimo, abbiamo sempre trovato acque limpide,
di un bel colore verde-azzurro (meglio andare la
mattina per evitare l’affollamento).
Con l’abbonamento settimanale
alle linee di autobus ischitane (14.50 euro),
acquistato in tabaccheria, abbiamo potuto girare
l’isola con grande facilità e un notevole
risparmio. Una meta importante è stata il
Castello Aragonese, a Ischia Ponte, a pochi
minuti di autobus (linea 7) dalla piazza di
Ischia Porto che funge da capolinea.
Un ’altra meta imperdibile di Ischia è senz’altro il meraviglioso parco denominato “Giardini La
Mortella”, poco a nord di Forìo (
https://visit.lamortella.org).
Qui vengono organizzate, in primavera-estate, rassegne di musica classica all’aperto (nel “Teatro
Greco”), in genere nel tardo pomeriggio, con
orchestre giovanili; nei week end si tengono, al
Museo, concerti di musica da camera. I giardini,
molto estesi e suddivisi in una parte “a valle”
e in una “in collina”, furono voluti nel 1956 da
Susana Gil Passo, di origine argentina, moglie
del compositore inglese William Walton; i
coniugi vissero a Ischia dal 1949 e le loro denominato “Giardini La
Mortella”, poco a nord di Forìo (
https://visit.lamortella.org).
Qui vengono organizzate, in primavera-estate, rassegne di musica classica all’aperto (nel “Teatro
Greco”), in genere nel tardo pomeriggio, con
orchestre giovanili; nei week end si tengono, al
Museo, concerti di musica da camera. I giardini,
molto estesi e suddivisi in una parte “a valle”
e in una “in collina”, furono voluti nel 1956 da
Susana Gil Passo, di origine argentina, moglie
del compositore inglese William Walton; i
coniugi vissero a Ischia dal 1949 e le loro
 ceneri sono custodite nel giardino, in luoghi
suggestivi dedicati alla loro memoria. I giardini inferiori furono progettati
dall’architetto paesaggista britannico Russell
Page, mentre quelli superiori devono la loro
struttura e composizione vegetale proprio a
Susana, vero genius loci, appassionata di
botanica, che introdusse molte piante tropicali.
Musica, arte e natura si fondono quindi in modo
armonioso, in uno scenario di grande bellezza,
tra fontane, piccole cascate, ruscelletti, nel
verde di palme, magnolie, papiri, ceneri sono custodite nel giardino, in luoghi
suggestivi dedicati alla loro memoria. I giardini inferiori furono progettati
dall’architetto paesaggista britannico Russell
Page, mentre quelli superiori devono la loro
struttura e composizione vegetale proprio a
Susana, vero genius loci, appassionata di
botanica, che introdusse molte piante tropicali.
Musica, arte e natura si fondono quindi in modo
armonioso, in uno scenario di grande bellezza,
tra fontane, piccole cascate, ruscelletti, nel
verde di palme, magnolie, papiri,
 felci,
orchidee, strelitzie, punteggiato da colori
smaglianti di fiori disposti sapientemente lungo
il percorso. Serre e padiglioni,
come il Tempio del Sole, il Ninfeo, la Voliera,
arricchiscono la visita. felci,
orchidee, strelitzie, punteggiato da colori
smaglianti di fiori disposti sapientemente lungo
il percorso. Serre e padiglioni,
come il Tempio del Sole, il Ninfeo, la Voliera,
arricchiscono la visita.
Tra i borghi visitati, ci ha
colpito in modo particolare Sant’Angelo, sia per
i
 forte desiderio di
tornare al più presto in questa magica isola, il
cui nome forse deriva proprio dallo spagnolo “La
Isla”, storpiato dai napoletani in “Iscla” e
quindi trasformato nel più eufonico “Ischia”.
Oppure il nome ha una derivazione greca e
significa “forza”, “fortezza inespugnabile”. O
ancora è legato a un osso del bacino, l’ischio,
e al mito dei Titani in lotta contro gli Dei
dell’Olimpo… forte desiderio di
tornare al più presto in questa magica isola, il
cui nome forse deriva proprio dallo spagnolo “La
Isla”, storpiato dai napoletani in “Iscla” e
quindi trasformato nel più eufonico “Ischia”.
Oppure il nome ha una derivazione greca e
significa “forza”, “fortezza inespugnabile”. O
ancora è legato a un osso del bacino, l’ischio,
e al mito dei Titani in lotta contro gli Dei
dell’Olimpo…
10 agosto 2022, Anna Busca
SETTEMBRE 2021 CAVALCATA APPENNINICA 2021 (Terza parte) di Anna Busca Da Campobasso a Calitri (Molise- Campania) Ci sono stati segnalati due
luoghi interessanti nei pressi di Campobasso,
raggiungibili in breve tempo con l’auto: uno è
Ferrazzano, borgo arroccato, con un bel castello
di origine normanna, più volte rimaneggiato, e
con la chiesa di Santa Maria Assunta,
dall’interessante portale duecentesco, insieme a
un magnifico pulpito della stessa epoca; Lasciata la struggente Sepino,
giungiamo a Benevento per la nostra ottava tappa
(B&B Le Streghe). Non eravamo mai stati in
questa città campana, e ne siamo rimasti davvero
favorevolmente colpiti.
Al numero 145 di corso
Garibaldi, nelle sale a pianterreno di un
palazzo nobiliare, ha sede “Janua- Museo delle
Streghe”. Il percorso, guidato con competenza,
porta il visitatore a
Partiti a malincuore da
Benevento, ci siamo diretti verso Calitri,
attraversando l’Irpinia. Una sosta allo
splendido lago di Laceno, in
Da Calitri a Marina di Ginosa (Campania, Basilicata, Puglia) Il giorno seguente ci siamo
dedicati a un breve trekking alle cascate di San
Fele, più a sud, in provincia di Potenza e
quindi già in Basilicata. Si parcheggia lungo la
strada e si comincia un percorso di un paio
d’ore al massimo, su sentieri e scalette, tra la
vegetazione, seguendo il corso del torrente
Bradanello, che forma, per salti di quota,
piccole cascate e laghetti. Siamo nell’Appennino
Lucano, e la bella escursione richiama parecchi
turisti. L’unica pecca è che, se non si vuole
riprendere il sentiero in senso inverso, poiché
l’itinerario non è ad anello ma si conclude
sulla strada asfaltata dalla parte opposta,
occorre tornare all’auto a piedi per 2-3 km, non
essendo stato ripristinato il servizio navetta.
Prevedere quindi buone scarpe e magari una
borraccia... Da San Fele ci siamo poi spostati a
5 settembre 2021 Anna Busca CAVALCATA APPENNINICA 2021 (seconda parte) di Anna Busca Da Matelica a L’Aquila (Marche-Umbria-Abruzzo) Prima di lasciare Matelica siamo passati dalla chiesa della Beata Mattia, che conserva il corpo di suor Mattia Nazzarei, vissuta tra il XIII e il il XIV secolo e fatta oggetto di culto e venerazione: è adiacente all ‘antico monastero delle clarisse. L’impianto di riscaldamento del convento, che ospitava le monache di clausura in gelide celle, fu generosamente donato da Enrico Mattei, che era uso frequentare la chiesa, un vero simbolo per i cattolici matelicesi. Lungo la strada, una breve sosta al cimitero cittadino, dove è sepolto Mattei, nella tomba di famiglia: una costruzione sobria, con una parte vetrata che consente di scorgere l’interno dove, su un piccolo altare, spiccano diverse fotografie. Il bassorilievo sull’ingresso riporta due pavoni, simboli cristiani della resurrezione e dell’immortalità. Il nostro percorso è
proseguito verso sud, costeggiando i Monti
Sibillini. Visso e altri paesi attraversati
portano ancora le ferite del terremoto del 26
ottobre 2016 (magnitudo 5.9): centro storico
Riprendendo il viaggio,
abbiamo sostato a Sant’Anatolia di Narco, che
possiede un curioso “Museo della Canapa”
– molto
coltivata in Valnerina per la produzione di
tessuti e cordami - ed è un bel borgo medioevale
ben conservato, con chiese romaniche
interessanti. Certo il binomio “Narco” e Canapa”
è ben bizzarro! Ma “Narco” in questo caso è
semplicemente il nome di un antico popolo o il
nome del Nera...La visita all’abbazia di san
Pietro in Valle (VII-XIII sec.), in provincia di
Terni, ci ha poi portato ad esplorare uno
splendido complesso, in gran parte- ahimé-
trasformato in un elegante resort per pochi
eletti. L’ex monastero benedettino è infatti
proprietà privata ed è adibito a residenza
alberghiera di lusso, mentre la chiesa è della
curia ed è visitabile. Spicca l’alta torre
campanaria; all’interno della chiesa, a navata
unica, affreschi medioevali e rinascimentali e
bellissime lastre d’altare d’epoca longobarda. A
Ferentillo ecco l’ultimo museo particolare,
quello delle Mummie. Da L’Aquila a Campobasso (Abruzzo-Lazio-Molise) Dopo la visita alla città, il
viaggio è continuato verso sud, attraversando lo
stupendo altopiano delle Rocche, nel Parco
Sirente-Velino, dove una sosta a Rocca di Mezzo
ci ha anche consentito di gustare squisiti
arrosticini. La nostra sesta tappa è stata Sora,
in provincia di Frosinone, dove ci siamo fermati
due notti (Hotel del Sole). Lo scorso anno, nel
nostro tour della Ciociaria, non eravamo
riusciti a vedere la città: la scelta quindi è
andata anche a “chiudere” simbolicamente il giro
dell’estate 2020 (vedi “Tra Acropoli e Mura
ciclopiche”, sez Turismo corrierebit.com,
settembre 2020). Sora ci riserva piacevoli
sorprese: circondata da monti boscosi, è
attraversata dal corso sinuoso del Liri, che si
può valicare con diversi ponti che collegano le
due sponde alberate.
Da Sora abbiamo seguito
strade secondarie, ricche di tornanti, salite e
discese, che ci hanno consentito di attraversare
lo splendido Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise,
tra foreste di faggi, piccole cascate e scenari
incantevoli. Chi ha tempo e attrezzatura adatta
può entrare nella Riserva Naturale della
Camosciara, nel cuore del Parco, per escursioni
e trekking, per esempio sul sentiero G5. Come
suggerisce il nome, è possibile l’avvistamento
di camosci d’Abruzzo.
4 settembre 2021 Anna Busca CAVALCATA APPENNINICA 2021 (Prima parte ) Scegliere per l’agosto 2021 un itinerario di viaggio di una ventina di giorni, tutto italiano, che prevedesse fondamentalmente tappe mai da noi toccate, non è stato facile: ma alla fine ci siamo riusciti. E ne è risultato un percorso tortuoso e a tratti impervio ma ricchissimo di bellezza, sia artistica che paesaggistica, di incontri, di storia. Indimenticabile. Da Modena ad Arezzo (Emilia Romagna-Toscana) Partendo da Milano e seguendo
l’A1, ci siamo fermati a Modena per la
necessaria pausa pranzo. Una passeggiata in
centro, decisamente poco affollato, ci ha
consentito di rivedere capolavori come
l’imponente Palazzo Ducale, il magnifico Duomo
romanico, l’alta Torre Ghirlandina.
Lasciata Modena, abbiamo
raggiunto quella che era in realtà la vera prima
tappa della nostra “cavalcata appenninica”,
lungo la spina dorsale della nostra penisola:
Riolo Terme, in provincia di
Passando da Modigliana,
interessante per i resti della Rocca dei Conti
Guidi, per il cosiddetto Ponte “della Signora” (ricostruzione
Proseguendo per strade e stradine dell’appennino tosco-emiliano, attraversando Bagno di Romagna, con la sua bella chiesa romanica di S. Maria Assunta, e i fitti boschi delle pendici del Monte Fumaiolo, ci fermiamo nei pressi di Subbiano (provincia di Arezzo), seconda sosta del nostro itinerario. Abbiamo pernottato in un luogo davvero magico, l’Albergo Ristorante La Gravenna, nei pressi di un torrente, circondato dalla vegetazione, con una vasca di acqua dolce: l’interno è una sorta di “camera delle meraviglie” che lascia davvero incantati. Pasolini era solito trascorrervi lunghi periodi di quiete, e la lista di clienti famosi è lunga… La tappa obbligata,la mattina successiva, dopo un’eccellente colazione, è sicuramente Arezzo, già visitata in passato ma sempre meritevole di una passeggiata nel centro storico. In cima a un colle,
l’affascinante
Da Arezzo a Matelica (Toscana- Marche) A una trentina di km il borgo
di Monterchi possiede un capolavoro di Piero: la
Madonna del Parto, affresco della metà del ‘400,
di cui
Superata Monterchi, abbiamo
proseguito soprattutto per stradine secondarie,
seguendo fiduciosi il navigatore in quanto privi
di carte automobilistiche adeguate, tra paesaggi
agricoli e boschi, valicando l’appennino
umbro-marchigiano. Ed eccoci a Matelica (provincia
di Macerata), terza sosta, ospiti dello storico
hotel Fioriti, in pieno centro, che presenta
davanti al portone d’ingresso, protetto da una
grande teca di vetro, un bel pavimento musivo di
epoca romana trovato durante gli scavi
archeologici della città. Il nome “Matelica”ha
origini oscure, forse celtiche, e viene già
citato da Plinio il Vecchio. Qui nel 1919 si
trasferì con la famiglia, da Acqualagna dove era
nato nel 1906, Enrico Mattei, geniale
3 settembre 2021 Anna Busca
|