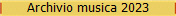 
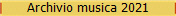
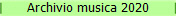 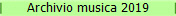 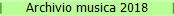 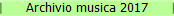 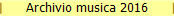 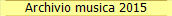 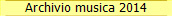  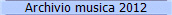 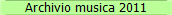 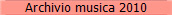 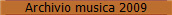 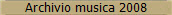
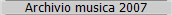
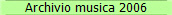
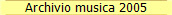
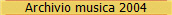







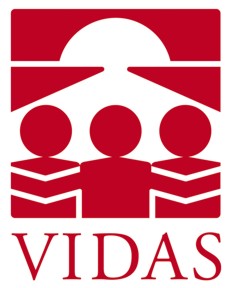
RECENSIONIDVDLIBRI
k
k
<
|
APRILE 2024
In Conservatorio
è iniziata MUSICA MAESTRI INTERNATIONAL
Il
primo appuntamento della nuova rassegna del
Conservatorio denominata Musica Maestri
International ha visto ieri sera in Sala
Puccini il Con Fuoco Duo, con Robert
 Walzel
al clarinetto e Steven Michael Glaser al
pianoforte. La nuova iniziativa, ieri introdotta
da Stefania Mormone docente di pianoforte nel
Conservatorio milanese, allarga la rassegna di
successo Musica Maestri! che abitualmente si
svolge in Sala Puccini. Statunitensi, entrambi,
docenti dei rispettivi strumenti in università
americane, il duo ha voluto omaggiare Walzel
al clarinetto e Steven Michael Glaser al
pianoforte. La nuova iniziativa, ieri introdotta
da Stefania Mormone docente di pianoforte nel
Conservatorio milanese, allarga la rassegna di
successo Musica Maestri! che abitualmente si
svolge in Sala Puccini. Statunitensi, entrambi,
docenti dei rispettivi strumenti in università
americane, il duo ha voluto omaggiare
 l'Italia
inserendo nel variegato impaginato denominato
Melodies for many occasions, brani di
Puccini e di Morricone molto popolari,
unitamente ad autori come Bernstein, con la rara
ed efficace Sonata per clarinetto e
pianoforte, di Harlos con “Benniana“,
di Richard Rodney Bennett con “Ballad in
memory of Shirley Horn“ e di Simon A. Sargon
con "KlezMuzik". Ottimi interpreti, i due
strumentisti hanno elargito esecuzioni chiare,
con misurato equilibrio tra le parti strumentali
e di valida resa espressiva complessiva. Bis
ancora di Ennio Morricone. Applausi sostenuti da
un pubblico purtroppo non numeroso in un
iniziativa che meritava una sala al completo. l'Italia
inserendo nel variegato impaginato denominato
Melodies for many occasions, brani di
Puccini e di Morricone molto popolari,
unitamente ad autori come Bernstein, con la rara
ed efficace Sonata per clarinetto e
pianoforte, di Harlos con “Benniana“,
di Richard Rodney Bennett con “Ballad in
memory of Shirley Horn“ e di Simon A. Sargon
con "KlezMuzik". Ottimi interpreti, i due
strumentisti hanno elargito esecuzioni chiare,
con misurato equilibrio tra le parti strumentali
e di valida resa espressiva complessiva. Bis
ancora di Ennio Morricone. Applausi sostenuti da
un pubblico purtroppo non numeroso in un
iniziativa che meritava una sala al completo.
19 Aprile
2024 Cesare Guzzardella
Il pianista Pietro De Maria
diretto da Alessandro Cadario ai Pomeriggi
Musicali
Il classicismo di due grandi
musicisti quali Beethoven e Schubert è stato
messo in risalto nell'anteprima di questa
mattina da I Pomeriggi Musicali del Dal
Verme con l'orchestra diretta da Alessandro
Cadario e con la partecipazione solistica del
pianista Pietro De Maria. Prima
 un brano celebre
con il beethoveniano Concerto n.5 per
pianoforte e orchestra in Mi bem.Maggiore Op.73
"Imperatore"; poi un'assoluta rarità
interpretativa con la giovanile Sinfonia n.1
in Re maggiore D 82 di Schubert. Lo
straordinario concerto del grande tedesco
riassume tutta la forza espressiva del musicista:
dai frangenti più estroversi dell'Allegro
iniziale e del Rondò finale, alla
dolcezza interiore del profondo Adagio poco
mosso centrale, dove le poche note del
pianoforte, eseguite con intensa espressività da
De Maria, e le geniali armonizzazioni
orchestrali definite con eterea un brano celebre
con il beethoveniano Concerto n.5 per
pianoforte e orchestra in Mi bem.Maggiore Op.73
"Imperatore"; poi un'assoluta rarità
interpretativa con la giovanile Sinfonia n.1
in Re maggiore D 82 di Schubert. Lo
straordinario concerto del grande tedesco
riassume tutta la forza espressiva del musicista:
dai frangenti più estroversi dell'Allegro
iniziale e del Rondò finale, alla
dolcezza interiore del profondo Adagio poco
mosso centrale, dove le poche note del
pianoforte, eseguite con intensa espressività da
De Maria, e le geniali armonizzazioni
orchestrali definite con eterea precisione e
giusto equilibrio da Cadario e dagli ottimi I
Pomeriggi, hanno portato, insieme ai
corretti ed equilibrati movimenti laterali nel
cosiddetto "stile eroico", ad un'ottima
interpretazione. Applausi meritatissimi ai
protagonisti. Particolarmente interessante la
Sinfonia giovanile di uno Schubert solo
sedicenne, ma che aveva imparato il mestiere
assai bene. Emergono già qui le qualità
melodiche del viennese e poi che delizia quell'Allegro
vivace finale, eseguito con grinta e
passione da Cadario nella valida restituzione de
I Pomeriggi. Ma non è finita qui: il
Maestro Caderio ha voluto regalare al numeroso
pubblico presente una splendida orchestrazione
di Max Reger di Erlkönig, Op.1 di Franz
Schubert e celebre suo lied. Questa sera alle
ore 20.00 la prima ufficiale e sabato alle 17.00
la replica. Da non perdere! precisione e
giusto equilibrio da Cadario e dagli ottimi I
Pomeriggi, hanno portato, insieme ai
corretti ed equilibrati movimenti laterali nel
cosiddetto "stile eroico", ad un'ottima
interpretazione. Applausi meritatissimi ai
protagonisti. Particolarmente interessante la
Sinfonia giovanile di uno Schubert solo
sedicenne, ma che aveva imparato il mestiere
assai bene. Emergono già qui le qualità
melodiche del viennese e poi che delizia quell'Allegro
vivace finale, eseguito con grinta e
passione da Cadario nella valida restituzione de
I Pomeriggi. Ma non è finita qui: il
Maestro Caderio ha voluto regalare al numeroso
pubblico presente una splendida orchestrazione
di Max Reger di Erlkönig, Op.1 di Franz
Schubert e celebre suo lied. Questa sera alle
ore 20.00 la prima ufficiale e sabato alle 17.00
la replica. Da non perdere!
18 aprile 2024. Cesare
Guzzardella
Il pianista inglese Paul
Lewis interpreta Schubert per la Società dei
Concerti
È tornato in Conservatorio il
pianista inglese Paul Lewis per la Società
dei Concerti milanese. Nel marzo dello
scorso anno aveva affrontato tre Sonate
schubertiane, la n.13, la n.15 e la n.16. Ieri
ha continuato l'impresa con altre tre Sonate del
grande musicista austriaco, precisamente la
n.4
 D.537, la n.9 D.575 e la n.18
D.894. Ci troviamo di fronte ad un
interprete che ha fatto dei classici la sua
principale cifra interpretativa. L'amato
Schubert, insieme a Beethoven, sono i musicisti
da lui più eseguiti. Come avevamo scritto lo
scorso anno, Lewis, classe 1972, di Liverpool,
ebbe tra i suoi insegnanti anche il grande
Alfred Brendel, dal quale ha ereditato evidenti
modalità interpretative oltre che a una certa
gestualità funzionale ad un'intensa
concentrazione utile per definire in modo
analitico le sue ottime timbriche. La qualità
della sua raffinata esecuzione ha trovato da
subito esplicitazione nella Sonata n.4 in la
minore, eccezionalmente in tre movimenti,
mancante di uno scherzo o di D.537, la n.9 D.575 e la n.18
D.894. Ci troviamo di fronte ad un
interprete che ha fatto dei classici la sua
principale cifra interpretativa. L'amato
Schubert, insieme a Beethoven, sono i musicisti
da lui più eseguiti. Come avevamo scritto lo
scorso anno, Lewis, classe 1972, di Liverpool,
ebbe tra i suoi insegnanti anche il grande
Alfred Brendel, dal quale ha ereditato evidenti
modalità interpretative oltre che a una certa
gestualità funzionale ad un'intensa
concentrazione utile per definire in modo
analitico le sue ottime timbriche. La qualità
della sua raffinata esecuzione ha trovato da
subito esplicitazione nella Sonata n.4 in la
minore, eccezionalmente in tre movimenti,
mancante di uno scherzo o di
 un minuetto, ma
nell'insieme comunque completa. La resa
espressiva di alto livello ha, in questo lavoro,
ma anche negli altri, rivelato coerenza nel
rapporto tra i differenti movimenti, con
frangenti di eccellente conpenetrazione del
materiale per una resa dettagliata e chiara.
Altrettanto valida la successiva Sonata n.9
in Si maggiore e, dopo l'intervallo, la più
corposa Sonata n.18 in Sol maggiore,
quattro movimenti di cui il primo, Molto
moderato e cantabile di ampia
dimensione e l'ultimo, l'Allegretto, di
una raffinatezza eccellente. Un interprete doc
per Schubert che ha meritato pienamente i
fragorosi applausi del pubblico presente in Sala
Verdi, concedendo, dopo il programma ufficiale,
un bis ancora schubertiano con il profondo
Andante molto dalla Sonata D568.
Splendido concerto! un minuetto, ma
nell'insieme comunque completa. La resa
espressiva di alto livello ha, in questo lavoro,
ma anche negli altri, rivelato coerenza nel
rapporto tra i differenti movimenti, con
frangenti di eccellente conpenetrazione del
materiale per una resa dettagliata e chiara.
Altrettanto valida la successiva Sonata n.9
in Si maggiore e, dopo l'intervallo, la più
corposa Sonata n.18 in Sol maggiore,
quattro movimenti di cui il primo, Molto
moderato e cantabile di ampia
dimensione e l'ultimo, l'Allegretto, di
una raffinatezza eccellente. Un interprete doc
per Schubert che ha meritato pienamente i
fragorosi applausi del pubblico presente in Sala
Verdi, concedendo, dopo il programma ufficiale,
un bis ancora schubertiano con il profondo
Andante molto dalla Sonata D568.
Splendido concerto!
18 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
Il VIOLINISTA E DIRETTORE
SZEPS-ZNAIDER AL VIOTTIFESTIVAL DI VERCELLI
Ieri sera, mercoledì 17
aprile, al Teatro Civico di Vercelli, ospite del
ViottiFestival è stato uno dei più celebri
violinisti d’oggi, nonché apprezzato direttore,
il danese Nikolaj Szeps-Znaider, tra i pochi a
poter vantare il primo premio ai due più
importanti concorsi europei per violino, il
Sibelius e Il Reine Elisabeth. Alla sua prima
vercellese, Szeps-Znaider, sia in veste di
solista, sia in quella di direttore
dell’Orchestra Camerata Ducale, presentava un
programma impaginato su due concerti per violino
e orchestra, il n. 2 in Re maggiore KV 211 di
Mozart (1775) e il n.16 in Mi minore WI: 16 di
Gb. Viotti (1785-89), per concludere, deposto il
violino, con la Sinfonia n.38 in Re maggiore KV
504 “Praga”, ancora di Mozart (1786). Fin
dall’Allegro moderato che apre il Concerto KV
211 il pubblico è stato sedotto dal suono dolce,
caldo, morbido e chiaro dello splendido
Guarnieri del Gesù 1741 Kreisler di
Szeps-Znaider. Questo suono, unito a una
fluidità straordinaria del legato, ha impresso,
alle varie soluzioni melodiche del Concerto, una
soave pacatezza, una sorta di serenità
trascendentale,
 che ha contenuto entro la misura
di un lieve brivido anche l’improvvisa
modulazione al minore nello sviluppo del primo
tempo. Un Mozart meravigliosamente classicistico,
ma non di un classicismo marmoreo, soffuso
invece come di ‘un calore di fiamma lontana’, se
ci è lecita una citazione foscoliana, grazie
anche alle sottili e raffinate ombreggiature
chiaroscurali ottenute con il controllo sapiente
delle dinamiche. Un suono, quello di
Szeps-Znaider che sa anche velarsi di suggestiva
tenerezza, come nel primo splendido tema
cantabile dell’Andante centrale, acme espressiva
dell’intero concerto, ma sa anche farsi
capriccioso e brioso, come nel refrain e nei
couplet del finale Rondò, ma sempre con quella
soavità e pacatezza di fondo di cui si diceva e
che avvolge un po’ tutto questo stupendo Mozart
del violinista danese. Il Concerto n. 16 di
Viotti, uno dei più belli in assoluto del suo
catalogo (tanto da suscitare l’ammirazione di
Mozart, che ne curò un’edizione aggiungendo
all’orchestrazione trombe e timpani) porta
all’estremo quella che già individuammo in un
precedente articolo come la caratteristica
fondamentale della musica più alta del
Vercellese, la tensione che la attraversa
costantemente tra temi (e mondi) musicali
lontani tra loro. Questo è un concerto segnato
da una forte inquietudine, che sfiora l’ansia,
subito annunciata dalla emozionante introduzione
funebre, e da un andamento fremente, nervoso,
reso instabile dalla costante oscillazione tra
momenti di intenso virtuosismo e temi cantabili.
Szeps-Znaider che ha contenuto entro la misura
di un lieve brivido anche l’improvvisa
modulazione al minore nello sviluppo del primo
tempo. Un Mozart meravigliosamente classicistico,
ma non di un classicismo marmoreo, soffuso
invece come di ‘un calore di fiamma lontana’, se
ci è lecita una citazione foscoliana, grazie
anche alle sottili e raffinate ombreggiature
chiaroscurali ottenute con il controllo sapiente
delle dinamiche. Un suono, quello di
Szeps-Znaider che sa anche velarsi di suggestiva
tenerezza, come nel primo splendido tema
cantabile dell’Andante centrale, acme espressiva
dell’intero concerto, ma sa anche farsi
capriccioso e brioso, come nel refrain e nei
couplet del finale Rondò, ma sempre con quella
soavità e pacatezza di fondo di cui si diceva e
che avvolge un po’ tutto questo stupendo Mozart
del violinista danese. Il Concerto n. 16 di
Viotti, uno dei più belli in assoluto del suo
catalogo (tanto da suscitare l’ammirazione di
Mozart, che ne curò un’edizione aggiungendo
all’orchestrazione trombe e timpani) porta
all’estremo quella che già individuammo in un
precedente articolo come la caratteristica
fondamentale della musica più alta del
Vercellese, la tensione che la attraversa
costantemente tra temi (e mondi) musicali
lontani tra loro. Questo è un concerto segnato
da una forte inquietudine, che sfiora l’ansia,
subito annunciata dalla emozionante introduzione
funebre, e da un andamento fremente, nervoso,
reso instabile dalla costante oscillazione tra
momenti di intenso virtuosismo e temi cantabili.
Szeps-Znaider
 domina questo infuocato materiale
sonoro, con una calibratissima duttilità di
suono, qui spinto ad esplorare zone che il
concerto mozartiano escludeva. L’intervento del
violino dopo l’ampia introduzione orchestrale
del Primo tempo Adagio/non troppo/Allegro si
carica di un’aura più dolente, in generale di
una energia sofferta e inquieta, in cui la linea
talora frammentata dei temi ritmici offre il
banco di prova a Szeps-Znaider per il suo
virtuosismo, come in generale nel Rondò finale e
in particolare nel ritornello, subito introdotto
con le sue cinque note ravvicinate e ribattute,
cui Szeps-Znaider sa dare la giusta carica di
fierezza. Ma nei momenti di più abbandonato
lirismo melodico, il violino del grande solista
danese raggiunge vertici di incantevole bellezza,
di una dolcezza intensa e coinvolgente, come
nell’Adagio centrale, tra le pagine da antologia
di Viotti. Dunque un Viotti tormentato e
dolente, drammatico, che solo nell’ultimo tempo
sembra trovare una qualche luce di riscatto e
speranza, secondo una’ narrazione’ sinfonica che
è già romantica. Veramente un’eccellente
interpretazione, sia per Mozart, sia per Viotti,
questa di Znaider, che ha guidato molto bene la
Camerata Ducale, con una perfetta gestione degli
equilibri e degli intrecci tra le varie linee
strumentali, valida scelta dei tempi e delle
dinamiche, dialogo sicuro tra solista e
orchestra. Gli applausi scroscianti di un
pubblico ammirato non sono valsi a ottenere un
bis. Non ha certamente deluso le attese neppure
lo Szeps-Znaider direttore, che ha ormai una
consolidata esperienza alle spalle e un’ottima
fama, che la ‘sua’ Sinfonia Praga ha dimostrato
essere ampiamente meritata. Questo Mozart è
certo diverso da quello del Concerto KV 211. Son
passati più di dieci anni, siamo al Mozart della
piena maturità, che ha appena composto le Nozze
di Figaro e si accinge alla grande impresa del
Don Giovanni. In generale, possiamo dire che la
chiave di lettura che Znaider offre di questa
quart’ultima sinfonia mozartiana è fondata su un
mirabile equilibrio tra la dolce amabilità del
concerto KV 211 e l’enorme intensificazione
espressiva che, rispetto a quella musica, anima
l’ultimo Mozart e che certo deve molto al Teatro.
Un mondo pieno di contrasti e di tensioni,
questo della ‘Praga’, ma che spesso resta
latente, pronto ad affiorare all’improvviso,
incrinando i più limpidi equilibri formali. Se
la bacchetta di Znaider presenta l’introduzione
lenta già come un dramma, che ha presentimenti
del Don Giovanni, è nel primo tempo che mostra
tutta la sua bravura nel sottile lavoro di scavo
della graduale e calibratissima evoluzione della
tensione drammatica che muove il pezzo. Con una
limpidezza fatta di preziosa precisione timbrica
e ritmica, la bacchetta (si fa per dire, perché
Znaider ieri ha diretto senza podio e bacchetta,
non sappiamo se sia una sua abitudine) del
Maestro danese guida la Camerata Ducale a
inseguire le più varie combinazioni dell’insieme
di motivi che formano il tema principale e che
ricorrono continuamente, spesso urtandosi e
contrastandosi a vicenda per tutto il tempo,
illuminando le diverse linee contrappuntistiche,
in cui il materiale musicale raggiunge un suo
ordine e un suo equilibrio, all’insegna di una
superiore armonia che trionfa di ogni contrasto.
Così, anche nell’Andante centrale la barra della
direzione di Szeps-Znaider tiene saldamente la
rotta di una grazia amabile che ha da combattere
con forze più oscure, qui rese evidenti
dall’abbondanza di cromatismi che caratterizza
il movimento. È infine l’inesausta spinta
ritmica quello che il Maestro danese mette in
maggior risalto nel Finale (com’è noto la
Sinfonia Praga conta solo tre tempi, mancando il
Minuetto), una sorta di slancio verso mete
ignote, che accompagna la gaiezza briosa di
questo Rondò. Un Mozart inafferrabile e ambiguo,
come sospeso in un mondo espressivo sfuggente e
indefinibile, per il quale la luminosa struttura
classicistica è più che altro una forma di
resistenza di fronte a un che di ignoto e
vagamente minaccioso, che si affaccia alla
complessa coscienza di questo genio. Questo il
Mozart di Szeps-Znaider, ottenuto con una
direzione orchestrale sempre attentissima alla
cura dei dettagli ritmici, dinamici, timbrici e
nella scelta calibrata dei tempi. Grandi
applausi del pubblico, che ha salutato con
entusiasmo questo gran bel concerto, decisamente
da ricordare. domina questo infuocato materiale
sonoro, con una calibratissima duttilità di
suono, qui spinto ad esplorare zone che il
concerto mozartiano escludeva. L’intervento del
violino dopo l’ampia introduzione orchestrale
del Primo tempo Adagio/non troppo/Allegro si
carica di un’aura più dolente, in generale di
una energia sofferta e inquieta, in cui la linea
talora frammentata dei temi ritmici offre il
banco di prova a Szeps-Znaider per il suo
virtuosismo, come in generale nel Rondò finale e
in particolare nel ritornello, subito introdotto
con le sue cinque note ravvicinate e ribattute,
cui Szeps-Znaider sa dare la giusta carica di
fierezza. Ma nei momenti di più abbandonato
lirismo melodico, il violino del grande solista
danese raggiunge vertici di incantevole bellezza,
di una dolcezza intensa e coinvolgente, come
nell’Adagio centrale, tra le pagine da antologia
di Viotti. Dunque un Viotti tormentato e
dolente, drammatico, che solo nell’ultimo tempo
sembra trovare una qualche luce di riscatto e
speranza, secondo una’ narrazione’ sinfonica che
è già romantica. Veramente un’eccellente
interpretazione, sia per Mozart, sia per Viotti,
questa di Znaider, che ha guidato molto bene la
Camerata Ducale, con una perfetta gestione degli
equilibri e degli intrecci tra le varie linee
strumentali, valida scelta dei tempi e delle
dinamiche, dialogo sicuro tra solista e
orchestra. Gli applausi scroscianti di un
pubblico ammirato non sono valsi a ottenere un
bis. Non ha certamente deluso le attese neppure
lo Szeps-Znaider direttore, che ha ormai una
consolidata esperienza alle spalle e un’ottima
fama, che la ‘sua’ Sinfonia Praga ha dimostrato
essere ampiamente meritata. Questo Mozart è
certo diverso da quello del Concerto KV 211. Son
passati più di dieci anni, siamo al Mozart della
piena maturità, che ha appena composto le Nozze
di Figaro e si accinge alla grande impresa del
Don Giovanni. In generale, possiamo dire che la
chiave di lettura che Znaider offre di questa
quart’ultima sinfonia mozartiana è fondata su un
mirabile equilibrio tra la dolce amabilità del
concerto KV 211 e l’enorme intensificazione
espressiva che, rispetto a quella musica, anima
l’ultimo Mozart e che certo deve molto al Teatro.
Un mondo pieno di contrasti e di tensioni,
questo della ‘Praga’, ma che spesso resta
latente, pronto ad affiorare all’improvviso,
incrinando i più limpidi equilibri formali. Se
la bacchetta di Znaider presenta l’introduzione
lenta già come un dramma, che ha presentimenti
del Don Giovanni, è nel primo tempo che mostra
tutta la sua bravura nel sottile lavoro di scavo
della graduale e calibratissima evoluzione della
tensione drammatica che muove il pezzo. Con una
limpidezza fatta di preziosa precisione timbrica
e ritmica, la bacchetta (si fa per dire, perché
Znaider ieri ha diretto senza podio e bacchetta,
non sappiamo se sia una sua abitudine) del
Maestro danese guida la Camerata Ducale a
inseguire le più varie combinazioni dell’insieme
di motivi che formano il tema principale e che
ricorrono continuamente, spesso urtandosi e
contrastandosi a vicenda per tutto il tempo,
illuminando le diverse linee contrappuntistiche,
in cui il materiale musicale raggiunge un suo
ordine e un suo equilibrio, all’insegna di una
superiore armonia che trionfa di ogni contrasto.
Così, anche nell’Andante centrale la barra della
direzione di Szeps-Znaider tiene saldamente la
rotta di una grazia amabile che ha da combattere
con forze più oscure, qui rese evidenti
dall’abbondanza di cromatismi che caratterizza
il movimento. È infine l’inesausta spinta
ritmica quello che il Maestro danese mette in
maggior risalto nel Finale (com’è noto la
Sinfonia Praga conta solo tre tempi, mancando il
Minuetto), una sorta di slancio verso mete
ignote, che accompagna la gaiezza briosa di
questo Rondò. Un Mozart inafferrabile e ambiguo,
come sospeso in un mondo espressivo sfuggente e
indefinibile, per il quale la luminosa struttura
classicistica è più che altro una forma di
resistenza di fronte a un che di ignoto e
vagamente minaccioso, che si affaccia alla
complessa coscienza di questo genio. Questo il
Mozart di Szeps-Znaider, ottenuto con una
direzione orchestrale sempre attentissima alla
cura dei dettagli ritmici, dinamici, timbrici e
nella scelta calibrata dei tempi. Grandi
applausi del pubblico, che ha salutato con
entusiasmo questo gran bel concerto, decisamente
da ricordare.
18 aprile 2024 Bruno Busca
Presentato ieri al Teatro
alla Scala il 33° Festival "Milano Musica"
Il
33° Festival Milano Musica denominato
quest'anno "L'ASCOLTO INQIUIETO" si
svolgerà tra il 23 aprile all'8 giugno 2024. Con
oltre 25 appuntamenti: concerti sinfonici e
cameristici, musica elettronica e video, teatro
di figura e con 7 prime esecuzioni assolute e 11
prime in Italia comprese 1 commissione e 5 co-commissioni
di Milano Musica, il Festival si rivela anche
quest'anno con un numeroso numero di eventi
musicali e anche nell' obiettivo perseguito
lungo percorsi molteplici: nell’uso di spazi non
 convenzionali, il Pirelli HangarBicocca e l’Orto
Botanico di Brera; nella scelta e
nell’accostamento di repertori e autori, da
Schumann a Marco Momi con la prima assoluta del
suo Concerto per pianoforte e orchestra con
elettronica; nella preferenza per brani che
innovano la relazione fra la musica e il
pubblico, come i trii e i quartetti per le
combinazioni strumentali più originali in prima
esecuzione nel Ridotto dei palchi del Teatro
alla Scala in occasione dell’inaugurazione.
L’arco del Festival si apre martedì 23 e
mercoledì 24 aprile con un’anteprima dedicata a
giovani e adulti, convenzionali, il Pirelli HangarBicocca e l’Orto
Botanico di Brera; nella scelta e
nell’accostamento di repertori e autori, da
Schumann a Marco Momi con la prima assoluta del
suo Concerto per pianoforte e orchestra con
elettronica; nella preferenza per brani che
innovano la relazione fra la musica e il
pubblico, come i trii e i quartetti per le
combinazioni strumentali più originali in prima
esecuzione nel Ridotto dei palchi del Teatro
alla Scala in occasione dell’inaugurazione.
L’arco del Festival si apre martedì 23 e
mercoledì 24 aprile con un’anteprima dedicata a
giovani e adulti,
 Tierkreis di Karlheinz
Stockhausen nello spettacolo di teatro di figura
di Luciano Gottardi, con intermezzi
elettroacustici al Teatro Menotti, e si chiude
al Pirelli HangarBicocca e al Conservatorio G.
Verdi, con due fondamentali lavori di Fausto
Romitelli, le cui coraggiose scelte musicali
hanno segnato la giovane generazione di
compositori a livello internazionale. Nella
presentazione di questa mattina, dopo il saluto
introduttivo della Presidente di Milano
Musica Rosalina Archinto, l'organizzatrice e
direttore di Milano Musica Cecilia
Balestra ha introdotto il Festival con esaustive
parole, delineando i punti di forza della
nuova rassegna di musica contemporanea e
presentando i numerosi ospiti: il musicologo
Franco Pulcini ha anche illustrato la mostra
presente in Scala con immagini e documenti
dedicati a Luigi Nono, musicista
d'avanguardia
del Secondo Novecento che in modo evidente si
collega alle origini di questa importante
rassegna; musicisti come il Tierkreis di Karlheinz
Stockhausen nello spettacolo di teatro di figura
di Luciano Gottardi, con intermezzi
elettroacustici al Teatro Menotti, e si chiude
al Pirelli HangarBicocca e al Conservatorio G.
Verdi, con due fondamentali lavori di Fausto
Romitelli, le cui coraggiose scelte musicali
hanno segnato la giovane generazione di
compositori a livello internazionale. Nella
presentazione di questa mattina, dopo il saluto
introduttivo della Presidente di Milano
Musica Rosalina Archinto, l'organizzatrice e
direttore di Milano Musica Cecilia
Balestra ha introdotto il Festival con esaustive
parole, delineando i punti di forza della
nuova rassegna di musica contemporanea e
presentando i numerosi ospiti: il musicologo
Franco Pulcini ha anche illustrato la mostra
presente in Scala con immagini e documenti
dedicati a Luigi Nono, musicista
d'avanguardia
del Secondo Novecento che in modo evidente si
collega alle origini di questa importante
rassegna; musicisti come il
 citato Marco Momi;
organizzatori come Mark Madlener, direttore
dell' IRCAM di Parigi che ha rimarcato il legame
privilegiato tra Milano e Parigi nel sostenere
la musica contemporanea. Sono intervenuti anche
il direttore d'orchestra Michele Gamba che è
entrato in merito al lavoro di Momi; interpreti
come il pianista Filippo Gorini che unirà nel
suo concerto alla Scala la figura di Schubert a
quella di Kurtag. Per finire il consulente
artistico Paolo Petazzi è entrato nei dettagli
della programmazione del Festival. Anche
quest'anno si prevede una forte affluenza di
appassionati nei numerosissimi spazi in cui si
svolgerà la manifestazione italiana più
importante di musica contemporanea. citato Marco Momi;
organizzatori come Mark Madlener, direttore
dell' IRCAM di Parigi che ha rimarcato il legame
privilegiato tra Milano e Parigi nel sostenere
la musica contemporanea. Sono intervenuti anche
il direttore d'orchestra Michele Gamba che è
entrato in merito al lavoro di Momi; interpreti
come il pianista Filippo Gorini che unirà nel
suo concerto alla Scala la figura di Schubert a
quella di Kurtag. Per finire il consulente
artistico Paolo Petazzi è entrato nei dettagli
della programmazione del Festival. Anche
quest'anno si prevede una forte affluenza di
appassionati nei numerosissimi spazi in cui si
svolgerà la manifestazione italiana più
importante di musica contemporanea.
17 aprile 2024 C.G.
L’ ORCHESTRA DA CAMERA DI
LUGANO E LA PIANISTA MARIA GLORIA FERRARI AL
FESTIVAL CANTELLI DI NOVARA
La stagione del novarese
Festival Cantelli si è conclusa ieri sera,
martedì 16/04, con un concerto al Teatro
Faraggiana, che vedeva protagoniste l’Orchestra
da Camera di Lugano e la pianista Maria Gloria
Ferrari. L’Orchestra di Lugano, di formazione
abbastanza recente (2005), è costituita da
strumentisti professionisti di giovane età, che
vantano tutti significative esperienze in alcune
delle più importanti compagini sinfoniche e
filarmoniche europee, sotto la guida di
prestigiose bacchette. Attualmente l’Orchestra
svizzera è diretta dal Maestro Stefano Bazzi,
con un ottimo curriculum di studi tra Svizzera e
Italia e un’esperienza di notevole spessore su
un repertorio assai esteso, dal Barocco alla
musica contemporanea. Maria Gloria Ferrari vanta
una tappa decisiva del suo iter formativo come
pianista in quanto allieva scelta di A.
Benedetti Michelangeli. All’attività
d’insegnamento presso il Conservatorio G. Verdi
di Milano ha accompagnato un’intensa attività
concertistica, sia come solista, sia con
orchestra, un po’ ovunque in Europa. Di notevole
interesse il programma, che aveva un titolo: “Musique
avec charme”, dunque una musica che si propone
il fascino del suono, delibato anzitutto come
fascinosa esperienza sensoriale, come realtà
assoluta, proprio in
 quanto
suono. A dare inizio a questo ‘charme’ musicale
sono stati eseguiti i “Two Pieces for Small
Orchestra”, di Frederick Delius (1862-1934),
quello che è forse il compositore inglese del
tardo ‘800-primo’900 meno presente nelle sale da
concerto italiane, del tutto ingiustificatamente,
visto il suo ruolo storico di ‘padre’ tra i più
rilevanti della musica inglese di almeno tutta
la prima metà del XX sec. nonché la qualità
notevole di gran parte della sua produzione.
Delius è stato definito “l’impressionista” della
musica inglese, una specie di traduzione inglese
di Debussy: qualunque cosa s’intenda con questo
controverso termine, una volta che dalla pittura
lo si trasferisca alla musica, certamente il
linguaggio musicale di Delius appare
profondamente e, per rimanere in tema con la
serata, fascinosamente innovativo, per i tempi
in cui la sua attività compositiva si colloca. I
“Two Pieces”, composti nel 1911-12, s’intitolano
“On hearing the first Cuckoo in Spring” (‘Ascoltando
il primo cuculo in primavera’) e “Summer night
on the river” (‘Notte d’estate sul fiume’).
Proprio questi due brevi pezzi vengono di solito
citati come la prova più significativa
dell’impressionismo di Delius. In effetti si
tratta di brani di struttura assai libera,
rapsodica, in particolare il secondo, in cui
domina incontrastata un’armonia, molto allargata
rispetto a quella autorizzata dal sistema tonale
tradizionale, sino ai limiti di leggere, dolci
dissonanze, che screziano soprattutto il primo
pezzo: un’armonia intesa ormai in senso
esclusivamente coloristico-timbrico. Eccellente
l’esecuzione dell’Orchestra Svizzera, diretta
con impareggiabile maestria da Bazzi nel
sottolineare le incessanti fluttuazioni, il
continuo gioco di luci e ombre, lo ‘charmant’
variopinto quadro di impasti timbrici sempre
cangianti, instabili, incantevoli sino
all’estasi, nella ricchezza di armonie di una
sottigliezza che la sensibilità e la bravura di
Bazzi hanno saputo cogliere e donare a noi
ascoltatori, in un’esperienza emotiva e
sensoriale molto coinvolgente, velata di
un’impalpabile malinconica dolcezza, che è un
possibile modo, tra i più suggestivi, di
manifestarsi dello charme nella ‘musica’.
Iniziatosi in Inghilterra, il viaggio musicale
proposto dal programma del concerto di ieri in
Francia si trasferiva, con un contemporaneo di
Delius, quel Gabriel Fauré, che, pur appartato e
indipendente quanto
suono. A dare inizio a questo ‘charme’ musicale
sono stati eseguiti i “Two Pieces for Small
Orchestra”, di Frederick Delius (1862-1934),
quello che è forse il compositore inglese del
tardo ‘800-primo’900 meno presente nelle sale da
concerto italiane, del tutto ingiustificatamente,
visto il suo ruolo storico di ‘padre’ tra i più
rilevanti della musica inglese di almeno tutta
la prima metà del XX sec. nonché la qualità
notevole di gran parte della sua produzione.
Delius è stato definito “l’impressionista” della
musica inglese, una specie di traduzione inglese
di Debussy: qualunque cosa s’intenda con questo
controverso termine, una volta che dalla pittura
lo si trasferisca alla musica, certamente il
linguaggio musicale di Delius appare
profondamente e, per rimanere in tema con la
serata, fascinosamente innovativo, per i tempi
in cui la sua attività compositiva si colloca. I
“Two Pieces”, composti nel 1911-12, s’intitolano
“On hearing the first Cuckoo in Spring” (‘Ascoltando
il primo cuculo in primavera’) e “Summer night
on the river” (‘Notte d’estate sul fiume’).
Proprio questi due brevi pezzi vengono di solito
citati come la prova più significativa
dell’impressionismo di Delius. In effetti si
tratta di brani di struttura assai libera,
rapsodica, in particolare il secondo, in cui
domina incontrastata un’armonia, molto allargata
rispetto a quella autorizzata dal sistema tonale
tradizionale, sino ai limiti di leggere, dolci
dissonanze, che screziano soprattutto il primo
pezzo: un’armonia intesa ormai in senso
esclusivamente coloristico-timbrico. Eccellente
l’esecuzione dell’Orchestra Svizzera, diretta
con impareggiabile maestria da Bazzi nel
sottolineare le incessanti fluttuazioni, il
continuo gioco di luci e ombre, lo ‘charmant’
variopinto quadro di impasti timbrici sempre
cangianti, instabili, incantevoli sino
all’estasi, nella ricchezza di armonie di una
sottigliezza che la sensibilità e la bravura di
Bazzi hanno saputo cogliere e donare a noi
ascoltatori, in un’esperienza emotiva e
sensoriale molto coinvolgente, velata di
un’impalpabile malinconica dolcezza, che è un
possibile modo, tra i più suggestivi, di
manifestarsi dello charme nella ‘musica’.
Iniziatosi in Inghilterra, il viaggio musicale
proposto dal programma del concerto di ieri in
Francia si trasferiva, con un contemporaneo di
Delius, quel Gabriel Fauré, che, pur appartato e
indipendente
 da
qualsiasi movimento o scuola del momento, veniva
dando anche lui, soprattutto nella musica da
camera, il suo bravo contributo all’apertura di
nuove prospettive musicali. Di Fauré è stata
proposta una composizione orchestrale del 1919,
la “Suite per orchestra Masques et Bergamasques”
0p. 112, nella versione originaria in quattro
movimenti, che purtroppo esclude
l’indimenticabile “Pavane”, aggiunta solo
successivamente. È una composizione, diremmo ‘neoclassica’,
che rivive, attraverso la forma della Suite di
musiche per danza cara al ‘700, con sentimento
ora spiritoso, ora malinconico, il mondo del
salotto aristocratico di quei tempi, sulla
suggestione del ciclo poetico delle “Fetes
galantes” del grande poeta simbolista Verlaine,
a sua volta ispirato da celebri quadri di
Watteau, che col suo pennello aveva immortalato
quel mondo. Queste note sono necessaria premessa
per comprendere l’interpretazione di Bazzi e
dell’Orchestra di Lugano. Nello stacco dei tempi
e nel suono richiesto all’orchestra, sempre
nitido e preciso, Bazzi crea un’atmosfera di
raffinata ed elegante leggerezza, che si declina
ora come ritmo briosamente spiritoso, specie nei
frequenti richiami a Mozart, appena velato di
malinconia nel secondo tema (Ouverture), ora con
una vena di sottile umorismo (Menuet), o come
puro ritmo, nella sua baldanza giocosa (Gavotte)
o infine come lirismo, sempre contenuto entro
una classica misura (Pastorale). Notevole, in
questa esecuzione, anche l’estrema cura,
riservata da Bazzi ai dettagli timbrici, sempre
seducenti nella ricchezza e varietà della
tavolozza, e dinamici. Restando in Francia,
seguiva un pezzo celeberrimo, il Concerto per
pianoforte e orchestra in Sol maggiore di M.
Ravel. Siamo ormai vent’anni dopo i Two Pieces
di Delius, il clima musicale europeo è
radicalmente cambiato, all’impressionismo
debussyano e non solo si è dato il bando, sia
con l’avanguardia viennese, sia con le varie
declinazioni del cosiddetto neoclassicismo. In
quest’ultimo caso, per il Ravel pianista
soprattutto, lo ‘charme’ va cercato nel nitore,
nelle pagine limpide e cristalline in cui anche
il più arduo virtuosismo si viene sgranando
sulla tastiera. L’interpretazione, eccellente,
di Maria Gloria Ferrari, scaturisce da un
fraseggio elegante e di non grande volume, ma di
seducente eleganza, che mantiene intatta la
propria pulizia formale anche nei ripetuti
glissando e nei vari arabeschi del primo tema
dell’Allegramente iniziale o nello scatenato
terzo tempo Presto, ove il tour de force
virtuosistico del concerto tocca il suo apice.
Ma è un fraseggio, quello della Ferrari, di
grande sensibilità, rispettoso degli elementi
strutturali della partitura, e che interpreta
con grande efficacia anche i momenti più
melodici del concerto, come il seducente blues ‘gershwiniano’
del primo tempo o, e soprattutto, la cantilena,
così apparentemente semplice e così potentemente
suggestiva, dell’Adagio assai centrale, in cui
il suo tocco delicato e morbido dà voce a quel
che di sfuggente è in questo meraviglioso pezzo
(‘tecnicamente’ dovuto ad alcune minime
sfasature negli accenti di battuta). Al
fraseggio si accompagna poi un suono che è
l’evidente frutto di un’arte squisita e di uno
studio meditato del concerto di Ravel, che
sappiamo dalle note di sala essere uno dei suoi
autori prediletti (avrà pur contato anche in
questo l’essere stata allieva di Benedetti
Michelangeli!). È un suono che, duttile nel
vario alternarsi delle dinamiche, sa essere di
aerea delicatezza in alcuni momenti-chiave,
quali la ripresa del secondo tema
dell’Allegramente, e soprattutto nel grandissimo
Adagio assai, ove il lunghissimo tema affidato
in cadenza al pianoforte trova, grazie a quel
suono, il ‘volume’ giusto, di dimessa dolcezza,
privo di accensioni, quasi piatto e monotono,
che è il suono puro della malinconia nella sua
quintessenza. Quando poi, dopo l’intervento
dell’orchestra, affiorano i timbri del corno
inglese e del fagotto, il colore del suono del
pianoforte cambia, si fa come vitreo, con un che
di irrigidito nella sua cristallina purezza, per
poi, ci è parso, quasi dissolversi negli
arpeggiati, quasi in un colore liquido che
culmina nel trillo finale. Davvero una
bellissima interpretazione, di rara finezza e
classe nella ricerca espressiva attraverso i
suoni. Ovviamente spetta un alto titolo di
merito all’ottima riuscita di questo concerto
raveliano anche alla valida direzione di Bazzi,
che ha sempre tenuto un perfetto equilibrio dei
piani sonori, con un intenso dialogo strumentale
nelle varie soluzioni timbriche della partitura
e nel dialogo costante con il pianoforte. Gli
applausi scroscianti del pubblico hanno ottenuto
due fuori programma: uno pianistico, chopiniano,
uno Chopin di elegante e delicata misura,
secondo lo stile della Ferrari; e uno
orchestrale, l’Intermezzo della Carmen di Bizet.
Gli Amici della Musica di Novara hanno voluto
salutare il loro pubblico con un concerto
all’insegna della bellezza e dello charme. Sono
stati ripagati da grandi, meritati applausi, che
sono anche applausi di riconoscenza per la bella
musica di cui, anche quest’anno, hanno fatto
dono alla città. da
qualsiasi movimento o scuola del momento, veniva
dando anche lui, soprattutto nella musica da
camera, il suo bravo contributo all’apertura di
nuove prospettive musicali. Di Fauré è stata
proposta una composizione orchestrale del 1919,
la “Suite per orchestra Masques et Bergamasques”
0p. 112, nella versione originaria in quattro
movimenti, che purtroppo esclude
l’indimenticabile “Pavane”, aggiunta solo
successivamente. È una composizione, diremmo ‘neoclassica’,
che rivive, attraverso la forma della Suite di
musiche per danza cara al ‘700, con sentimento
ora spiritoso, ora malinconico, il mondo del
salotto aristocratico di quei tempi, sulla
suggestione del ciclo poetico delle “Fetes
galantes” del grande poeta simbolista Verlaine,
a sua volta ispirato da celebri quadri di
Watteau, che col suo pennello aveva immortalato
quel mondo. Queste note sono necessaria premessa
per comprendere l’interpretazione di Bazzi e
dell’Orchestra di Lugano. Nello stacco dei tempi
e nel suono richiesto all’orchestra, sempre
nitido e preciso, Bazzi crea un’atmosfera di
raffinata ed elegante leggerezza, che si declina
ora come ritmo briosamente spiritoso, specie nei
frequenti richiami a Mozart, appena velato di
malinconia nel secondo tema (Ouverture), ora con
una vena di sottile umorismo (Menuet), o come
puro ritmo, nella sua baldanza giocosa (Gavotte)
o infine come lirismo, sempre contenuto entro
una classica misura (Pastorale). Notevole, in
questa esecuzione, anche l’estrema cura,
riservata da Bazzi ai dettagli timbrici, sempre
seducenti nella ricchezza e varietà della
tavolozza, e dinamici. Restando in Francia,
seguiva un pezzo celeberrimo, il Concerto per
pianoforte e orchestra in Sol maggiore di M.
Ravel. Siamo ormai vent’anni dopo i Two Pieces
di Delius, il clima musicale europeo è
radicalmente cambiato, all’impressionismo
debussyano e non solo si è dato il bando, sia
con l’avanguardia viennese, sia con le varie
declinazioni del cosiddetto neoclassicismo. In
quest’ultimo caso, per il Ravel pianista
soprattutto, lo ‘charme’ va cercato nel nitore,
nelle pagine limpide e cristalline in cui anche
il più arduo virtuosismo si viene sgranando
sulla tastiera. L’interpretazione, eccellente,
di Maria Gloria Ferrari, scaturisce da un
fraseggio elegante e di non grande volume, ma di
seducente eleganza, che mantiene intatta la
propria pulizia formale anche nei ripetuti
glissando e nei vari arabeschi del primo tema
dell’Allegramente iniziale o nello scatenato
terzo tempo Presto, ove il tour de force
virtuosistico del concerto tocca il suo apice.
Ma è un fraseggio, quello della Ferrari, di
grande sensibilità, rispettoso degli elementi
strutturali della partitura, e che interpreta
con grande efficacia anche i momenti più
melodici del concerto, come il seducente blues ‘gershwiniano’
del primo tempo o, e soprattutto, la cantilena,
così apparentemente semplice e così potentemente
suggestiva, dell’Adagio assai centrale, in cui
il suo tocco delicato e morbido dà voce a quel
che di sfuggente è in questo meraviglioso pezzo
(‘tecnicamente’ dovuto ad alcune minime
sfasature negli accenti di battuta). Al
fraseggio si accompagna poi un suono che è
l’evidente frutto di un’arte squisita e di uno
studio meditato del concerto di Ravel, che
sappiamo dalle note di sala essere uno dei suoi
autori prediletti (avrà pur contato anche in
questo l’essere stata allieva di Benedetti
Michelangeli!). È un suono che, duttile nel
vario alternarsi delle dinamiche, sa essere di
aerea delicatezza in alcuni momenti-chiave,
quali la ripresa del secondo tema
dell’Allegramente, e soprattutto nel grandissimo
Adagio assai, ove il lunghissimo tema affidato
in cadenza al pianoforte trova, grazie a quel
suono, il ‘volume’ giusto, di dimessa dolcezza,
privo di accensioni, quasi piatto e monotono,
che è il suono puro della malinconia nella sua
quintessenza. Quando poi, dopo l’intervento
dell’orchestra, affiorano i timbri del corno
inglese e del fagotto, il colore del suono del
pianoforte cambia, si fa come vitreo, con un che
di irrigidito nella sua cristallina purezza, per
poi, ci è parso, quasi dissolversi negli
arpeggiati, quasi in un colore liquido che
culmina nel trillo finale. Davvero una
bellissima interpretazione, di rara finezza e
classe nella ricerca espressiva attraverso i
suoni. Ovviamente spetta un alto titolo di
merito all’ottima riuscita di questo concerto
raveliano anche alla valida direzione di Bazzi,
che ha sempre tenuto un perfetto equilibrio dei
piani sonori, con un intenso dialogo strumentale
nelle varie soluzioni timbriche della partitura
e nel dialogo costante con il pianoforte. Gli
applausi scroscianti del pubblico hanno ottenuto
due fuori programma: uno pianistico, chopiniano,
uno Chopin di elegante e delicata misura,
secondo lo stile della Ferrari; e uno
orchestrale, l’Intermezzo della Carmen di Bizet.
Gli Amici della Musica di Novara hanno voluto
salutare il loro pubblico con un concerto
all’insegna della bellezza e dello charme. Sono
stati ripagati da grandi, meritati applausi, che
sono anche applausi di riconoscenza per la bella
musica di cui, anche quest’anno, hanno fatto
dono alla città.
18 aprile 2024 Bruno Busca
Elisso Virsaladze
alle Serate Musicali del Conservatorio
Torna
puntualmente per Serate Musicali la
pianista georgiana Elisso Virsaladze. Dal 1992 è
ospite dell'importante società concertistica e
sempre ha impaginato programmi diversificati in
concerti come quello cui abbiamo assistito ieri
sera. Schubert, Brahms, Liszt e Prokofiev sono
stati interpretati con una facilità discorsiva
tipica di chi ha
 interiorizzato
ogni frangente di brani spesso molto complessi e
articolati. I schubertiani Sei momenti
Musicali D780 Op.94 hanno introdotto la
serata rivelando una leggerezza di tocco mediata
da sottili escursioni dinamiche, per una
restituzione espressiva e di ottimo valore
estetico. Il brano successivo , la Sonata per
pianoforte n.1 in do maggiore Op.1 è un
lavoro giovanile di Brahms con i classici
quattro movimenti che rivelano una costruzione
articolata e già costitutiva del linguaggio del
compositore amburghese. La Virsaldze ha eseguito
questa rarità esecutiva con equilibrio,
sicurezza e penetrazione espressiva di
eccellente livello. Di romantica valenza
estetica nella interiorizzato
ogni frangente di brani spesso molto complessi e
articolati. I schubertiani Sei momenti
Musicali D780 Op.94 hanno introdotto la
serata rivelando una leggerezza di tocco mediata
da sottili escursioni dinamiche, per una
restituzione espressiva e di ottimo valore
estetico. Il brano successivo , la Sonata per
pianoforte n.1 in do maggiore Op.1 è un
lavoro giovanile di Brahms con i classici
quattro movimenti che rivelano una costruzione
articolata e già costitutiva del linguaggio del
compositore amburghese. La Virsaldze ha eseguito
questa rarità esecutiva con equilibrio,
sicurezza e penetrazione espressiva di
eccellente livello. Di romantica valenza
estetica nella
 leggerezza
interpretativa i due noti brani di Franz Liszt:
prima da Consolations il n.3 Lento
placido, quindi da i Tre studi da
concerto "Il Lamento". L'ultimo
brano del programma, la celebre Sonata n.7
Op.83 "Stalingrado" è probabilmente la più
eseguita di Prokofiev, anche per via di quel
ritmico Precipitato, ultimo dei tre
movimenti che la compongono. La Virsalazde con
un'ottima lettura, ha restituito tutte le
caratteristiche della geniale musica di
Prokofiev, ricca di geometrie, simmetrie e
astratte visioni. Un'interpretazione di alto
spessore. Applausi sostenuti e due i bis
concessi, entrambi di Schubert: prima un breve
valzer e poi il celebre ed eccellente
brano da Soirées de Vienne, il n.6 "Valse
caprice". Splendida serata! leggerezza
interpretativa i due noti brani di Franz Liszt:
prima da Consolations il n.3 Lento
placido, quindi da i Tre studi da
concerto "Il Lamento". L'ultimo
brano del programma, la celebre Sonata n.7
Op.83 "Stalingrado" è probabilmente la più
eseguita di Prokofiev, anche per via di quel
ritmico Precipitato, ultimo dei tre
movimenti che la compongono. La Virsalazde con
un'ottima lettura, ha restituito tutte le
caratteristiche della geniale musica di
Prokofiev, ricca di geometrie, simmetrie e
astratte visioni. Un'interpretazione di alto
spessore. Applausi sostenuti e due i bis
concessi, entrambi di Schubert: prima un breve
valzer e poi il celebre ed eccellente
brano da Soirées de Vienne, il n.6 "Valse
caprice". Splendida serata!
16 aprile
2024
Cesare Guzzardella
Alla Scala successo
meritatissimo per La Rondine di Puccini
diretta da Riccardo Chailly
Un successo meritato per La
Rondine, commedia lirica in tre atti di Giacomo
Puccini su libretto di Giuseppe Adami,
presentata alla Scala in una messa in scena
curata da Ditlev Rindom nel 2023 che rivela
alcune differenze rispetto alla prima edizione
del 1917. È un'opera tra il leggero e il
 drammatico, come risulta nel finale del terzo
atto, dove la musica pucciniana è
particolarmente piacevole nella genuinità del
personalissimo linguaggio del grande compositore
toscano, inventore di arie anche leggere, ma non
per questo non rilevanti. La sua geniale
capacità di armonizzazione, con le ricercate
timbriche orchestrali, è stata resa in modo
eccellente da Riccardo Chailly, un direttore
affascinato dalla musica pucciniana, drammatico, come risulta nel finale del terzo
atto, dove la musica pucciniana è
particolarmente piacevole nella genuinità del
personalissimo linguaggio del grande compositore
toscano, inventore di arie anche leggere, ma non
per questo non rilevanti. La sua geniale
capacità di armonizzazione, con le ricercate
timbriche orchestrali, è stata resa in modo
eccellente da Riccardo Chailly, un direttore
affascinato dalla musica pucciniana,
 attento ad
ogni dettaglio e ad ogni perfetto inserimento
delle voci nella componente strumentale. È un
gioiello di raffinatezze melodiche questo lavoro
purtroppo eseguito troppo poco rispetto quello
che meriterebbe, che trova come riferimento
quello ben più celebre di Bohème, per la
presenza di numerose situazioni simili. La regia
di Irina Brook, supportata dalle originali scene
e i coloratissimi costumi di Patrik Kinmonth,
dalle luminose luci di Marco Filibeck e dalla
valida coreografia di Paul Pui Wo Lee, ci è
piaciuta molto, soprattutto per attento ad
ogni dettaglio e ad ogni perfetto inserimento
delle voci nella componente strumentale. È un
gioiello di raffinatezze melodiche questo lavoro
purtroppo eseguito troppo poco rispetto quello
che meriterebbe, che trova come riferimento
quello ben più celebre di Bohème, per la
presenza di numerose situazioni simili. La regia
di Irina Brook, supportata dalle originali scene
e i coloratissimi costumi di Patrik Kinmonth,
dalle luminose luci di Marco Filibeck e dalla
valida coreografia di Paul Pui Wo Lee, ci è
piaciuta molto, soprattutto per
 l'ottima
sintonia con la musica e i repentini cambiamenti
dei personaggi in gioco. L'ottimo cast vocale ha
trovato in Mariangela Sicilia, Magda, la
voce più convincente, e nella quinta
rappresentazione da me vista, anche la più
applaudita. Ottimi anche Matteo Lippi in
Ruggero, Rosalia Cid in Lisette,
Giovanni Sala in Prunier, Pietro Spagnoli
in Rambaldo, William Allione in
Perichaud e tutti gli altri. Il coro di
Alberto Malazzi, di grande potenza espressiva
nel secondo atto, è stato come sempre al top.
Uno spettacolo decisamente riuscito che avrà
ancora una replica il 20 aprile. Da non perdere.
(Foto di Brescia e di Amisano -Archivio della
Scala) l'ottima
sintonia con la musica e i repentini cambiamenti
dei personaggi in gioco. L'ottimo cast vocale ha
trovato in Mariangela Sicilia, Magda, la
voce più convincente, e nella quinta
rappresentazione da me vista, anche la più
applaudita. Ottimi anche Matteo Lippi in
Ruggero, Rosalia Cid in Lisette,
Giovanni Sala in Prunier, Pietro Spagnoli
in Rambaldo, William Allione in
Perichaud e tutti gli altri. Il coro di
Alberto Malazzi, di grande potenza espressiva
nel secondo atto, è stato come sempre al top.
Uno spettacolo decisamente riuscito che avrà
ancora una replica il 20 aprile. Da non perdere.
(Foto di Brescia e di Amisano -Archivio della
Scala)
15 aprile 2024 Cesare Guzzardella
A VERCELLI UN
GRANDE VIOTTI PER IL BICENTENARIO
Ieri sera, sabato 13/04, il
violinista e direttore Guido Rimonda con
l’orchestra Camerata Ducale, ha degnamente
festeggiato, al Teatro Civico di Vercelli, il
bicentenario della morte di G. B. Viotti, cui è
peraltro dedicata l’intera stagione in corso,
con un concerto che proponeva, su tre pezzi, due
dei ventinove concerti per violino del grande
musicista vercellese: il n. 4 in RE maggiore WI
4 e il n. 28 in La minore WI 28. La serata era
poi conclusa da un capolavoro di F. J. Haydn, la
sinfonia n. 104 in RE maggiore, Hob I: 104, nota
come ‘Londra’. Il Maestro Rimonda ha dedicato
alla figura e alla musica di G. B. Viotti studi
intensi ed approfonditi, che lo hanno reso uno
dei massimi esperti al mondo di questo
violinista e compositore che fu tra i più grandi
e celebri in Europa tra ‘700 e ‘800, ammirato da
geni quali Beethoven e Brahms, ma, abbastanza
inspiegabilmente, caduto in un quasi completo
oblio dopo la comparsa di Paganini, che pure di
Viotti aveva grande considerazione e al Maestro
vercellese deve non poco della sua arte. Un
oblio cui l’indefessa attività di studioso e di
violinista -direttore di Guido Rimonda ha il
sommo merito di aver sottratto in questi anni
uno dei pochi grandi della musica strumentale
italiana dal tardo ‘700 in poi. Sfogliando le
pagine dedicate a Viotti in saggi critici e
storici, a definire la sua musica compare
sovente l’aggettivo ‘accattivante’. In cosa è
precisamente accattivante la musica di Viotti?
C’è un passaggio nel secondo tempo, Romance, del
 Concerto
n. 4 che ci appare al riguardo particolarmente
significativo: il tempo si apre e prosegue per
una serie piuttosto numerosa di battute, con una
melodia di limpida serenità, in cui si avverte
più di un’eco del bel canto italiano dell’epoca.
All’improvviso, come un fulmine inaspettato, il
violino introduce un tema inquieto, di un pathos
piuttosto mosso ritmicamente, con un acuto
stridente che spezza quasi brutalmente
l’abbandono incantato alla precedente melodia,
che, dopo poche battute riprende come nulla
fosse accaduto. È questo, secondo noi, il tratto
particolare e affascinante del miglior Viotti,
questa espressività in fondo ambigua e
sorprendente, sospesa tra dolcezza serena del
classicismo del pieno ‘700 e brividi
d’inquietudine che lo pongono sulla linea di
quell’estetica del Sublime, che a fine ‘700
dominava l’arte europea che oggi diremmo
d’avanguardia e irraggiava i primi bagliori
della sorgente sensibilità romantica. Per
rendere al meglio questa musica, le qualità di
Rimonda, sia come direttore, sia come violinista,
sono pienamente adeguate: dotato di una cavata
espressiva ed energica ad un tempo, di un suono
puro e ricco di sfumature, di una tecnica di
rara perfezione nei vari colpi d’arco e negli
effetti che è possibile ottenerne, sino al
virtuosismo più arduo, come nella cadenza del
Maestoso iniziale, di un fraseggio molto duttile
nelle dinamiche, Rimonda ha fornito di questo
quarto concerto viottiano un’interpretazione da
antologia, assecondata da una Camerata Ducale
che ha ormai maturato un suono di raffinata
eleganza e sensibilità timbrica, giocata
peraltro, in questa composizione,
prevalentemente sulla sezione degli archi,
essendo i fiati ridotti all’essenziale, con due
oboi e due corni. Perfetto, in particolare, il
Maestoso iniziale, in cui la solennità del tema
d’attacco è temperata da quella eleganza di cui
accennavamo poc’anzi, e inciso con precisione è
il vario alternarsi dei ritmi, dal canto
spiegato ai momenti di più rapida e robusta
agogica. Facendo del suo arco un pennello capace
di usare al meglio i più diversi colori, Rimonda
dà voce tanto al fluire delle melodie più dolci
della Romance centrale, Concerto
n. 4 che ci appare al riguardo particolarmente
significativo: il tempo si apre e prosegue per
una serie piuttosto numerosa di battute, con una
melodia di limpida serenità, in cui si avverte
più di un’eco del bel canto italiano dell’epoca.
All’improvviso, come un fulmine inaspettato, il
violino introduce un tema inquieto, di un pathos
piuttosto mosso ritmicamente, con un acuto
stridente che spezza quasi brutalmente
l’abbandono incantato alla precedente melodia,
che, dopo poche battute riprende come nulla
fosse accaduto. È questo, secondo noi, il tratto
particolare e affascinante del miglior Viotti,
questa espressività in fondo ambigua e
sorprendente, sospesa tra dolcezza serena del
classicismo del pieno ‘700 e brividi
d’inquietudine che lo pongono sulla linea di
quell’estetica del Sublime, che a fine ‘700
dominava l’arte europea che oggi diremmo
d’avanguardia e irraggiava i primi bagliori
della sorgente sensibilità romantica. Per
rendere al meglio questa musica, le qualità di
Rimonda, sia come direttore, sia come violinista,
sono pienamente adeguate: dotato di una cavata
espressiva ed energica ad un tempo, di un suono
puro e ricco di sfumature, di una tecnica di
rara perfezione nei vari colpi d’arco e negli
effetti che è possibile ottenerne, sino al
virtuosismo più arduo, come nella cadenza del
Maestoso iniziale, di un fraseggio molto duttile
nelle dinamiche, Rimonda ha fornito di questo
quarto concerto viottiano un’interpretazione da
antologia, assecondata da una Camerata Ducale
che ha ormai maturato un suono di raffinata
eleganza e sensibilità timbrica, giocata
peraltro, in questa composizione,
prevalentemente sulla sezione degli archi,
essendo i fiati ridotti all’essenziale, con due
oboi e due corni. Perfetto, in particolare, il
Maestoso iniziale, in cui la solennità del tema
d’attacco è temperata da quella eleganza di cui
accennavamo poc’anzi, e inciso con precisione è
il vario alternarsi dei ritmi, dal canto
spiegato ai momenti di più rapida e robusta
agogica. Facendo del suo arco un pennello capace
di usare al meglio i più diversi colori, Rimonda
dà voce tanto al fluire delle melodie più dolci
della Romance centrale,
 quanto
alle ombre che in essa affiorano, così come alla
vena gioiosa, di vago sapore popolaresco,
dell’Allegro finale. Il successivo concerto, il
n.28, databile intorno al 1803-4, appartiene al
periodo del secondo soggiorno inglese di Viotti.
Presenta, a differenza del precedente,
un’orchestrazione molto più ricca, con una
sezione dei fiati con tutti i legni, cui si
aggiungono corni e trombe a due, con una
conseguente tavolozza timbrica assai più estesa
e varia. Il primo tempo, Moderato, è esemplare
di quella ‘poetica del contrasto’, come potremmo
definire l’essenza espressiva della musica di
Viotti: momenti di intimo ripiegamento
espressivo aprono squarci improvvisi in una
linea musicale dominante, a carattere assertivo,
quasi imperioso. Dopo l’introduzione orchestrale
è il violino a reggere il gioco, con energia e
sottile ricerca espressiva, peraltro
interloquendo con l’orchestra in un gioco
timbrico abbastanza vario e raffinato. Il
purtroppo breve tempo centrale Andante sostenuto
è senz’altro il gioiello di questo concerto: lo
avvolge un’atmosfera di cosmica tristezza, che
si declina ora come solenne pensosità, ora come
pathos venato di intima malinconia, in un flusso
melodico che il fraseggio del leggendario
violino Noir di Rimonda interpreta con sapienza,
coi suoi delicati chiaroscuri, accuratissimo
nella calibratura delle dinamiche, puntuale
nelle escursioni lungo la tessitura dello
strumento, dai registri acuti a quelli più gravi.
Senz’altro brioso e gioioso, coi suoi ritmi da
danza popolare, come già nel tempo di chiusura
del concerto n.8, è il finale Allegretto vivo,
dove peraltro il piglio giocoso sembra talvolta
come avvolto in un impalpabile velo di
malinconia. Un bellissimo concerto, interpretato
in modo davvero superbo da un grande Rimonda.
Gli scroscianti appalusi del sempre numeroso
pubblico ottenevano da Rimonda, come fuori
programma, uno dei suoi pezzi di baule Il tema
della Marsigliese con variazioni di Viotti.
Chiudeva la serata l’ultima sinfonia di Haydn,
la 104 , ‘Londra’ , composta nel 1795 subito
prima della sua definitiva partenza dalla Gran
Bretagna, quando anche Viotti vi trascorreva il
suo primo soggiorno, costretto nel 1793 a
fuggire precipitosamente dalla Francia in piena
Rivoluzione, inseguito da un’accusa, poi
dimostratasi falsa, di attività politica
filomonarchica: In questi due anni di comune
soggiorno in terra britannica Haydn e Viotti si
conobbero anche personalmente, presentati dal
loro comune ‘mecenate’ Salomon. Al di là dei
rapporti personali, ascoltando questa sinfonia
di Haydn, sentiamo circolare, pur nelle
differenze del linguaggio musicale dei due
autori, un’aria comune alla musica di Haydn e di
Viotti. Se consideriamo l’Andante della 104,
formalmente un tema con variazioni, siamo
colpiti da quella ‘poetica del contrasto’ che
abbiamo già notato in Viotti, sfruttata dal
Maestro di Rohrau in modo senz’altro più
radicale: lavorando più sulla trasformazione del
tema che sul contrasto tra temi diversi, Haydn
spezza la placida serenità del motivo d’apertura
con continue sorprese armoniche e dinamiche, con
sospensioni improvvise, sino a raggiungere
vertici di potente e suggestiva tensione
drammatica. È evidente che Haydn e Viotti sono
compagni di strada, stanno percorrendo un
cammino comune, che porta fuori dal classicismo
per approdare a nuove soluzioni espressive che
hanno il loro perno nell’imprevedibilità e nella
tensione cui è sottoposto il materiale musicale.
Ancora una volta, la Camerata Ducale, sotto la
guida di Rimonda, offre al pubblico del Civico
un’interpretazione inappuntabile di un
capolavoro, sottolineandone la tensione
dominante già dall’Adagio introduttivo, con un
energico gioco di contrasti drammatici tra
l’inciso motivico a piena orchestra e i
frammenti melodici di violini e fiati. Ottimo il
fraseggio, sempre sorretto da un compiuto
equilibrio dei vari piani sonori, che scolpisce
la tensione dello sviluppo del successivo
Allegro e il suo finale placarsi in un clima più
sereno. Pregevole lo stacco dei tempi del
Minuetto e trascinante il brillante finale su un
tema di una ballata popolare croata, il tutto
diretto con raffinatezza nella valorizzazione
della complessa timbrica del pezzo. Ottima
serata di musica, applauditissima da un pubblico
come sempre accorso numeroso. quanto
alle ombre che in essa affiorano, così come alla
vena gioiosa, di vago sapore popolaresco,
dell’Allegro finale. Il successivo concerto, il
n.28, databile intorno al 1803-4, appartiene al
periodo del secondo soggiorno inglese di Viotti.
Presenta, a differenza del precedente,
un’orchestrazione molto più ricca, con una
sezione dei fiati con tutti i legni, cui si
aggiungono corni e trombe a due, con una
conseguente tavolozza timbrica assai più estesa
e varia. Il primo tempo, Moderato, è esemplare
di quella ‘poetica del contrasto’, come potremmo
definire l’essenza espressiva della musica di
Viotti: momenti di intimo ripiegamento
espressivo aprono squarci improvvisi in una
linea musicale dominante, a carattere assertivo,
quasi imperioso. Dopo l’introduzione orchestrale
è il violino a reggere il gioco, con energia e
sottile ricerca espressiva, peraltro
interloquendo con l’orchestra in un gioco
timbrico abbastanza vario e raffinato. Il
purtroppo breve tempo centrale Andante sostenuto
è senz’altro il gioiello di questo concerto: lo
avvolge un’atmosfera di cosmica tristezza, che
si declina ora come solenne pensosità, ora come
pathos venato di intima malinconia, in un flusso
melodico che il fraseggio del leggendario
violino Noir di Rimonda interpreta con sapienza,
coi suoi delicati chiaroscuri, accuratissimo
nella calibratura delle dinamiche, puntuale
nelle escursioni lungo la tessitura dello
strumento, dai registri acuti a quelli più gravi.
Senz’altro brioso e gioioso, coi suoi ritmi da
danza popolare, come già nel tempo di chiusura
del concerto n.8, è il finale Allegretto vivo,
dove peraltro il piglio giocoso sembra talvolta
come avvolto in un impalpabile velo di
malinconia. Un bellissimo concerto, interpretato
in modo davvero superbo da un grande Rimonda.
Gli scroscianti appalusi del sempre numeroso
pubblico ottenevano da Rimonda, come fuori
programma, uno dei suoi pezzi di baule Il tema
della Marsigliese con variazioni di Viotti.
Chiudeva la serata l’ultima sinfonia di Haydn,
la 104 , ‘Londra’ , composta nel 1795 subito
prima della sua definitiva partenza dalla Gran
Bretagna, quando anche Viotti vi trascorreva il
suo primo soggiorno, costretto nel 1793 a
fuggire precipitosamente dalla Francia in piena
Rivoluzione, inseguito da un’accusa, poi
dimostratasi falsa, di attività politica
filomonarchica: In questi due anni di comune
soggiorno in terra britannica Haydn e Viotti si
conobbero anche personalmente, presentati dal
loro comune ‘mecenate’ Salomon. Al di là dei
rapporti personali, ascoltando questa sinfonia
di Haydn, sentiamo circolare, pur nelle
differenze del linguaggio musicale dei due
autori, un’aria comune alla musica di Haydn e di
Viotti. Se consideriamo l’Andante della 104,
formalmente un tema con variazioni, siamo
colpiti da quella ‘poetica del contrasto’ che
abbiamo già notato in Viotti, sfruttata dal
Maestro di Rohrau in modo senz’altro più
radicale: lavorando più sulla trasformazione del
tema che sul contrasto tra temi diversi, Haydn
spezza la placida serenità del motivo d’apertura
con continue sorprese armoniche e dinamiche, con
sospensioni improvvise, sino a raggiungere
vertici di potente e suggestiva tensione
drammatica. È evidente che Haydn e Viotti sono
compagni di strada, stanno percorrendo un
cammino comune, che porta fuori dal classicismo
per approdare a nuove soluzioni espressive che
hanno il loro perno nell’imprevedibilità e nella
tensione cui è sottoposto il materiale musicale.
Ancora una volta, la Camerata Ducale, sotto la
guida di Rimonda, offre al pubblico del Civico
un’interpretazione inappuntabile di un
capolavoro, sottolineandone la tensione
dominante già dall’Adagio introduttivo, con un
energico gioco di contrasti drammatici tra
l’inciso motivico a piena orchestra e i
frammenti melodici di violini e fiati. Ottimo il
fraseggio, sempre sorretto da un compiuto
equilibrio dei vari piani sonori, che scolpisce
la tensione dello sviluppo del successivo
Allegro e il suo finale placarsi in un clima più
sereno. Pregevole lo stacco dei tempi del
Minuetto e trascinante il brillante finale su un
tema di una ballata popolare croata, il tutto
diretto con raffinatezza nella valorizzazione
della complessa timbrica del pezzo. Ottima
serata di musica, applauditissima da un pubblico
come sempre accorso numeroso.
14 aprile 2024 Bruno Busca
Il pianista Nobuyuki Tsujii
per Grieg, Maggese di Del Corno e Pini
Romani di Respighi diretti da Sesto Quatrini
Il
concerto ascoltato
all'Auditorium milanese, denominato "Serate
romane", ha visto alla direzione della
Sinfonica di Milano il quarantenne romano Sesto
Quatrini per tre brani diversi, ma aventi in
comune timbriche per alcuni aspetti legati alla
mondo paesaggistico. Il Concerto per
pianoforte e orchestra in La minore Op.16 di
Edvard Grieg, Maggese, recente
composizione per orchestra di Filippo Del Corno
e il celebre Pini di Roma di Ottorino
Respighi, utilizzato
 anche per il noto film
Fantasia 2000 di Walt Disney, attraverso
frangenti di efficaci suggestioni coloristiche
non possono non richiamare al mondo
dell'osservazione. Il noto Concerto op.16
(1868) del norvegese Grieg (1843-1907), ha trovato al pianoforte l'affermato pianista
giapponese trentacinquenne Nobuyuki Tsujii, un
eccellente interprete già venuto in Auditorium
per uno straordinario concerto di Rachmaninov.
Ottima l'interpretazione elargita, sia grazie
all'espressività della componente solistica che
alla decisa direzione di Quatrini, che ha
trovato una valida restituzione in ogni sezione
orchestrale. Nobu, applaudito con entusiasmo dal
numeroso pubblico presente, ha ringraziato il
pubblico concedendo ben tre bis: due Pezzi
lirici, op.12 n.1 "Arietta" e
op.65 n.6 "Wedding day" sempre del
compositore norvegese e centralmente,il noto
Studio da Concerto n.1 del
pianista-compositore russo Nikolai Kapustin
eseguito con grinta e chiarezza superlativa.
Un'ovazione con applausi interminabili per Nobu.
Dopo l'intervallo la Prima esecuzione assoluta
di Maggese (2023), recente composizione
del milanese Filippo Del Corno (1970) era una
commissione dell'Orchestra Sinfonica milanese e della Fondazione Arturo Toscanini di Parma. anche per il noto film
Fantasia 2000 di Walt Disney, attraverso
frangenti di efficaci suggestioni coloristiche
non possono non richiamare al mondo
dell'osservazione. Il noto Concerto op.16
(1868) del norvegese Grieg (1843-1907), ha trovato al pianoforte l'affermato pianista
giapponese trentacinquenne Nobuyuki Tsujii, un
eccellente interprete già venuto in Auditorium
per uno straordinario concerto di Rachmaninov.
Ottima l'interpretazione elargita, sia grazie
all'espressività della componente solistica che
alla decisa direzione di Quatrini, che ha
trovato una valida restituzione in ogni sezione
orchestrale. Nobu, applaudito con entusiasmo dal
numeroso pubblico presente, ha ringraziato il
pubblico concedendo ben tre bis: due Pezzi
lirici, op.12 n.1 "Arietta" e
op.65 n.6 "Wedding day" sempre del
compositore norvegese e centralmente,il noto
Studio da Concerto n.1 del
pianista-compositore russo Nikolai Kapustin
eseguito con grinta e chiarezza superlativa.
Un'ovazione con applausi interminabili per Nobu.
Dopo l'intervallo la Prima esecuzione assoluta
di Maggese (2023), recente composizione
del milanese Filippo Del Corno (1970) era una
commissione dell'Orchestra Sinfonica milanese e della Fondazione Arturo Toscanini di Parma.
 Il valido
brano ci ha rivelato un compositore
particolarmente sinfonico. Sono circa 15 minuti
d'intensa musica che nascono dopo un lungo
periodo - circa otto anni- nel quale il
musicista aveva lasciato la composizione per
l'impegno politico e amministrativo (Assessore
alla cultura) nella sua e nostra città. Un
ritorno felice alla composizione con un efficace
lavoro che pur nella piacevole titolazione,
risente del difficile periodo storico in cui
stiamo vivendo. Nella varietà d'articolazione
dell'unico movimento, sono riconoscibili quattro
parti contrastanti che alternano timbriche forti
ed incisive ad altre più tenui, in un complesso
di suoni-immagini che ci sembrano adattissime
per il mondo del cinema e che hanno
un'impalcatura compositiva assai solida con una
presenza di una strumentazione molto varia dove
risalta una componente ritmico-percussiva. Un
lavoro scritto molto bene, di non difficile
comprensione Il valido
brano ci ha rivelato un compositore
particolarmente sinfonico. Sono circa 15 minuti
d'intensa musica che nascono dopo un lungo
periodo - circa otto anni- nel quale il
musicista aveva lasciato la composizione per
l'impegno politico e amministrativo (Assessore
alla cultura) nella sua e nostra città. Un
ritorno felice alla composizione con un efficace
lavoro che pur nella piacevole titolazione,
risente del difficile periodo storico in cui
stiamo vivendo. Nella varietà d'articolazione
dell'unico movimento, sono riconoscibili quattro
parti contrastanti che alternano timbriche forti
ed incisive ad altre più tenui, in un complesso
di suoni-immagini che ci sembrano adattissime
per il mondo del cinema e che hanno
un'impalcatura compositiva assai solida con una
presenza di una strumentazione molto varia dove
risalta una componente ritmico-percussiva. Un
lavoro scritto molto bene, di non difficile
comprensione
 e di valida resa emotiva,
restituito con chiarezza dalla direzione di
Quatrini. Applausi convinti del pubblico agli
interpreti e anche al musicista salito sul
palcoscenico. L'ultimo brano, Pini di Roma
(1924), e diviso in quattro movimenti tanto
celebri quanto splendidi, che ci rivelano ancora
le abilità del grande Respighi (1879-1936), il
più eseguito dei compositori italiani della sua
generazione. Pur essendo nato a Bologna, i
lavori sono spesso legati a Roma, città dove ha
insegnato, dove ha composto le più importanti
opere e dove è vissuto a lungo. Respighi ha
segnato i primi decenni del Novecento italiano
per la qualità compositiva e per l'eccellenza
delle sue orchestrazioni. Un'esecuzione di
ottima qualità quella ascoltata ieri sera, che
ha ricevuto un tripudio di applausi. Domenica
alle ore 16.00 la replica certamente da non
perdere! e di valida resa emotiva,
restituito con chiarezza dalla direzione di
Quatrini. Applausi convinti del pubblico agli
interpreti e anche al musicista salito sul
palcoscenico. L'ultimo brano, Pini di Roma
(1924), e diviso in quattro movimenti tanto
celebri quanto splendidi, che ci rivelano ancora
le abilità del grande Respighi (1879-1936), il
più eseguito dei compositori italiani della sua
generazione. Pur essendo nato a Bologna, i
lavori sono spesso legati a Roma, città dove ha
insegnato, dove ha composto le più importanti
opere e dove è vissuto a lungo. Respighi ha
segnato i primi decenni del Novecento italiano
per la qualità compositiva e per l'eccellenza
delle sue orchestrazioni. Un'esecuzione di
ottima qualità quella ascoltata ieri sera, che
ha ricevuto un tripudio di applausi. Domenica
alle ore 16.00 la replica certamente da non
perdere!
13 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
Il violoncello di Ettore
Pagano ai Pomeriggi Musicali del Dal
Verme
Tre
brani molto diversi tra loro hanno impegnato
l'Orchestra de "I Pomeriggi Musicali" diretta da
James Feddeck. Il primo dell'aquilana Roberta
Vacca (1947), denominato Poker Face, per
la commissione de I Pomerggi e in prima
esecuzione assoluta, ha introdotto l'anteprima
di questa mattina. Un lavoro tonale molto
sfaccettato nei ritmi e nelle
 timbriche che ha
messo in rilievo le qualità di scrittura
dell'affermata compositrice. Un valido lavoro
reso bene da Feddeck e dagli orchestrali.
Applausi anche alla compositrice salita sul
palcoscenico. Il brano più atteso, anche per la
presenza del giovane violoncellista Ettore
Pagano, era il Concerto per violoncello e
orchestra n.1 op.107 di Dmitri
Šostakovic. Un capolavoro di pregnanza timbrica
reso con espressività
da Pagano, un cellista di
grande spessore musicale, che ha saputo
penetrare la timbriche che ha
messo in rilievo le qualità di scrittura
dell'affermata compositrice. Un valido lavoro
reso bene da Feddeck e dagli orchestrali.
Applausi anche alla compositrice salita sul
palcoscenico. Il brano più atteso, anche per la
presenza del giovane violoncellista Ettore
Pagano, era il Concerto per violoncello e
orchestra n.1 op.107 di Dmitri
Šostakovic. Un capolavoro di pregnanza timbrica
reso con espressività
da Pagano, un cellista di
grande spessore musicale, che ha saputo
penetrare la
 musica del grande russo con
timbriche profonde, incisive e di rara efficacia.
La lunga Cadenza, un vero movimento tra
il Moderato e l'Allegro con moto
ha esaltato le qualità dell'interprete. Applausi
sostenuti ai protagonisti. L'ultimo brano in
programma, la Sinfonia n.4 op.60 di
Beethoven è stato ben delineato nei quattro
movimenti che lo compongono dalla valida
direzione di Feddeck per una energica
restituzione dalla compagine orchestrale. Questa
sera alle ore 20.00 la prima ufficiale e sabato
alle 17.00 la replica. Da non perdere! musica del grande russo con
timbriche profonde, incisive e di rara efficacia.
La lunga Cadenza, un vero movimento tra
il Moderato e l'Allegro con moto
ha esaltato le qualità dell'interprete. Applausi
sostenuti ai protagonisti. L'ultimo brano in
programma, la Sinfonia n.4 op.60 di
Beethoven è stato ben delineato nei quattro
movimenti che lo compongono dalla valida
direzione di Feddeck per una energica
restituzione dalla compagine orchestrale. Questa
sera alle ore 20.00 la prima ufficiale e sabato
alle 17.00 la replica. Da non perdere!
11 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
Monica Zhang
per la Società dei
Concerti
Ha solo
diciassette anni la pianista milanese Monica
Zhang, l'artista in residenza della
Fondazione La Società dei Concerti che
all'ultimo momento ha sostituito il pianista
Yunchan Lim. Un compito non facile, avendo il
sud-coreano vinto nel 2022 l'importantissimo "Concorso
Internazionale Van Cliburn". Le qualità
superlative di
 Monica
hanno comunque soddisfatto il numeroso pubblico
intervenuto in Sala Verdi, nel Conservatorio
milanese, dopo aver ascoltato un impaginato
ricco di brani celebri e virtuosistici. Dal
primo
Čaikovskij con l'Andante maestoso-
Pas de deux
da "Lo Schiaccianoci" , nella straordinaria
trascrizione di M.
Pletnev, la Zhang ha rivelato la sua cifra
interpretativa delineata da una tecnica
straordinaria, ricca di chiarissimi dettagli e
da una sicurezza nell'approccio pianistico da
interprete con anni di carriera. Il successivo
Liszt, con la celebre Parafrasi da Concerto
dal verdiano "Rigoletto", ha ancora
consolidato le qualità
digitali della pianista e
anche Monica
hanno comunque soddisfatto il numeroso pubblico
intervenuto in Sala Verdi, nel Conservatorio
milanese, dopo aver ascoltato un impaginato
ricco di brani celebri e virtuosistici. Dal
primo
Čaikovskij con l'Andante maestoso-
Pas de deux
da "Lo Schiaccianoci" , nella straordinaria
trascrizione di M.
Pletnev, la Zhang ha rivelato la sua cifra
interpretativa delineata da una tecnica
straordinaria, ricca di chiarissimi dettagli e
da una sicurezza nell'approccio pianistico da
interprete con anni di carriera. Il successivo
Liszt, con la celebre Parafrasi da Concerto
dal verdiano "Rigoletto", ha ancora
consolidato le qualità
digitali della pianista e
anche
 il
più raro Ginastera delle Danzas Argentinas
Op.2 -tre danze con quelle due laterali di
un virtuosismo ritmico scintillante- ha dato
idea di trovarci di fronte ad un'interprete con
potenziali che potranno, nei prossimi anni,
formare una personalizzazione espressiva di
altissimo livello. Dopo l'intervallo sono stati
eseguiti con grande equilibrio e con ottima resa
espressiva i celebri Quadri di un'esposizione
di Modest Musorgskij. Interpretazione di
qualità la sua, specie nei frangenti dove le
volumetrie hanno il
più raro Ginastera delle Danzas Argentinas
Op.2 -tre danze con quelle due laterali di
un virtuosismo ritmico scintillante- ha dato
idea di trovarci di fronte ad un'interprete con
potenziali che potranno, nei prossimi anni,
formare una personalizzazione espressiva di
altissimo livello. Dopo l'intervallo sono stati
eseguiti con grande equilibrio e con ottima resa
espressiva i celebri Quadri di un'esposizione
di Modest Musorgskij. Interpretazione di
qualità la sua, specie nei frangenti dove le
volumetrie hanno
 un
grande impatto sonoro. Applausi interminabili al
termine del programma ufficiale e ben tre i bis
concessi dalla pianista con un brano iniziale di
Gabriel Fauré e due di F.Chopin. Del polacco ha
eseguito prima lo Studio n.1 op.10 e poi
la Mazurca Op.33 n.1 . Applausi calorosi
dal pubblico presente in Sala Verdi e numerosi
mazzi di fiori anche dai compagni di
Conservatorio e del Liceo Classico Carducci
frequentato dalla bravissima Monica. Grande
serata! un
grande impatto sonoro. Applausi interminabili al
termine del programma ufficiale e ben tre i bis
concessi dalla pianista con un brano iniziale di
Gabriel Fauré e due di F.Chopin. Del polacco ha
eseguito prima lo Studio n.1 op.10 e poi
la Mazurca Op.33 n.1 . Applausi calorosi
dal pubblico presente in Sala Verdi e numerosi
mazzi di fiori anche dai compagni di
Conservatorio e del Liceo Classico Carducci
frequentato dalla bravissima Monica. Grande
serata!
11 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
Wolfram Christ e Georgijs
Osokins con l'Orchestra
UNIMI dell'Università Statale milanese
Ieri nell'aula Magna
dall'Università Statale, l'Orchestra UNIMI
ha trovato la direzione di Wolfram Christ,
un direttore d'orchestra che per decenni è stato
la prima viola di eccellenti orchestre
tra cui la leggendaria Orchestra Filarmonica di
Berlino. La più recente attività direttoriale lo
ha portato in giro per il mondo. Per l'Orchestra
universitaria milanese ha scelto un impaginato
tutto beethoveniano con il Concerto n.4 in
Sol maggiore Op.58 per pianoforte e orchestra
e con la Sinfonia n.8 in fa maggiore
Op.93. Il primo brano, il concerto, ha
trovato l'ausilio solistico del pianista lettone
Georgij Osokins, un interprete di ottima
 qualità
recentemente ascoltato in Sala Verdi in una
trascrizione del Concerto n.2 di F.
Chopin accompagnato dalla Kremerata Baltica (11
marzo- Serate Musicali) Il Concerto n.4
beethoveniano è stato affrontato con altrettanta
discorsività e chiarezza di dettaglio. L'ampio
Allegro moderato del primo movimento, con
quelle celebri note iniziali solo pianistiche,
ha trovato un'ottima resa anche dai giovani
strumentisti dell'orchestra UNIMI, compagine
universitaria milanese che ha anche quest'anno qualità
recentemente ascoltato in Sala Verdi in una
trascrizione del Concerto n.2 di F.
Chopin accompagnato dalla Kremerata Baltica (11
marzo- Serate Musicali) Il Concerto n.4
beethoveniano è stato affrontato con altrettanta
discorsività e chiarezza di dettaglio. L'ampio
Allegro moderato del primo movimento, con
quelle celebri note iniziali solo pianistiche,
ha trovato un'ottima resa anche dai giovani
strumentisti dell'orchestra UNIMI, compagine
universitaria milanese che ha anche quest'anno una valida programmazione con ottimi direttori e
solisti. La precisa e incisiva direzione di
Wolfram Christ ha permesso di ben rilevare il
pianismo di Osokins, ben evidenziato anche nel
profondo Andante con moto e
nell'esuberante Rondò finale. Applausi
sostenuti dal mumerosissimo pubblico intervenuto
in Aula Magna, pubblico che in buona parte aveva
presenziato all'incontro
con gli
interpreti,
anticipatorio del concerto, in una conversazione
con la collega giornalista-musicologa Gaia Varon.
Splendido il bis solistico di Osokins con il
celebre Carnevale di Venezia in una
rivisitazione di Chopin dalle variazioni di
Paganini. Dopo la brevissima pausa, valida
l'interpretazione di Christ e dell'Orchestra
della breve Sinfonia n.8 (1814) , lavoro
di "passaggio" tra le ben più celebri Settima
e Nona, ma con caratteristiche sempre
molto beethoveniane. Ottimo concerto e ancora
applausi sostenuti .
una valida programmazione con ottimi direttori e
solisti. La precisa e incisiva direzione di
Wolfram Christ ha permesso di ben rilevare il
pianismo di Osokins, ben evidenziato anche nel
profondo Andante con moto e
nell'esuberante Rondò finale. Applausi
sostenuti dal mumerosissimo pubblico intervenuto
in Aula Magna, pubblico che in buona parte aveva
presenziato all'incontro
con gli
interpreti,
anticipatorio del concerto, in una conversazione
con la collega giornalista-musicologa Gaia Varon.
Splendido il bis solistico di Osokins con il
celebre Carnevale di Venezia in una
rivisitazione di Chopin dalle variazioni di
Paganini. Dopo la brevissima pausa, valida
l'interpretazione di Christ e dell'Orchestra
della breve Sinfonia n.8 (1814) , lavoro
di "passaggio" tra le ben più celebri Settima
e Nona, ma con caratteristiche sempre
molto beethoveniane. Ottimo concerto e ancora
applausi sostenuti .
10 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
Uto Ughi alle
Serate Musicali del
Conservatorio
Una
serata di ottima qualità quella di ieri sera
alle Serate Musicali del Conservatorio
milanese. È finalmente ritornato il violinista
Uto Ughi, classe 1944, ottant'anni compiuti a
gennaio. Era in duo con il pianista Leonardo
Bartelloni per un programma di brani classici
affrontati molte volte nelle decine di concerti
tenuti in Sala Verdi, in almeno trent'anni
 di
rapporto continuativo con la nota società
concertistica milanese. Per questo, prima dei
bis concessi dal Maestro, è stata consegnata a
Ughi una targa di ringraziamento "per la sua
arte a Milano" a nome di Hans Fazzari, da sempre
organizzatore delle Serate Musicali e che
purtroppo non ha potuto essere presente. Nella
prima parte del concerto un cambio di programma
ha visto Ughi e Bartelloni eseguire la celebre
Ciaccona di Tomaso Vitali, cui ha fatto
seguito l'altrettanto noto cavallo di battaglia
del Maestro , il " Trillo del diavolo"
ovvero la Sonata in Sol minore di
Giuseppe Tartini. Uto Ughi ha ieri espresso, in
questi primi due importanti lavori, un livello
interpretativo poetico. Coadiuvato da Bartelloni,
pianista attento alle volumetrie del violino e
perfetto nel sottolineare le inflessioni
timbriche di Ughi, il duo di
rapporto continuativo con la nota società
concertistica milanese. Per questo, prima dei
bis concessi dal Maestro, è stata consegnata a
Ughi una targa di ringraziamento "per la sua
arte a Milano" a nome di Hans Fazzari, da sempre
organizzatore delle Serate Musicali e che
purtroppo non ha potuto essere presente. Nella
prima parte del concerto un cambio di programma
ha visto Ughi e Bartelloni eseguire la celebre
Ciaccona di Tomaso Vitali, cui ha fatto
seguito l'altrettanto noto cavallo di battaglia
del Maestro , il " Trillo del diavolo"
ovvero la Sonata in Sol minore di
Giuseppe Tartini. Uto Ughi ha ieri espresso, in
questi primi due importanti lavori, un livello
interpretativo poetico. Coadiuvato da Bartelloni,
pianista attento alle volumetrie del violino e
perfetto nel sottolineare le inflessioni
timbriche di Ughi, il duo
 ha
fornito una prestazione di altissimo livello.
Non sono certo le lievi imperfezioni
d'intonazione del grande violinista a sminuire
una qualità complessiva eccellente dove la
profonda espressività della "voce" è emersa in
toto, valorizzata dalle armonie pianistiche. Il
momento di "a solo" del violino di Ughi al
termine del Trillo del diavolo è stato
poi entusiasmante per pregnanza espressiva. Dopo
l'intervallo, valida l'interpretazione
complessiva della nota Sonata in la maggiore
del belga-francese Cesare Franck, con
frangenti di profonda espressività. Valida anche
la parte pianistica, di fondamentale importanza,
di Bartelloni, in questo ampio lavoro ciclico.
Straordinari i due bis concessi dal duo. In essi
un violino intonatissimo e molto espressivo ha
fatto emergere i valori musicali sia del brano
di Manuel De Falla, con la Danza spagnola n.1 da
La vida
breve,
che di quello di Fritz Kreisler, Schön
Rosmarin. Applausi meritatissimi in una sala
molto affollata, con un pubblico decisamente
soddisfatto. ha
fornito una prestazione di altissimo livello.
Non sono certo le lievi imperfezioni
d'intonazione del grande violinista a sminuire
una qualità complessiva eccellente dove la
profonda espressività della "voce" è emersa in
toto, valorizzata dalle armonie pianistiche. Il
momento di "a solo" del violino di Ughi al
termine del Trillo del diavolo è stato
poi entusiasmante per pregnanza espressiva. Dopo
l'intervallo, valida l'interpretazione
complessiva della nota Sonata in la maggiore
del belga-francese Cesare Franck, con
frangenti di profonda espressività. Valida anche
la parte pianistica, di fondamentale importanza,
di Bartelloni, in questo ampio lavoro ciclico.
Straordinari i due bis concessi dal duo. In essi
un violino intonatissimo e molto espressivo ha
fatto emergere i valori musicali sia del brano
di Manuel De Falla, con la Danza spagnola n.1 da
La vida
breve,
che di quello di Fritz Kreisler, Schön
Rosmarin. Applausi meritatissimi in una sala
molto affollata, con un pubblico decisamente
soddisfatto.
9
aprile 2024 Cesare
Guzzardella
I violinisti Houman Vaziri e
Agnese Maria Balestracci ai Lieti Calici
Due
ottimi violinisti, Houman Vaziri e Agnese Maria
Balestracci del Quartetto Sincronie,
hanno tenuto un ottimo concerto ieri mattina
agli Amici del Loggione del Teatro alla Scala
di Via Silvio Pellico 6 per la rassegna
Lieti Calici. La valida resa interpretativa
del duo
 cameristico
è stata sostenuta da una scelta d'impaginato di
qualità, con l'esecuzione di autori sia recenti
che del passato e con relativi brani che hanno
ben delineato la particolarità delle
composizioni per "due violini". Al centro del
breve concerto, la figura del ligure Luciano
Berio (1925-2003) e di dieci duetti per due
violini, tra i quasi 40 da lui composti -
eseguiti all'inizio e alla fina della mattinata
musicale- , hanno rivelato le qualità della sua
musica, legata agli stilemi del passato ma anche
alla figura di Bartòk e alle opere dei suoi
contemporanei. I due interpreti, in un gioco di
alternanza delle parti, secondo le modalità
della scrittura a canone, tipica della musica
seicentesca e settecentesca, hanno intervallato
i brevi ma creativi lavori di Berio, dedicati a
Bartók, con altri di Georg Philipp Telemann (
1681
–
1767) , di Jean-Marie Leclair (1697-1764), ma
anche di Paul Hindemith (1895-1963), musicista
tedesco debitore della musica bachiana e, come
il suo geniale connazionale, grande architetto
polifonico. Un concerto interessatissimo,
presentato bene da Mario Marcarini, e con il
gran finale, - dopo il bellissimo bis con la
ripetizione del brano più interiore e melodico
di Berio e gli applausi sostenuti del numeroso
pubblico presente- , del brindisi con eccelsi
vini di superlativa qualità. Ottima mattinata. cameristico
è stata sostenuta da una scelta d'impaginato di
qualità, con l'esecuzione di autori sia recenti
che del passato e con relativi brani che hanno
ben delineato la particolarità delle
composizioni per "due violini". Al centro del
breve concerto, la figura del ligure Luciano
Berio (1925-2003) e di dieci duetti per due
violini, tra i quasi 40 da lui composti -
eseguiti all'inizio e alla fina della mattinata
musicale- , hanno rivelato le qualità della sua
musica, legata agli stilemi del passato ma anche
alla figura di Bartòk e alle opere dei suoi
contemporanei. I due interpreti, in un gioco di
alternanza delle parti, secondo le modalità
della scrittura a canone, tipica della musica
seicentesca e settecentesca, hanno intervallato
i brevi ma creativi lavori di Berio, dedicati a
Bartók, con altri di Georg Philipp Telemann (
1681
–
1767) , di Jean-Marie Leclair (1697-1764), ma
anche di Paul Hindemith (1895-1963), musicista
tedesco debitore della musica bachiana e, come
il suo geniale connazionale, grande architetto
polifonico. Un concerto interessatissimo,
presentato bene da Mario Marcarini, e con il
gran finale, - dopo il bellissimo bis con la
ripetizione del brano più interiore e melodico
di Berio e gli applausi sostenuti del numeroso
pubblico presente- , del brindisi con eccelsi
vini di superlativa qualità. Ottima mattinata.
8 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
Antonio Alessandri in
un concerto in Conservatorio per la
Fondazione Bracco
Il
concerto straordinario organizzato dal
Conservatorio milanese e dalla Fondazione Bracco
ha trovato sul palcoscenico un pianista di 18
anni appena compiuti. Antonio Alessandri,
vincitore del "Premio speciale Diventerò" di
Fondazione Bracco alla XXXIII edizione del
Concorso Pianistico Internazionale Ettore
Pozzoli, è un nome già noto nell'area milanese e
non solo, avendo già
 sostenuto
concerti in numerose importanti sale della città,
e avendo vinto molti Primi Premi in concorsi
concertistici internazionali sin da quando era
poco più di un bambino. L'impaginato scelto ieri
sera, degno di un pianista maturo ed in carriera
da decenni, prevedeva brani di Rachmaninov e di
Chopin. Ha iniziato con i virtuosistici
Etudes-Tableaux op.33 sostenuto
concerti in numerose importanti sale della città,
e avendo vinto molti Primi Premi in concorsi
concertistici internazionali sin da quando era
poco più di un bambino. L'impaginato scelto ieri
sera, degno di un pianista maturo ed in carriera
da decenni, prevedeva brani di Rachmaninov e di
Chopin. Ha iniziato con i virtuosistici
Etudes-Tableaux op.33 del grande russo e ha continuato con gli
Studi op.10 del polacco. Si rimane
certamente sbalorditi della sicurezza con la
quale esegue brani di grande impegno. La
facilità nel superare le difficoltà tecniche è
unita ad una qualità espressiva già consolidata
e di ottima resa. Alcuni dei celebri Studi
chopiniani hanno trovato una rapida
articolazione per un equilibrio discorsivo
eccellente. Una resa così matura di brani
alquanto difficili ha entusiasmato il
numerosissimo pubblico presente in Sala Puccini.
Applausi fragorosi e un bis ancora di Chopin con
lo Studio n.7 op.25
del grande russo e ha continuato con gli
Studi op.10 del polacco. Si rimane
certamente sbalorditi della sicurezza con la
quale esegue brani di grande impegno. La
facilità nel superare le difficoltà tecniche è
unita ad una qualità espressiva già consolidata
e di ottima resa. Alcuni dei celebri Studi
chopiniani hanno trovato una rapida
articolazione per un equilibrio discorsivo
eccellente. Una resa così matura di brani
alquanto difficili ha entusiasmato il
numerosissimo pubblico presente in Sala Puccini.
Applausi fragorosi e un bis ancora di Chopin con
lo Studio n.7 op.25
7 aprile 2024 Cesare Guzzardella
La pianista Gala Chistiakova
a "Il pianoforte in Ateneo" dell'Università
Cattolica milanese.
"Il
pianoforte in Ateneo", la rassegna musicale
dedicata al pianoforte, è tornata all'
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Gli organizzatori delle serate musicali, il prof.
Enrico Reggiani, direttore dello Studium
Musicale di Ateneo e il Maestro Davide Cabassi,
pianista-concertista e
 docente al Conservatorio
" G. Verdi" di Milano, hanno portato nella
splendida Aula Magna dell'Università milanese la
moscovita Gala Chistiakova che con il
prestigioso Shigeru Kawai, pianoforte scelto per
tutta la rassegna musicale, ha eseguito due
celebri lavori di Beethoven (1770-1827) e di
Musorgskij (1839-1881): la Sonata op. 27 n. 2
"Al chiaro di luna" e Quadri di
un’esposizione. Brani che, come ricordato
nella valida introduzione di Enrico Reggiani,
non hanno certo bisogno di presentazione in
quanto noti anche docente al Conservatorio
" G. Verdi" di Milano, hanno portato nella
splendida Aula Magna dell'Università milanese la
moscovita Gala Chistiakova che con il
prestigioso Shigeru Kawai, pianoforte scelto per
tutta la rassegna musicale, ha eseguito due
celebri lavori di Beethoven (1770-1827) e di
Musorgskij (1839-1881): la Sonata op. 27 n. 2
"Al chiaro di luna" e Quadri di
un’esposizione. Brani che, come ricordato
nella valida introduzione di Enrico Reggiani,
non hanno certo bisogno di presentazione in
quanto noti anche
 dal pubblico che non frequenta
abitualmente le sale da concerto. La Chistiakova
ha rivelato in entrambi i lavori di possedere un
carattere particolarmente deciso, delineando
strutture musicali ricche di forza espressiva e
discorsività fluida nell'esternare ogni sequenza
melodico-armonica. L'equilibrio complessivo, sia
nella Sonata beethoveniana, sia in quella
suite rappresentata dai Quadri, con quel
ritorno alternato del celebre tema, è stato
valido nel contrasto tra il cambiamento dei
tempi e nelle volumetrie timbriche. Un grande
successo nella Aula colma di appassionati e la
concessione di due splendidi bis da parte
dell'ottima interprete: prima di Piotr I.
Čajkovskij Meditation op.72 n.5 e quindi
di Anatoly Lyadov The Music Box op.32,
che hanno rivelato tutte le raffinatezze del
pianismo della russa.
Il prossimo appuntamento, previsto per il 16
maggio , vedrà al
pianoforte
il noto interprete Boris
Petrushanski con musiche di Mozart, Beethoven e
Brahms. Da non perdere! dal pubblico che non frequenta
abitualmente le sale da concerto. La Chistiakova
ha rivelato in entrambi i lavori di possedere un
carattere particolarmente deciso, delineando
strutture musicali ricche di forza espressiva e
discorsività fluida nell'esternare ogni sequenza
melodico-armonica. L'equilibrio complessivo, sia
nella Sonata beethoveniana, sia in quella
suite rappresentata dai Quadri, con quel
ritorno alternato del celebre tema, è stato
valido nel contrasto tra il cambiamento dei
tempi e nelle volumetrie timbriche. Un grande
successo nella Aula colma di appassionati e la
concessione di due splendidi bis da parte
dell'ottima interprete: prima di Piotr I.
Čajkovskij Meditation op.72 n.5 e quindi
di Anatoly Lyadov The Music Box op.32,
che hanno rivelato tutte le raffinatezze del
pianismo della russa.
Il prossimo appuntamento, previsto per il 16
maggio , vedrà al
pianoforte
il noto interprete Boris
Petrushanski con musiche di Mozart, Beethoven e
Brahms. Da non perdere!
5 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
La violinista turca
Tchumburidze
diretta da Bisatti ai Pomeriggi Musicali
Brani
tutti in Re Maggiore quelli scelti dal giovane
direttore Riccardo Bisatti per I Pomeriggi
Musicali al Teatro Dal Verme. Ho ascoltato
l'anteprima di questa mattina con un programna
che prevedeva un capolavoro assai noto di
L.v.Beethoven con il suo Concerto in Re
maggiore per
 violino
e orchestra op. 61. L'ottima solista era la
ventottenne violinista Veriko Tchumburidze. Dopo
il breve intervallo una rarità giovanile di
Franz Schubert con la Sinfonia n. 3 in Re
maggiore D200 concludeva l'mpaginato. Il
bravissimo direttore ha mostrato una valida
gestualità nel trasmettere con precisione ogni
indicazione ai bravissimi orchestrali de I
Pomeriggi. Il concerto beethoveniano,
splendido sia nei singoli movimenti che
nell'insieme, con un grandioso Allegro ma non
troppo iniziale, ha rivelato le qualità
della violinista turca. Oltre ad una
precisissima padronanza tecnica la Tchumburidze
emergeva nella bellissima prima cadenza,
risolta con straordinaria espressività, così
come anche violino
e orchestra op. 61. L'ottima solista era la
ventottenne violinista Veriko Tchumburidze. Dopo
il breve intervallo una rarità giovanile di
Franz Schubert con la Sinfonia n. 3 in Re
maggiore D200 concludeva l'mpaginato. Il
bravissimo direttore ha mostrato una valida
gestualità nel trasmettere con precisione ogni
indicazione ai bravissimi orchestrali de I
Pomeriggi. Il concerto beethoveniano,
splendido sia nei singoli movimenti che
nell'insieme, con un grandioso Allegro ma non
troppo iniziale, ha rivelato le qualità
della violinista turca. Oltre ad una
precisissima padronanza tecnica la Tchumburidze
emergeva nella bellissima prima cadenza,
risolta con straordinaria espressività, così
come anche
 in
quella del Rondò finale. Ha colori molto
raffinati il violino della Tchumburidze, espressi
nella tenue ma producente discorsività. Un
equilibrio complessivo ottimo con la direzione
di Bisatti. Il direttore ventitreenne novarese
ha poi rivelato ancora qualità nella valida
Sinfonia di Schubert. Una scrittura ancora non
del tutto personale ma con un Allegretto
e un Presto vivace deliziosi. Di qualità
l'interpretazione. Questa sera alle 20.00 la
prima ufficiale e sabato alle 17.00 la replica. in
quella del Rondò finale. Ha colori molto
raffinati il violino della Tchumburidze, espressi
nella tenue ma producente discorsività. Un
equilibrio complessivo ottimo con la direzione
di Bisatti. Il direttore ventitreenne novarese
ha poi rivelato ancora qualità nella valida
Sinfonia di Schubert. Una scrittura ancora non
del tutto personale ma con un Allegretto
e un Presto vivace deliziosi. Di qualità
l'interpretazione. Questa sera alle 20.00 la
prima ufficiale e sabato alle 17.00 la replica.
4 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
Successo incompleto per il
Guillaume Tell rossiniano di Michele
Mariotti e Chiara Muti
Un
Teatro alla Scala colmo di pubblico ha accolto
la quarta rappresentazione - da me vista - del
rossoniano Guillaume Tell. Un'opera che
da quasi 35 anni non veniva rappresentata in
Scala - era il dicembre del 1989- e mai lo era
stata nel teatro del Piermarini nella versione
francese. Quattro atti particolarmente corposi
per quasi quattro ore
 reali
di musica, ai quali si aggiungono tre non brevi
intervalli. Alcuni spettatori, i meno
appassionati, hanno lasciato il teatro prima,
perdendo l'ultimo atto e altri anche il più
articolato e contestato terzo atto . Una
contestazione rivolta alla regia di Chiara Muti,
che se pur con indubbia creatività, ha
realizzato una rappresentazione attualizzata ai
tristi momenti che stiamo vivendo, mettendo in
scena situazioni spesso violente come nei
frangenti danzanti del terzo atto, buate
da un certo numero di spettatori presenti anche
in platea. Valide comunque le motivazioni di
Chiara Muti scritte nel completo libro di sala
che parte dalla scura messinscena ispirata dal
celebre film del 1927 Metropolis di Fritz
Lang, che profetizza "l'annichilamento della
società reali
di musica, ai quali si aggiungono tre non brevi
intervalli. Alcuni spettatori, i meno
appassionati, hanno lasciato il teatro prima,
perdendo l'ultimo atto e altri anche il più
articolato e contestato terzo atto . Una
contestazione rivolta alla regia di Chiara Muti,
che se pur con indubbia creatività, ha
realizzato una rappresentazione attualizzata ai
tristi momenti che stiamo vivendo, mettendo in
scena situazioni spesso violente come nei
frangenti danzanti del terzo atto, buate
da un certo numero di spettatori presenti anche
in platea. Valide comunque le motivazioni di
Chiara Muti scritte nel completo libro di sala
che parte dalla scura messinscena ispirata dal
celebre film del 1927 Metropolis di Fritz
Lang, che profetizza "l'annichilamento della
società e l'umanità automatizzata e asservita al
profitto" e "l'uomo ha imprigionato sé
stesso erigendo muri di schermi ad accecare il
sole". La discordanza tra le splendide
musiche dirette con passione e cura di dettaglio
da Michele Mariotti - un rossiniano doc,
pesarese come Rossini- e le cupe scene di
Alessandro Camera, in sintonia con i costumi di
Ursula Patzak e le luci di Vincent
Longuemare,
hanno creato un contrasto estetico che non è
piaciuto a molti spettatori. Anche le
coreografie originali, articolate e ricche di
situazioni, di Silvia Giordano, non hanno
trovato apprezzamenti da alcuni del pubblico
presente. Ho trovato invece soprattutto il terzo
atto meritevole d'attenzione per la complessa
dinamica e per nulla astrusa realizzazione.
Mariotti è stato al termine della lunga serata
il più applaudito, ad iniziare dalla celebre
Ouverture che riassume nei temi la
particolare vicenda e che ha trovato a
conclusione un'ovazione per l'ottima esecuzione.
Ma anche il valido cast vocale è piaciuto,
ottenendo meritati applausi. e l'umanità automatizzata e asservita al
profitto" e "l'uomo ha imprigionato sé
stesso erigendo muri di schermi ad accecare il
sole". La discordanza tra le splendide
musiche dirette con passione e cura di dettaglio
da Michele Mariotti - un rossiniano doc,
pesarese come Rossini- e le cupe scene di
Alessandro Camera, in sintonia con i costumi di
Ursula Patzak e le luci di Vincent
Longuemare,
hanno creato un contrasto estetico che non è
piaciuto a molti spettatori. Anche le
coreografie originali, articolate e ricche di
situazioni, di Silvia Giordano, non hanno
trovato apprezzamenti da alcuni del pubblico
presente. Ho trovato invece soprattutto il terzo
atto meritevole d'attenzione per la complessa
dinamica e per nulla astrusa realizzazione.
Mariotti è stato al termine della lunga serata
il più applaudito, ad iniziare dalla celebre
Ouverture che riassume nei temi la
particolare vicenda e che ha trovato a
conclusione un'ovazione per l'ottima esecuzione.
Ma anche il valido cast vocale è piaciuto,
ottenendo meritati applausi.
 L'ultima opera di
Rossini, drammatica ma a lieto fine, con gli
svizzeri finalmente liberi dal dominio asburgico
, è musicalmente diversa dalle altre opere, con
molto sinfonismo presente nel corso degli atti,
a dimostrazione di una capacità del grande
copositore pesarese di realizzare musica non
solo legata alla sua più celebre vena lirica. In
questo, Mariotti e gli orchestrali scaligeri,
hanno dato prova di eccellente duttilità
timbrica. Tutti rilevanti i cantanti a
cominciare da Michele Pertusi, un Guillaume
Tell notevole nella timbrica e nella resa
scenica; ottime le voce di Dmitry Korchak,
Arnold Melcthal, di Salome Jicia,
Mathilde, di Geraldine Chauvet, Hedwige,
di Evgeny Stavinsky, Melchtal, di
Catherine Trottmann, Jemmy, di Luca
Tittoto, Gesler, e degli altri, tutti
meritevoli degli applausi ricevuti. Di grande
impatto timbrico e di alta qualità il Coro di
Alberto Malazzi. Le prossime repliche sono
previste per il 6 e il 10 aprile, sempre con
inizio alle ore 18.30. Da non perdere. (Prime
due foto di Brescia e Amisan- Archivio Teatro
alla Scala) L'ultima opera di
Rossini, drammatica ma a lieto fine, con gli
svizzeri finalmente liberi dal dominio asburgico
, è musicalmente diversa dalle altre opere, con
molto sinfonismo presente nel corso degli atti,
a dimostrazione di una capacità del grande
copositore pesarese di realizzare musica non
solo legata alla sua più celebre vena lirica. In
questo, Mariotti e gli orchestrali scaligeri,
hanno dato prova di eccellente duttilità
timbrica. Tutti rilevanti i cantanti a
cominciare da Michele Pertusi, un Guillaume
Tell notevole nella timbrica e nella resa
scenica; ottime le voce di Dmitry Korchak,
Arnold Melcthal, di Salome Jicia,
Mathilde, di Geraldine Chauvet, Hedwige,
di Evgeny Stavinsky, Melchtal, di
Catherine Trottmann, Jemmy, di Luca
Tittoto, Gesler, e degli altri, tutti
meritevoli degli applausi ricevuti. Di grande
impatto timbrico e di alta qualità il Coro di
Alberto Malazzi. Le prossime repliche sono
previste per il 6 e il 10 aprile, sempre con
inizio alle ore 18.30. Da non perdere. (Prime
due foto di Brescia e Amisan- Archivio Teatro
alla Scala)
4 aprile 2024 Cesare
Guzzardella
Ilaria Baldaccini interpreta
"Corde e
martelletti" di Alessandro Solbiati al Museo
del Novecento
Un
pomeriggio musicale particolarmente interessante
quello visto e ascoltato al Museo del Novecento
per l'organizzazione di NoMus e del "Quartetto"
di Milano. La raccolta di brevi pezzi per
pianoforte del compositore milanese Alessandro
Solbiati, denominata " Corde e martelletti,
cento piccoli pezzi per crescere al pianoforte"
ha trovato un valida esecuzione dalla
pianista Ilaria Baldaccini. Lei ha selezionato
sessanta tra i cento brani
 dell'originale
lavoro del noto musicista. Circa un'ora di
musica che ha ben delineato la sequenza di brani
dedicati ai giovani studenti di pianoforte, ma
che, come per le celebri raccolte pianistiche di
Schumann, di Bartok e di altri ancora, hanno una
valenza compositiva più importante, che rivela
anche le profonde modalità creative dei
compositori. Solbiati - come da lui raccontato
presentando anche la bravissima Baldaccini- nei
brani utilizza il pianoforte a 360 gradi, usando
la cordiera, percuotendo lo strumento,
modificando le timbriche preparando il
pianoforte, e chiedendo all'interprete di usare
la voce o fare versi, situazioni che ci hanno
riportato alle lontane ricerche di Cage, di
Bussotti e di altri compositori del "dopo anni
'50" del secolo scorso. dell'originale
lavoro del noto musicista. Circa un'ora di
musica che ha ben delineato la sequenza di brani
dedicati ai giovani studenti di pianoforte, ma
che, come per le celebri raccolte pianistiche di
Schumann, di Bartok e di altri ancora, hanno una
valenza compositiva più importante, che rivela
anche le profonde modalità creative dei
compositori. Solbiati - come da lui raccontato
presentando anche la bravissima Baldaccini- nei
brani utilizza il pianoforte a 360 gradi, usando
la cordiera, percuotendo lo strumento,
modificando le timbriche preparando il
pianoforte, e chiedendo all'interprete di usare
la voce o fare versi, situazioni che ci hanno
riportato alle lontane ricerche di Cage, di
Bussotti e di altri compositori del "dopo anni
'50" del secolo scorso.
 Anche
quando l'uso del pianoforte è tradizionale, con
le mani ben ancorate alla tastiera per chiare e
incisive armonie o per semplici note isolate,
Solbiati esplora le possibilità timbriche dello
strumento con un'articolazione digitale, seppure
non difficile in quanto pensata per i più
giovani allievi, di particolare interesse
compositivo. I brevi pezzi, di una durata
compresa tra i venti secondi e il minuto e
mezzo, sono un condensato di riferimenti
musicali raccontati da una precisa titolazione,
come ad esempio: Invenzione sulle corde,
Corale con riverberi, Campane a festa ,
Fischiettando... una serie, Piccola pantomima,
Scivolando, Trilli e guizzi, e così Anche
quando l'uso del pianoforte è tradizionale, con
le mani ben ancorate alla tastiera per chiare e
incisive armonie o per semplici note isolate,
Solbiati esplora le possibilità timbriche dello
strumento con un'articolazione digitale, seppure
non difficile in quanto pensata per i più
giovani allievi, di particolare interesse
compositivo. I brevi pezzi, di una durata
compresa tra i venti secondi e il minuto e
mezzo, sono un condensato di riferimenti
musicali raccontati da una precisa titolazione,
come ad esempio: Invenzione sulle corde,
Corale con riverberi, Campane a festa ,
Fischiettando... una serie, Piccola pantomima,
Scivolando, Trilli e guizzi, e così
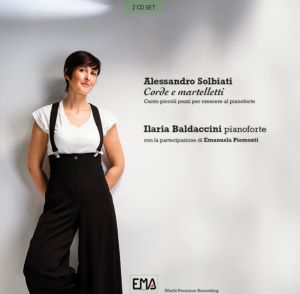 via
per 100 titoli. Decisamente brava Ilaria
Baldaccini nell'aver estrapolato sessanta dei
cento brani, in un ordine da lei deciso, per
ottenere una sorta di performance
musicale-gestuale ben articolata, con frangenti
di eccellenti valenze espressive, alternati ad
altri dove la gestualità o l'effetto timbrico
hanno una maggiore prevalenza. Al termine
dell'originale esecuzione i doverosi applausi
all'interprete e al compositore non sono mancati
dal numerosissimo pubblico che gremiva la
panoramicissima e luminosa Sala Fontana del
museo milanese. Successo
meritato in un pomeriggio musicale che voleva
anche presentare l'ottimo Cd uscito nel 2023 per
EMA Vinci Records con l'opera completa di
Solbiati "Corde e martelletti" nell'ottima
interpretazione di Ilaria Baldaccini. via
per 100 titoli. Decisamente brava Ilaria
Baldaccini nell'aver estrapolato sessanta dei
cento brani, in un ordine da lei deciso, per
ottenere una sorta di performance
musicale-gestuale ben articolata, con frangenti
di eccellenti valenze espressive, alternati ad
altri dove la gestualità o l'effetto timbrico
hanno una maggiore prevalenza. Al termine
dell'originale esecuzione i doverosi applausi
all'interprete e al compositore non sono mancati
dal numerosissimo pubblico che gremiva la
panoramicissima e luminosa Sala Fontana del
museo milanese. Successo
meritato in un pomeriggio musicale che voleva
anche presentare l'ottimo Cd uscito nel 2023 per
EMA Vinci Records con l'opera completa di
Solbiati "Corde e martelletti" nell'ottima
interpretazione di Ilaria Baldaccini.
3 aprile 2024 Cesare Guzzardella
MARZO 2024
A
NOVARA LE ULTIME SETTE PAROLE DI CRISTO IN CROCE
DI HAYDN CON IL QUARTETTO IRI DA IRI
Ieri
sera, Venerdì Santo, a Novara, il Quartetto
d’archi Iri da Iri ha eseguito uno dei
capolavori della musica religiosa di tutti i
tempi, “Le ultime sette parole di Cristo in
Croce” op.51 Hob: III di F. J. Haydn. La prima
versione di questo lavoro, per soli, coro e
orchestra, eseguita per la prima volta nel 1787,
venne quasi subito trascritta, già l’anno dopo,
con alcune importanti modifiche, per quartetto
d’archi da Haydn stesso, che, come è risaputo,
attribuiva grande efficacia emotiva alla musica
strumentale in chiesa. La composizione, nella
sua versione per quartetto d’archi, più snella
rispetto a quella per voci, coro e orchestra, è
suddivisa in sette ‘sonate’ (così le chiama
Haydn stesso, in quanto quasi tutte rispettano
lo schema della forma-sonata), tutte in tempo
lento e precedute da un’Introduzione, anch’essa
in tempo lento e concluse da un pezzo,
intitolato “Terremoto”, l’unico in tempo veloce,
un Presto .Le sette sonate sono intervallate da
brevi frasi in latino tratte dai Vangeli,
appunto le ultime sette frasi (‘parole’)
pronunciate da Cristo nella sua agonia sulla
croce. Realizzando le intenzioni dell’autore, il
Quartetto Iri da Iri ha scelto di eseguire le
Sette parole in una chiesa novarese, la
settecentesca (nell’attuale veste architettonica)
S. Andrea, rispettandone integralmente le
modalità esecutive, con la lettura, in italiano
dei brevi brani evangelici tra una sonata e
l’altra. seguiti da un breve commento .Sull’origine
del nome dell’ensemble abbiamo recentemente
parlato in un articolo del 17 marzo, e ci
esimiamo dal ripetere quanto già detto.
Precisiamo solo che il quartetto d’archi è
formato da Anna Molinari e Tea Vitali, violini,
Lara Albesano,
 viola,
Lucia Molinari, violoncello, tutte giovani
diplomate e perfezionate negli studi dei
rispettivi strumenti, seguendo corsi di
formazione rigorosi e con un’esperienza
concertistica ormai significativa. Il giudizio
su questa esecuzione non può che essere
ampiamente positivo: il quartetto Iri da Iri è
stato infatti pienamente all’altezza di un’opera
di grande valore, complessa sia sotto il profilo
tecnico, per la presenza di un fitto
contrappunto, sia per i profondi valori
espressivi che lo contraddistinguono. Tutte e
quattro le parti dell’Iri da Iri hanno suonato
con perfetta intonazione, con un suono chiaro e
preciso, con impeccabile intesa, con un
fraseggio ispirato da una cura rigorosa dei
dettagli dinamici, essenziali in quest’opera. Un
compito particolarmente gravoso, e assolto con
risultati eccellenti, toccava al violoncello,
cui era richiesta una particolare energia e
intensità nel volume del suono, in quanto
rappresentava l’unico basso in una composizione
che tende a gravitare su una sonorità cupa e
scura, tanto che alcuni quartetti scelgono di
rafforzare il violoncello, trasformandosi in
quintetti, con l’appoggio di un contrabbasso,
soluzione peraltro non autorizzata da Haydn:
ebbene, la qualità del suono cavato da Lucia
Molinari per volume e proiezione non ha fatto
rimpiangere certo il rinforzo del contrabbasso.
In generale Le sette ultime parole di Cristo
ascoltate ieri sera hanno colpito gli
ascoltatori (che hanno riempito la chiesa), per
il pathos, profondo, ma contenuto da una forma
musicale di classico nitore, e sostenuto da una
linea espressiva alimentata da un suono, in
particolare nelle sette sonate, sussultante, a
tratti quasi sospirato, di una delicatezza
sovente sfumata in pianissimi di eterea levità,
di potente carica suggestiva. I momenti in cui
questo ‘pathos sospirato’ si sono impennati in
una più accentuata tensione drammatica hanno
visto generalmente il primo violino come
strumento protagonista, come nel primo tema
dell’Introduzione, dove Anna Molinari ha dato
alla sua arcata una forza espressiva di alto
impatto emotivo o come nella cadenza solistica
della sonata IV, dove il suono del violino
sembra ricreare con efficacia l’atmosfera di
desolato abbandono e solitudine di Cristo sulla
Croce, a commento delle parole di Marco “Deus
meus, Deus meus, utquid dereliquisti me?” Tutta
l’opera, come abbiamo detto, nell’ora circa
della sua durata, ha incantato ed emozionato il
pubblico, ma se vogliamo indicare i momenti in
assoluto più alti, citeremmo le ultime tre
sonate: la V, la “sonata della sete” che segue
la parola di Cristo “sitio”, “ho sete”, coi
delicatissimi pizzicati degli archi all’unisono,
seguiti dal tema dell’invocazione drammatica; la
VI, il “Consummatum est” dove il sol minore
diventa davvero la ‘tonalità della morte’, con
il suo primo tema scandito su cinque note lunghe
in cui risuonano con tensione indicibile le
cinque sillabe della frase; la VII, infine, col
suo meraviglioso tema principale, di esaltante
serenità, col quale, alla fine del dramma della
passione, Gesù morente affida il suo spirito al
Padre. Le quattro bravissime strumentiste
dell’Iri da Iri hanno offerto di questi
altissimi momenti di straordinaria musica
un’interpretazione pienamente adeguata, che ha
emozionato e commosso il pubblico, che ha
tributato loro un meritatissimo, torrenziale
applauso. Davvero, da ricordare. viola,
Lucia Molinari, violoncello, tutte giovani
diplomate e perfezionate negli studi dei
rispettivi strumenti, seguendo corsi di
formazione rigorosi e con un’esperienza
concertistica ormai significativa. Il giudizio
su questa esecuzione non può che essere
ampiamente positivo: il quartetto Iri da Iri è
stato infatti pienamente all’altezza di un’opera
di grande valore, complessa sia sotto il profilo
tecnico, per la presenza di un fitto
contrappunto, sia per i profondi valori
espressivi che lo contraddistinguono. Tutte e
quattro le parti dell’Iri da Iri hanno suonato
con perfetta intonazione, con un suono chiaro e
preciso, con impeccabile intesa, con un
fraseggio ispirato da una cura rigorosa dei
dettagli dinamici, essenziali in quest’opera. Un
compito particolarmente gravoso, e assolto con
risultati eccellenti, toccava al violoncello,
cui era richiesta una particolare energia e
intensità nel volume del suono, in quanto
rappresentava l’unico basso in una composizione
che tende a gravitare su una sonorità cupa e
scura, tanto che alcuni quartetti scelgono di
rafforzare il violoncello, trasformandosi in
quintetti, con l’appoggio di un contrabbasso,
soluzione peraltro non autorizzata da Haydn:
ebbene, la qualità del suono cavato da Lucia
Molinari per volume e proiezione non ha fatto
rimpiangere certo il rinforzo del contrabbasso.
In generale Le sette ultime parole di Cristo
ascoltate ieri sera hanno colpito gli
ascoltatori (che hanno riempito la chiesa), per
il pathos, profondo, ma contenuto da una forma
musicale di classico nitore, e sostenuto da una
linea espressiva alimentata da un suono, in
particolare nelle sette sonate, sussultante, a
tratti quasi sospirato, di una delicatezza
sovente sfumata in pianissimi di eterea levità,
di potente carica suggestiva. I momenti in cui
questo ‘pathos sospirato’ si sono impennati in
una più accentuata tensione drammatica hanno
visto generalmente il primo violino come
strumento protagonista, come nel primo tema
dell’Introduzione, dove Anna Molinari ha dato
alla sua arcata una forza espressiva di alto
impatto emotivo o come nella cadenza solistica
della sonata IV, dove il suono del violino
sembra ricreare con efficacia l’atmosfera di
desolato abbandono e solitudine di Cristo sulla
Croce, a commento delle parole di Marco “Deus
meus, Deus meus, utquid dereliquisti me?” Tutta
l’opera, come abbiamo detto, nell’ora circa
della sua durata, ha incantato ed emozionato il
pubblico, ma se vogliamo indicare i momenti in
assoluto più alti, citeremmo le ultime tre
sonate: la V, la “sonata della sete” che segue
la parola di Cristo “sitio”, “ho sete”, coi
delicatissimi pizzicati degli archi all’unisono,
seguiti dal tema dell’invocazione drammatica; la
VI, il “Consummatum est” dove il sol minore
diventa davvero la ‘tonalità della morte’, con
il suo primo tema scandito su cinque note lunghe
in cui risuonano con tensione indicibile le
cinque sillabe della frase; la VII, infine, col
suo meraviglioso tema principale, di esaltante
serenità, col quale, alla fine del dramma della
passione, Gesù morente affida il suo spirito al
Padre. Le quattro bravissime strumentiste
dell’Iri da Iri hanno offerto di questi
altissimi momenti di straordinaria musica
un’interpretazione pienamente adeguata, che ha
emozionato e commosso il pubblico, che ha
tributato loro un meritatissimo, torrenziale
applauso. Davvero, da ricordare.
30 marzo 2024 Bruno Busca
Le
Sonate per
violino e fortepiano di
Mozart con Isabelle Faust e Alexander Melnikov
per il "Quartetto"
L'impaginato mozartiano scelto dalla violinista
tedesca Isabelle Faust e dal fortepianista
moscovita Alexander Melnikov prevedeva quattro
sonate: la K481, la K296, la
K303 e la K380. Siamo abituati ad
ascoltare Mozart con gli strumenti moderni, il
pianoforte evoluto dei nostri giorni e i violini
che, seppure spesso d'epoca, tendono ad
adeguarsi alle sonorità anche voluminose dei
pianoforti. Tra i vantaggi dei pianoforti
recenti c'è certamente la
maggiore resa
 volumetrica, che fa percepire le
sonorità nelle grandi sale da concerto anche a
chi si trova a notevole distanza. Ai tempi di
Mozart i luoghi della musica erano però più
raccolti, il clavicembalo e il fortepiano erano
tra gli strumenti a tastiera più diffusi, e
naturalmente il pensiero musicale dei
compositori si formava con le timbriche più
discrete di questi due strumenti. I due
eccellenti interpreti che abbiamo ascoltato ieri
sera in Sala Verdi per il "Quartetto" hanno
voluto ritrovare le timbriche che verosimilmente
erano quelle di maggior uso ai tempi di Mozart e
dai suoi contemporanei. Il fortepiano,
gentilmente concesso dalla collezione di
strumenti d'epoca di Fernanda Giulini, ha
permesso queste più autentiche interpretazioni
Dalle prime note della Sonata n.33 in mi bem.
maggiore K481 abbiamo riscoperto un Mozart
diverso: raccolto, interiorizzato e restituito
da una timbrica unitaria più "antica" che
nascondeva una gamma infinita di colori
sapientemente espressi dalle armonie del
fortepiano storico di Melnikov e dalle sottili
enunciazioni volumetrica, che fa percepire le
sonorità nelle grandi sale da concerto anche a
chi si trova a notevole distanza. Ai tempi di
Mozart i luoghi della musica erano però più
raccolti, il clavicembalo e il fortepiano erano
tra gli strumenti a tastiera più diffusi, e
naturalmente il pensiero musicale dei
compositori si formava con le timbriche più
discrete di questi due strumenti. I due
eccellenti interpreti che abbiamo ascoltato ieri
sera in Sala Verdi per il "Quartetto" hanno
voluto ritrovare le timbriche che verosimilmente
erano quelle di maggior uso ai tempi di Mozart e
dai suoi contemporanei. Il fortepiano,
gentilmente concesso dalla collezione di
strumenti d'epoca di Fernanda Giulini, ha
permesso queste più autentiche interpretazioni
Dalle prime note della Sonata n.33 in mi bem.
maggiore K481 abbiamo riscoperto un Mozart
diverso: raccolto, interiorizzato e restituito
da una timbrica unitaria più "antica" che
nascondeva una gamma infinita di colori
sapientemente espressi dalle armonie del
fortepiano storico di Melnikov e dalle sottili
enunciazioni
 melodiche della Faust, una coppia
di strumentisti integrati perfettamente in un
unicum di grande valore estetico. Rilevanti
tutte le quattro sonate con momenti di grande
riflessione nei movimenti centrali delle tre
maggiori, mentre per la più breve, la Sonata
n.20 in do maggiore K 303, in due soli parti,
l' Adagio era posto all'inizio. Una resa
complessiva che ha pienamente soddisfatto il
pubblico presente in Conservatorio. Interpreti
visibilmente soddisfatti e un bis concesso con
lo splendido Tempo di minuetto, movimento
centrale della Sonata in mi minore K304.
Concerto splendido! melodiche della Faust, una coppia
di strumentisti integrati perfettamente in un
unicum di grande valore estetico. Rilevanti
tutte le quattro sonate con momenti di grande
riflessione nei movimenti centrali delle tre
maggiori, mentre per la più breve, la Sonata
n.20 in do maggiore K 303, in due soli parti,
l' Adagio era posto all'inizio. Una resa
complessiva che ha pienamente soddisfatto il
pubblico presente in Conservatorio. Interpreti
visibilmente soddisfatti e un bis concesso con
lo splendido Tempo di minuetto, movimento
centrale della Sonata in mi minore K304.
Concerto splendido!
27 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
La
chitarra di Manuel Barrueco è tornata alle
Serate Musicali del Conservatorio
Ricordando lo splendido
concerto tenuto dal grande chitarrista Manuel
Barrueco nel maggio 2022, siamo tornati a
riascoltarlo ieri sera in Conservatorio, ancora
per l'organizzazione di Serate Musicali.
Un impaginato altrettanto diversificato e
ottimamente progettato attendeva il Maestro con
brani di Negri, Galilei, Bach, Sor, Harrison,
 Tàrrega e Turina, più alcuni anonimi della
tradizione più antica. Come avevamo già
sottolineato, si rimane stupiti della
completezza melodico-armonica di questo
strumento a sei corde che abbisogna di un
ascolto adeguato; dove l'attenzione
dell'ascoltatore deve andare incontro ai volumi
contenuti della cassa armonica per comprenderne
la ricchezza delle timbriche. Manuel Barrueco,
chitarrista cubano tra i più noti virtuosi di
questo strumento, eccelle per raffinatezza di
colore. Oscar Chilesotti ha trascritto alcuni
brani di danza anonimi, ma anche Bianco fiore di
Cesare Negri (1535-1604) e il Saltarello di
Vincenzo Galilei (1525-1591). Brani spesso per
liuto, che trascritti per chitarra conservano
ancora quelle timbriche antiche che Barrueco ha
perfettamente restituito con il suo armonioso
strumento. La splendida Suite per liuto n.3
in la minore BWV 995 di J S. Bach
(1685-1750) ha trovato poi un'esemplare
interpretazione nelle sei corde del chitarrista
cubano. Le atmosfere spagnole del
compositore-chitarrista Fernando Sor (1778-1839)
sono quindi arrivate con il Grand solo op. 14
( versione D. Aguado), un lavoro perfetto
formalmente ed espresso con destrezza armonica e
nitore timbrico Tàrrega e Turina, più alcuni anonimi della
tradizione più antica. Come avevamo già
sottolineato, si rimane stupiti della
completezza melodico-armonica di questo
strumento a sei corde che abbisogna di un
ascolto adeguato; dove l'attenzione
dell'ascoltatore deve andare incontro ai volumi
contenuti della cassa armonica per comprenderne
la ricchezza delle timbriche. Manuel Barrueco,
chitarrista cubano tra i più noti virtuosi di
questo strumento, eccelle per raffinatezza di
colore. Oscar Chilesotti ha trascritto alcuni
brani di danza anonimi, ma anche Bianco fiore di
Cesare Negri (1535-1604) e il Saltarello di
Vincenzo Galilei (1525-1591). Brani spesso per
liuto, che trascritti per chitarra conservano
ancora quelle timbriche antiche che Barrueco ha
perfettamente restituito con il suo armonioso
strumento. La splendida Suite per liuto n.3
in la minore BWV 995 di J S. Bach
(1685-1750) ha trovato poi un'esemplare
interpretazione nelle sei corde del chitarrista
cubano. Le atmosfere spagnole del
compositore-chitarrista Fernando Sor (1778-1839)
sono quindi arrivate con il Grand solo op. 14
( versione D. Aguado), un lavoro perfetto
formalmente ed espresso con destrezza armonica e
nitore timbrico
 da Barrueco. Il brano successivo
ci ha portato al Novecento di Lou Harrison
(1917-2003) con cinque brani tra cui Serenado
por gitaro, Music for Bill and me, Sonata for
Ishartum e le Serenade Air e
Round. Brani scritti molto bene per la
chitarra, di non difficile ricezione. Gli ultimi
brani dell'impaginato erano di Francisco Tárrega
(1852-1909) e di Joaquín Turina ( 1882-1949).
Trent'anni separano le date di nascita dei due
compositori spagnoli, il primo anche chitarrista
e il secondo pianista. Diverse modalità
stilistiche si riscontrano nei due lavori
proposti: il primo, di Tárrega, era il
Capricho Árabe, particolarmente celebre nei
modi tipici ottocenteschi delle sue timbriche
spagnole; il secondo, di Turina, era la più
corposa Sonata in re minore op.61, nei
classici tre movimenti Allegro, Andante e
Allegro vivo . È un brano proiettato nelle
modalità stilistiche novecentesche, ma ispirato
dal flamenco andaluso per una sorta di fantasia
particolarmente riuscita nelle influenze delle
timbriche spagnole. Interpretazioni di rara
qualità, apprezzate dal pubblico presente, con
numerosi giovani amanti e/o praticanti della
chitarra. Tre i bis concessi, due danze antiche
le prime e nel finale il Fandanguillo di
Torroba. Applausi calorosi. da Barrueco. Il brano successivo
ci ha portato al Novecento di Lou Harrison
(1917-2003) con cinque brani tra cui Serenado
por gitaro, Music for Bill and me, Sonata for
Ishartum e le Serenade Air e
Round. Brani scritti molto bene per la
chitarra, di non difficile ricezione. Gli ultimi
brani dell'impaginato erano di Francisco Tárrega
(1852-1909) e di Joaquín Turina ( 1882-1949).
Trent'anni separano le date di nascita dei due
compositori spagnoli, il primo anche chitarrista
e il secondo pianista. Diverse modalità
stilistiche si riscontrano nei due lavori
proposti: il primo, di Tárrega, era il
Capricho Árabe, particolarmente celebre nei
modi tipici ottocenteschi delle sue timbriche
spagnole; il secondo, di Turina, era la più
corposa Sonata in re minore op.61, nei
classici tre movimenti Allegro, Andante e
Allegro vivo . È un brano proiettato nelle
modalità stilistiche novecentesche, ma ispirato
dal flamenco andaluso per una sorta di fantasia
particolarmente riuscita nelle influenze delle
timbriche spagnole. Interpretazioni di rara
qualità, apprezzate dal pubblico presente, con
numerosi giovani amanti e/o praticanti della
chitarra. Tre i bis concessi, due danze antiche
le prime e nel finale il Fandanguillo di
Torroba. Applausi calorosi.
26 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Recital
di Rosa Feola
al Teatro alla Scala
Ieri
sera Rosa Feola ha ottenuto un meritatissimo
successo al Teatro alla Scala. Il soprano, nata
a San Nicola la Strada in provincia di Caserta,
aveva l'eccellente sostegno strumentale del
pianista romano Fabio Centanni, in un repertorio
che includeva brani di Rossini, Martucci,
Respighi, Debussy, Mozart e Donizetti. Nella
prima parte della serata alcuni brani erano
rarità di grande valore, quali i Tre pezzi
op. 84 di Giuseppe Martucci o i Quattro
rispetti toscani di Ottorino Respighi,
anticipati dalla Regata veneziana di
Gioachino Rossini e conclusi con l'intenso
Azael, Azael perche mi hai lasciata, dall'Enfant
prodigue di Claude Debussy. L'ottima
timbrica della Feola ha trovato
 precise
armonizzazioni da Centanni, calibrate in ogni
registro per sostenere ogni sottile inflessione
coloristica della voce. Di maggiore
frequentazione i brani della seconda parte del
recital con un' aria dal Don Giovanni di Mozart,
Don Ottavio, son morta! Qui la Feola,
coadiuvata dal tenore Haiyang Guo, allievo del
corsi di perfezionamenti scaligeri, ha esternato
maggiormente tutta la sua intensità vocale con
grande abilità anche attoriale. A seguire sono
state eseguiti Bel raggio lusinghier da
Semiramide di Rossini e Regnava nel
silenzio da Lucia di Lammermoor di
Donizetti, entrambi ancora indicativi delle
qualità del grande soprano. Le capacità
interpretative di Centanni le abbiamo rilevate
anche nei due brani per solo pianoforte,
eseguiti nei momenti di riposo della voce di
Feola: prima il pregnante Debussy con
Poissons d'or, dalla seconda serie di
Images e poi l'efficace e graziosissimo
Petite caprice ( in stile Offenbach) dai
Péchés de vieillesse di Rossini. Applausi
calorosissimi in un teatro gremito di pubblico e
tre bis concessi dalla Feola con Quando men
vò soletta per la via da Bohème, A'
vucchella di F.P. Tosti e Signore ascolta
da Turandot. Voce eccellente e soprano
visibilmente soddisfatto. precise
armonizzazioni da Centanni, calibrate in ogni
registro per sostenere ogni sottile inflessione
coloristica della voce. Di maggiore
frequentazione i brani della seconda parte del
recital con un' aria dal Don Giovanni di Mozart,
Don Ottavio, son morta! Qui la Feola,
coadiuvata dal tenore Haiyang Guo, allievo del
corsi di perfezionamenti scaligeri, ha esternato
maggiormente tutta la sua intensità vocale con
grande abilità anche attoriale. A seguire sono
state eseguiti Bel raggio lusinghier da
Semiramide di Rossini e Regnava nel
silenzio da Lucia di Lammermoor di
Donizetti, entrambi ancora indicativi delle
qualità del grande soprano. Le capacità
interpretative di Centanni le abbiamo rilevate
anche nei due brani per solo pianoforte,
eseguiti nei momenti di riposo della voce di
Feola: prima il pregnante Debussy con
Poissons d'or, dalla seconda serie di
Images e poi l'efficace e graziosissimo
Petite caprice ( in stile Offenbach) dai
Péchés de vieillesse di Rossini. Applausi
calorosissimi in un teatro gremito di pubblico e
tre bis concessi dalla Feola con Quando men
vò soletta per la via da Bohème, A'
vucchella di F.P. Tosti e Signore ascolta
da Turandot. Voce eccellente e soprano
visibilmente soddisfatto.
25 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
A
Musica Maestri! la
giovanissima Martina
Meola
Musica
Maestri!, la
Stagione concertistica dei docenti e degli
studenti vincitori di premi del Conservatorio
milanese, ha ospitato in Sala Puccini la
pianista Martina Meola. Nata nel novembre 2012,
non ha ancora dodici anni e ha vinto il premio
per I Giovani Talenti categoria H. Il non
breve concerto era abbinato ad un incontro
importante con il
 CUAMM-
Medici con l'Africa, un gruppo di volontari che
sostengono la formazione del personale sanitario,
finanziando la borsa di studio per un medico
referente per l'ospedale statale Rumbek in Sud
Sudan. La sala, colma di pubblico, ha ascoltato
con attenzione Martina in un impaginato assai
diversificato, che prevedeva brani di Schumann,
Beethoven, Chopin, Liszt e Granados. Un pianismo
perfetto nella classicità di brani importanti
quello ascoltato, con alcuni lavori corposi come
il Tema con variazioni sul nome Abegg op.1
di Schumann o la Sonata n.17 op.31 n.2
"La tempesta" di Beethoven. Brani piu brevi
come lo Studio n.1 op.25 o il Valzer
op.64 n.2 di Chopin o il delizioso
Piccolo Valzer di Puccini, dalla Bohème (
aria di Musetta). D'incredibile virtuosismo il
Liszt della Rapsodia ungherese n.11 o il
Granados dell'Allegro da concerto op.46.
Tra i bis concessi da Martina, il Valzer
Op.64 n.1 di Chopin o il Sogno d'amore
di Liszt. Si rimane davvero sbalorditi per
l'avanzato CUAMM-
Medici con l'Africa, un gruppo di volontari che
sostengono la formazione del personale sanitario,
finanziando la borsa di studio per un medico
referente per l'ospedale statale Rumbek in Sud
Sudan. La sala, colma di pubblico, ha ascoltato
con attenzione Martina in un impaginato assai
diversificato, che prevedeva brani di Schumann,
Beethoven, Chopin, Liszt e Granados. Un pianismo
perfetto nella classicità di brani importanti
quello ascoltato, con alcuni lavori corposi come
il Tema con variazioni sul nome Abegg op.1
di Schumann o la Sonata n.17 op.31 n.2
"La tempesta" di Beethoven. Brani piu brevi
come lo Studio n.1 op.25 o il Valzer
op.64 n.2 di Chopin o il delizioso
Piccolo Valzer di Puccini, dalla Bohème (
aria di Musetta). D'incredibile virtuosismo il
Liszt della Rapsodia ungherese n.11 o il
Granados dell'Allegro da concerto op.46.
Tra i bis concessi da Martina, il Valzer
Op.64 n.1 di Chopin o il Sogno d'amore
di Liszt. Si rimane davvero sbalorditi per
l'avanzato livello interpretativo della giovanissima Meola,
che studia in Conservatorio con la docente
Silvia Limongelli: insegnante che ha il non
facile compito di dare indicazioni ad un'allieva
così talentuosa! La pregnante restituzione della
Sonata beethoveniana, la facilità di
esternazione della Rapsodia di Liszt o
dell'Allegro di Granados, la trasparenza
timbrica di tutti i lavori, rivelano doti
naturali di una pianista dalle risorse già
eccezionali, che certamente daranno molti frutti
durante la sua crescita musicale. Pubblico
entusiasta ed applausi calorosi a Martina -
graziosissima nel suo abito bianco - , che ha
ricevuto i complimenti
livello interpretativo della giovanissima Meola,
che studia in Conservatorio con la docente
Silvia Limongelli: insegnante che ha il non
facile compito di dare indicazioni ad un'allieva
così talentuosa! La pregnante restituzione della
Sonata beethoveniana, la facilità di
esternazione della Rapsodia di Liszt o
dell'Allegro di Granados, la trasparenza
timbrica di tutti i lavori, rivelano doti
naturali di una pianista dalle risorse già
eccezionali, che certamente daranno molti frutti
durante la sua crescita musicale. Pubblico
entusiasta ed applausi calorosi a Martina -
graziosissima nel suo abito bianco - , che ha
ricevuto i complimenti
 anche
dal direttore del Conservatorio di Milano "G.
Verdi" Massimiliano Baggio , salito sul
palcoscenico insieme a un rappresentante del
CUAMM. Questo a sua volta ha ringraziato un
giovane medico, Alberto, che è stato lo scorso
anno in Sud Sudan a formare altri medici (per
sostenere l'attività del CUAMM, si può versare
un bonifico con causale "PMB3 Rumbek_FORMAZIONE
Erogazione liberale" Banca Popolare Etica IBAN:
IT 32C 0501812101 000011078904
www.mediciconlafrica.org
).
Un concerto magnifico e importante! anche
dal direttore del Conservatorio di Milano "G.
Verdi" Massimiliano Baggio , salito sul
palcoscenico insieme a un rappresentante del
CUAMM. Questo a sua volta ha ringraziato un
giovane medico, Alberto, che è stato lo scorso
anno in Sud Sudan a formare altri medici (per
sostenere l'attività del CUAMM, si può versare
un bonifico con causale "PMB3 Rumbek_FORMAZIONE
Erogazione liberale" Banca Popolare Etica IBAN:
IT 32C 0501812101 000011078904
www.mediciconlafrica.org
).
Un concerto magnifico e importante!
25 marzo 2024
Cesare Guzzardella
IL
VIOLINO DI SERGEJ
KHACHATRYAN ILLUMINA IL
VIOTTIFESTIVAL DI VERCELLI
Ieri sera, al Teatro Civico
di Vercelli, la ventiseiesima stagione del
ViottiFestival, che coincide con il bicentenario
della morte del grande musicista vercellese, ha
avuto come protagonista uno dei più affermati
violinisti della ‘generazione degli anni 80’,
l’armeno Sergej Khachatryan, balzato nel 2000
agli onori della cronaca musicale internazionale
col primo premio al Concorso Sibelius e
definitivamente consacrato cinque anni dopo dal
Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles (l’equivalente
per il violino di ciò che è il van Cliburn per
il pianoforte) , come uno dei più importanti
violinisti del nostro tempo. Il programma della
serata, dedicata doverosamente al ricordo di
Maurizio Pollini, lo vedeva solista nel primo
dei due pezzi proposti, uno dei più celebri ed
eseguiti in assoluto tra i concerti per violino
e orchestra, quello di Beethoven in Re maggiore
op.61. Ad accompagnare il solista era, come
d’abitudine, l’Orchestra Camerata Ducale diretta
da Guido Rimonda: dalla collaborazione tra
direzione orchestrale e solista è nata
un’interpretazione di questo capolavoro
beethoveniano che riteniamo di poter annoverare
tra le migliori da noi ascoltate negli ultimi
anni, un’interpretazione capace di dare voce
suggestiva ed emozionante al clima espressivo di
questa partitura, fondato su uno stretto
rapporto dialogico tra solista e compagine
orchestrale, con tutta l’infinita gamma di
sfumature ritmiche, timbriche, dinamiche, cui
esso dà luogo. Ovviamente in primo piano è stata
la prova di Khachatryan, alla sua prima
esibizione a Vercelli. Dire che il trentottenne
violinista armeno
 domina
senza problemi le numerose parti virtuosistiche
previste dalla partitura, non solo nelle due
cadenze dei tempi esterni, e in particolare nel
finale Rondò, è, ormai, dire nulla, poiché tutti
i violinisti delle ultime generazioni in genere
possiedono un completo controllo dei mezzi
tecnici, grazie all’avanzato perfezionamento
della didattica dello strumento nei Conservatori
di tutto il mondo. Il valore di un violinista,
come di qualsiasi altro solista, si giudica
dalla capacità di mettere il proprio bagaglio
tecnico al servizio di un’interpretazione, di un
‘esplorazione delle potenzialità espressive del
pezzo eseguito. Ebbene, non esitiamo a definire
‘carismatica’ l’interpretazione del concerto di
Beethoven offerta ieri da Khachatryan.
Sfruttando al massimo il suono particolare del
suo Guarneri del Gesù “Ysaye” 1740, umbratile e
sensuale, il violinista armeno ha creato
atmosfere timbriche di estrema raffinatezza, a
cominciare da quella incantata sospensione
lirica con cui ha subito catturato le menti
degli ascoltatori nella riesposizione del tema
principale dell’Allegro ma non troppo iniziale,
cavando dal registro più acuto un suono di
eterea finezza. Nella lunga linea melodica,
quasi dolcissima cantilena, in cui a un certo
punto si trasforma il tema principale del
Larghetto centrale, Khachatryan esibisce le
migliori qualità del suo fraseggio: intonazione
perfetta, un’articolazione delle singole frasi
che è pura bellezza, precisione assoluta per le
più sottili variazioni timbriche, sensibilità
per le dinamiche e le varie ombreggiature del
suono, con arcate sempre intese ai valori
espressivi, screziate da un vibrato misurato e
amabile. Un suono, in generale, quello di
Khachatryan, che, pur non ignorando certo
momenti di potente energia (tra tutti, l’attacco
del primo couplet del finale Rondò, ma in
generale l’intero terzo movimento), si distingue
prevalentemente per un che di intimistico, di
dolcemente suadente, talora come avvolto da
sottilissime velature, ma che sa farsi raggio di
luce cristallina nei trilli, negli arpeggi e nei
vari abbellimenti, frequenti in questo concerto
in tutti e tre i tempi, tra i quali
indimenticabile il lungo trillo che sembra
illuminare il morbido panneggio dei fagotti e
dei clarinetti, nella ripresa del secondo tema
della seconda esposizione dell’Allegro
d’apertura. Insomma: la ricerca interpretativa
ed espressiva di Khachatryan valorizza al
massimo l’ideale d’intimismo espressivo che è il
centro d’ispirazione di questo concerto
beethoveniano, senza tuttavia rinunciare a
quegli ‘scatti’ e illuminazioni improvvise che
rivelano come una corrente di sotterranea
energia, del resto evocata alle soglie del
concerto dalla misteriosa pulsazione dei
timpani. Dal podio Rimonda ha guidato la
Camerata Ducale in un dialogo costante, preciso
ed efficace con il solista, sempre sostenendo
con coerenza la sua linea interpretativa: di
particolare bellezza gli impasti timbrici,
soprattutto nelle tinte delicate ottenuta dai
legni, e ottimamente gestite le dinamiche,
soprattutto quelle più intimistiche e ‘ in
sordina’: un esempio da antologia di entrambi
questi elementi della direzione di Rimonda è
stata l’introduzione all’Andante, coi suoi archi
in pianissimo, seguiti dalla delicata pennellata
di clarinetti e fagotti, un momento di musica
eseguito con suggestiva finezza e gran classe. I
torrenziali applausi del pubblico assiepato al
Civico ottenevano un lungo fuori programma,
banco di prova del vertiginoso virtuosismo di
Khachatryan: non abbiamo identificato con
sicurezza l’autore del pezzo, azzardiamo Ysaye.
A seguire, e concludere la serata, di Luigi
Cherubini, la Sinfonia in Re maggiore Parc 54.
Nell’impaginato del concerto la presenza di
Cherubini richiama quella di Viotti,
compensandone, in un certo senso, l’assenza:
contemporaneo del grande vercellese, Cherubini
fu anche legato a lui da stretti rapporti di
amicizia; anzi, la sua decisione, nel 1788, di
lasciare per sempre l’Italia per trasferirsi a
Parigi, si deve anche all’invito di Viotti, che
nella capitale francese lo aveva preceduto sette
anni prima. Si aggiunga che entrambi i musicisti
italiani godettero dell’ammirazione di
Beethoven, e si comprenderanno bene le ragioni
del programma di questo concerto. Questa
sinfonia, a parte quelle d’opera, è l’unica
composta da Cherubini, nel 1815. Amata da
Schumann, che paragonava Cherubini addirittura a
Dante (?!), caduta nel più totale oblio nel
secondo ‘800, venne riscoperta nel 1935 e da
allora, pur non godendo di vasta popolarità, è
entrata abbastanza stabilmente nei repertori
delle orchestre, non solo italiane. Nei canonici
quattro tempi, mostra una qualche apertura al
classicismo viennese, in particolare ad Haydn.,
accanto a cui convivono sprazzi di chiara
reminiscenza dell’opera comica napoletana tra
Cimarosa e Paisiello. Al di là dei modelli e dei
riferimenti, sempre opinabili, all’ascolto
questa sinfonia di Cherubini presenta una sua
notevole originalità, che ne fa senz’altro domina
senza problemi le numerose parti virtuosistiche
previste dalla partitura, non solo nelle due
cadenze dei tempi esterni, e in particolare nel
finale Rondò, è, ormai, dire nulla, poiché tutti
i violinisti delle ultime generazioni in genere
possiedono un completo controllo dei mezzi
tecnici, grazie all’avanzato perfezionamento
della didattica dello strumento nei Conservatori
di tutto il mondo. Il valore di un violinista,
come di qualsiasi altro solista, si giudica
dalla capacità di mettere il proprio bagaglio
tecnico al servizio di un’interpretazione, di un
‘esplorazione delle potenzialità espressive del
pezzo eseguito. Ebbene, non esitiamo a definire
‘carismatica’ l’interpretazione del concerto di
Beethoven offerta ieri da Khachatryan.
Sfruttando al massimo il suono particolare del
suo Guarneri del Gesù “Ysaye” 1740, umbratile e
sensuale, il violinista armeno ha creato
atmosfere timbriche di estrema raffinatezza, a
cominciare da quella incantata sospensione
lirica con cui ha subito catturato le menti
degli ascoltatori nella riesposizione del tema
principale dell’Allegro ma non troppo iniziale,
cavando dal registro più acuto un suono di
eterea finezza. Nella lunga linea melodica,
quasi dolcissima cantilena, in cui a un certo
punto si trasforma il tema principale del
Larghetto centrale, Khachatryan esibisce le
migliori qualità del suo fraseggio: intonazione
perfetta, un’articolazione delle singole frasi
che è pura bellezza, precisione assoluta per le
più sottili variazioni timbriche, sensibilità
per le dinamiche e le varie ombreggiature del
suono, con arcate sempre intese ai valori
espressivi, screziate da un vibrato misurato e
amabile. Un suono, in generale, quello di
Khachatryan, che, pur non ignorando certo
momenti di potente energia (tra tutti, l’attacco
del primo couplet del finale Rondò, ma in
generale l’intero terzo movimento), si distingue
prevalentemente per un che di intimistico, di
dolcemente suadente, talora come avvolto da
sottilissime velature, ma che sa farsi raggio di
luce cristallina nei trilli, negli arpeggi e nei
vari abbellimenti, frequenti in questo concerto
in tutti e tre i tempi, tra i quali
indimenticabile il lungo trillo che sembra
illuminare il morbido panneggio dei fagotti e
dei clarinetti, nella ripresa del secondo tema
della seconda esposizione dell’Allegro
d’apertura. Insomma: la ricerca interpretativa
ed espressiva di Khachatryan valorizza al
massimo l’ideale d’intimismo espressivo che è il
centro d’ispirazione di questo concerto
beethoveniano, senza tuttavia rinunciare a
quegli ‘scatti’ e illuminazioni improvvise che
rivelano come una corrente di sotterranea
energia, del resto evocata alle soglie del
concerto dalla misteriosa pulsazione dei
timpani. Dal podio Rimonda ha guidato la
Camerata Ducale in un dialogo costante, preciso
ed efficace con il solista, sempre sostenendo
con coerenza la sua linea interpretativa: di
particolare bellezza gli impasti timbrici,
soprattutto nelle tinte delicate ottenuta dai
legni, e ottimamente gestite le dinamiche,
soprattutto quelle più intimistiche e ‘ in
sordina’: un esempio da antologia di entrambi
questi elementi della direzione di Rimonda è
stata l’introduzione all’Andante, coi suoi archi
in pianissimo, seguiti dalla delicata pennellata
di clarinetti e fagotti, un momento di musica
eseguito con suggestiva finezza e gran classe. I
torrenziali applausi del pubblico assiepato al
Civico ottenevano un lungo fuori programma,
banco di prova del vertiginoso virtuosismo di
Khachatryan: non abbiamo identificato con
sicurezza l’autore del pezzo, azzardiamo Ysaye.
A seguire, e concludere la serata, di Luigi
Cherubini, la Sinfonia in Re maggiore Parc 54.
Nell’impaginato del concerto la presenza di
Cherubini richiama quella di Viotti,
compensandone, in un certo senso, l’assenza:
contemporaneo del grande vercellese, Cherubini
fu anche legato a lui da stretti rapporti di
amicizia; anzi, la sua decisione, nel 1788, di
lasciare per sempre l’Italia per trasferirsi a
Parigi, si deve anche all’invito di Viotti, che
nella capitale francese lo aveva preceduto sette
anni prima. Si aggiunga che entrambi i musicisti
italiani godettero dell’ammirazione di
Beethoven, e si comprenderanno bene le ragioni
del programma di questo concerto. Questa
sinfonia, a parte quelle d’opera, è l’unica
composta da Cherubini, nel 1815. Amata da
Schumann, che paragonava Cherubini addirittura a
Dante (?!), caduta nel più totale oblio nel
secondo ‘800, venne riscoperta nel 1935 e da
allora, pur non godendo di vasta popolarità, è
entrata abbastanza stabilmente nei repertori
delle orchestre, non solo italiane. Nei canonici
quattro tempi, mostra una qualche apertura al
classicismo viennese, in particolare ad Haydn.,
accanto a cui convivono sprazzi di chiara
reminiscenza dell’opera comica napoletana tra
Cimarosa e Paisiello. Al di là dei modelli e dei
riferimenti, sempre opinabili, all’ascolto
questa sinfonia di Cherubini presenta una sua
notevole originalità, che ne fa senz’altro
 l’albero
più frondoso e maestoso del povero, limitato
orticello del sinfonismo italiano nell’età d’oro
del classicismo austro-tedesco. Tale originalità
è ben colta e interpretata da Rimonda, come
sempre impeccabile nell’eleganza del suono,
nello stacco dei tempi, nella cura meticolosa di
dinamiche e timbriche in cui peraltro raramente
la partitura crea impasti tra archi e fiati,
preferendo in genere sfruttarli a blocchi
separati . Rimonda mette in pieno risalto quella
che, in definitiva, è la caratteristica
dominante di questa sinfonia: il suo ‘strano’
ritmo, il continuo contrasto tra temi e motivi e
stati d’animo opposti, sottolineando la
singolarità di una architettura che non ha
termini di paragone nella musica dell’epoca:
invece di sviluppare i temi, Cherubini li
frammenta, inserisce spunti secondari, frasi
indipendenti, giustappone motivi eterogenei, ora
solenni, ora grotteschi, ora ironici, ora
percorsi da un brivido d’inquietudine.
Affascinante ne risulta il Minuetto, con il
singhiozzo dei suoi accenti sincopati e con un
Trio intermedio, che, per il modo in cui lo
esegue Rimonda, potrebbe ricordare la giocosa
leggerezza di Bizet, in cui lampeggia a tratti
la divertita malizia di un Rossini. E, a voler
azzardare un paragone, la spavalda e trascinante
vitalità del Finale Allegro assai par quasi
anticipare qualcosa dei Davidsbundler
schumanniani (forse proprio qui stanno le
ragioni dell’ammirazione di Schumann per
Cherubini). Una pregevole esecuzione, che ci ha
fatto venir voglia, tornati a casa, di togliere
dal dimenticatoio in cui l’avevamo confinata
sugli scaffali più remoti della nostra personale
discoteca e riascoltarla, dopo tanti anni,
questa strana, amabile sinfonia. Un’ altra,
bella, interessante, memorabile serata al Civico
di Vercelli: ma ormai, serate così, al
ViottiFestival, non si contano più… (Foto in alto Ufficio Stampa di Vercelli) l’albero
più frondoso e maestoso del povero, limitato
orticello del sinfonismo italiano nell’età d’oro
del classicismo austro-tedesco. Tale originalità
è ben colta e interpretata da Rimonda, come
sempre impeccabile nell’eleganza del suono,
nello stacco dei tempi, nella cura meticolosa di
dinamiche e timbriche in cui peraltro raramente
la partitura crea impasti tra archi e fiati,
preferendo in genere sfruttarli a blocchi
separati . Rimonda mette in pieno risalto quella
che, in definitiva, è la caratteristica
dominante di questa sinfonia: il suo ‘strano’
ritmo, il continuo contrasto tra temi e motivi e
stati d’animo opposti, sottolineando la
singolarità di una architettura che non ha
termini di paragone nella musica dell’epoca:
invece di sviluppare i temi, Cherubini li
frammenta, inserisce spunti secondari, frasi
indipendenti, giustappone motivi eterogenei, ora
solenni, ora grotteschi, ora ironici, ora
percorsi da un brivido d’inquietudine.
Affascinante ne risulta il Minuetto, con il
singhiozzo dei suoi accenti sincopati e con un
Trio intermedio, che, per il modo in cui lo
esegue Rimonda, potrebbe ricordare la giocosa
leggerezza di Bizet, in cui lampeggia a tratti
la divertita malizia di un Rossini. E, a voler
azzardare un paragone, la spavalda e trascinante
vitalità del Finale Allegro assai par quasi
anticipare qualcosa dei Davidsbundler
schumanniani (forse proprio qui stanno le
ragioni dell’ammirazione di Schumann per
Cherubini). Una pregevole esecuzione, che ci ha
fatto venir voglia, tornati a casa, di togliere
dal dimenticatoio in cui l’avevamo confinata
sugli scaffali più remoti della nostra personale
discoteca e riascoltarla, dopo tanti anni,
questa strana, amabile sinfonia. Un’ altra,
bella, interessante, memorabile serata al Civico
di Vercelli: ma ormai, serate così, al
ViottiFestival, non si contano più… (Foto in alto Ufficio Stampa di Vercelli)
24-03-24 Bruno Busca
Il concerto de I Pomeriggi
Musicali, ricordando Maurizio Pollini
Ho
riascoltato volentieri il concerto diretto da
Alessandro Cadario per I
Pomeriggi Musicali, per riassaporare sia
l'ottimo Beethoven che la bravura del pianista
Emanuele Arciuli, alle prese con l'avvincente
Concerto per pianoforte e orchestra "
Luminary" del compositore thailandese
Narong Prangcharoen, un lavoro di particolare
resa, la cui anteprima di giovedì 21 è stata già
da me commentata. La triste notizia, diffusasi
immediatamente, della scomparsa del grandissimo
Maurizio Pollini (5 gennaio 1942-
23 marzo 2024),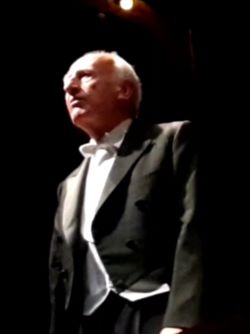 che ci ha lasciato questa mattina a 82 anni, ha
purtroppo connotato la giornata. Pollini è
sempre stato un punto di riferimento del
concertismo pianistico, che con lui ha trovato
il modo migliore per un'efficace condivisione
del repertorio classico, grazie ai suoi
amatissimi Beethoven, Chopin, Schubert e ai
compositori del Novecento da lui privilegiati,
come Stravinskij, Bartok, Schönberg,
Stockhausen, Nono. Pollini ha dato meravigliosi
concerti per oltre sessant'anni nelle sale della
nostra città e soprattutto nel suo amato Teatro
alla Scala dove ha voluto suonare fino
all'ultimo, anche quando la malattia gli rendeva
faticosa la tastiera. Oggi, alla
che ci ha lasciato questa mattina a 82 anni, ha
purtroppo connotato la giornata. Pollini è
sempre stato un punto di riferimento del
concertismo pianistico, che con lui ha trovato
il modo migliore per un'efficace condivisione
del repertorio classico, grazie ai suoi
amatissimi Beethoven, Chopin, Schubert e ai
compositori del Novecento da lui privilegiati,
come Stravinskij, Bartok, Schönberg,
Stockhausen, Nono. Pollini ha dato meravigliosi
concerti per oltre sessant'anni nelle sale della
nostra città e soprattutto nel suo amato Teatro
alla Scala dove ha voluto suonare fino
all'ultimo, anche quando la malattia gli rendeva
faticosa la tastiera. Oggi, alla
 replica
pomeridiana del concerto de I
Pomeriggi Musicali, dopo l'annuncio
iniziale della scomparsa del Maestro,il
direttore Cadario e i Professori d'Orchestra,
unitamente a tutto il pubblico in piedi, lo
hanno omaggiato con un minuto di silenzio. Dopo
l'ottima interpretazione del valido concerto di
Prangcharoen,eseguito ancora una volta molto
bene, Emanuele Arciuli ha voluto ricordare
personalmente Pollini eseguendo come bis uno dei
lavori più cari al grande pianista, i Sei
pezzi op.19 di Arnold Schönberg. Lavori
brevissimi ma intensi, di cui Arciuli ha dato
un' ottima resa estetica. replica
pomeridiana del concerto de I
Pomeriggi Musicali, dopo l'annuncio
iniziale della scomparsa del Maestro,il
direttore Cadario e i Professori d'Orchestra,
unitamente a tutto il pubblico in piedi, lo
hanno omaggiato con un minuto di silenzio. Dopo
l'ottima interpretazione del valido concerto di
Prangcharoen,eseguito ancora una volta molto
bene, Emanuele Arciuli ha voluto ricordare
personalmente Pollini eseguendo come bis uno dei
lavori più cari al grande pianista, i Sei
pezzi op.19 di Arnold Schönberg. Lavori
brevissimi ma intensi, di cui Arciuli ha dato
un' ottima resa estetica.
23 marzo 2024 Cesare Guzzardella
Alessandro Cadario ed
Emanuele Arciuli con
I Pomeriggi Musicali per un
concerto di Prangcharoen
L'interessante impaginato
ascoltato questa mattina all'anteprima dei
concerti de "I Pomeriggi Musicali" prevedeva
brani di due compositori, L.v. Beethoven e il
thailandese Narong Prangcharoen (1973). Alla
direzione dell'orchestra c'era Alessandro
Cadario, rinomato direttore sia dei grandi
classici che del repertorio contemporaneo. I
noti lavori del genio tedesco erano l'Ouverture
 "Le creature di Prometeo", eseguita ad
introduzione del concerto, e la Sinfonia n.7
in la maggiore op.92, elargita al termine.
Centralmente, in Prima esecuzione italiana,
il Concerto per pianoforte e orchestra
"Luminary" di Prangcharoen ha visto come
solista Emanuele Arciuli, un esperto nel settore
contemporaneo, sempre alla ricerca di novità
interpretative come la riuscita composizione del
thailandese. Il corposo brano di oltre
venticinque minuti è stato realizzato nel 2016 e
dedicato al maestro del compositore, il pianista
Bennett Lerner. È un unico lungo movimento dove
però si riconoscono tre parti: quella centrale
più lirica in contrasto con la dinamicità di
quelle laterali. La forza espressiva di questa
suggestiva opera, sorretta da una solida
impalcatura dal carattere narrativo, rimane
impressa per il ruolo incisivo, spesso
percussivo del pianoforte, perfettamente
integrato con l'evidente sinfonismo orchestrale
altrettanto acceso. Non mancano i frangenti più
meditativi, come quelli della parte centrale o
nelle brevi cadenze pianistiche. Arciuli ha
sostenuto la non facile parte solistica "Le creature di Prometeo", eseguita ad
introduzione del concerto, e la Sinfonia n.7
in la maggiore op.92, elargita al termine.
Centralmente, in Prima esecuzione italiana,
il Concerto per pianoforte e orchestra
"Luminary" di Prangcharoen ha visto come
solista Emanuele Arciuli, un esperto nel settore
contemporaneo, sempre alla ricerca di novità
interpretative come la riuscita composizione del
thailandese. Il corposo brano di oltre
venticinque minuti è stato realizzato nel 2016 e
dedicato al maestro del compositore, il pianista
Bennett Lerner. È un unico lungo movimento dove
però si riconoscono tre parti: quella centrale
più lirica in contrasto con la dinamicità di
quelle laterali. La forza espressiva di questa
suggestiva opera, sorretta da una solida
impalcatura dal carattere narrativo, rimane
impressa per il ruolo incisivo, spesso
percussivo del pianoforte, perfettamente
integrato con l'evidente sinfonismo orchestrale
altrettanto acceso. Non mancano i frangenti più
meditativi, come quelli della parte centrale o
nelle brevi cadenze pianistiche. Arciuli ha
sostenuto la non facile parte solistica
 con
grande precisione nelle scansioni ritmiche,
spesso una miriade di note ribattute volte a
sostenere la tensione drammatica accentuata.
L'esemplare resa complessiva del solista,
unitamente all'ottima sinergia con la direzione
di Cadario e la valida resa espressiva di ogni
sezione orchestrale, ha generato un successo
entusiasmante nel numeroso pubblico presente al
Dal Verme, pubblico che ha applaudito a lungo un
brano che si spera possa trovare altre
esecuzioni in Italia nei prossimi anni, cosa non
scontata per gli autori contemporanei. Di ottima
qualità sia il Beethoven introduttivo
dell'Ouverture che la celebre Settima
Sinfonia, resa ancor più interessante
dall'eccellente espressività dello scultoreo
Allegretto. Questa sera alle ore 20.00 la
prima ufficiale e sabato alle 17.00 la replica.
Da non perdere! con
grande precisione nelle scansioni ritmiche,
spesso una miriade di note ribattute volte a
sostenere la tensione drammatica accentuata.
L'esemplare resa complessiva del solista,
unitamente all'ottima sinergia con la direzione
di Cadario e la valida resa espressiva di ogni
sezione orchestrale, ha generato un successo
entusiasmante nel numeroso pubblico presente al
Dal Verme, pubblico che ha applaudito a lungo un
brano che si spera possa trovare altre
esecuzioni in Italia nei prossimi anni, cosa non
scontata per gli autori contemporanei. Di ottima
qualità sia il Beethoven introduttivo
dell'Ouverture che la celebre Settima
Sinfonia, resa ancor più interessante
dall'eccellente espressività dello scultoreo
Allegretto. Questa sera alle ore 20.00 la
prima ufficiale e sabato alle 17.00 la replica.
Da non perdere!
21 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Il Festival Strings
Lucerne e il violino
di Leia Zhu per la Società dei Concerti
Gli
straordinari colori della compagine strumentale
"Festival Strings Lucerne" sono emersi
nel notevole impaginato scelto per il concerto
organizzato dalla "Società dei Concerti".
L'Orchestra d'archi - ieri sera di sedici
strumentisti - è stata fondata nel 1956, ed è
tra le migliori formazioni di livello
internazionale. Maestro
 concertatore
dal 2012 è Daniel Dodds, dal 2000 anche primo
violino. Il brano introduttivo, la
Novelletten n.1 in fa maggiore op.53 per archi,
una rarità di N.W. Gade,
ha introdotto la serata rivelando da subito lo
spessore della compagine orchestrale. La parte
centrale della serata ha riservato un ospite
d'eccezione quale la giovane violinista Leia
Zhu. Non ancora diciottenne, era stata già
ospite della Società concertistica nel 2018.
Impegnata prima nel Concerto per violino e
orchestra d'archi in re minore di
Mendelssohn e poi nella celebre La campanella-
dal Concerto n.2 di Paganini-,
la britannica Leia Zhu, coadiuvata in maniera
eccellente dai sedici archi, ha rivelato concertatore
dal 2012 è Daniel Dodds, dal 2000 anche primo
violino. Il brano introduttivo, la
Novelletten n.1 in fa maggiore op.53 per archi,
una rarità di N.W. Gade,
ha introdotto la serata rivelando da subito lo
spessore della compagine orchestrale. La parte
centrale della serata ha riservato un ospite
d'eccezione quale la giovane violinista Leia
Zhu. Non ancora diciottenne, era stata già
ospite della Società concertistica nel 2018.
Impegnata prima nel Concerto per violino e
orchestra d'archi in re minore di
Mendelssohn e poi nella celebre La campanella-
dal Concerto n.2 di Paganini-,
la britannica Leia Zhu, coadiuvata in maniera
eccellente dai sedici archi, ha rivelato
 una
musicalità di primo livello, esternando una
leggerezza di tocco straordinaria, unitamente ad
incisività e cantabilità. L'ottima esecuzione
del concerto mendelssohniano ha visto
successivamente un'eccellente resa solistica
nella brillante La campanella, dove la
chiarezza del fraseggio e la solida struttura
complessiva dei tre movimenti, hanno ritrovato
l'elemento virtuosistico con una resa
d'apparente facilità d'esecuzione. Le
intonazioni perfette della Zhu, anche nei più
impervi sopracuti, realizzati con evidente
nitore espressivo e la bellezza delle timbriche
hanno portato ad un tripudio di applausi.
Eccellente il bis solistico concesso, con il
celebre Capriccio n.24 di Paganini,
quello di maggiore lunghezza per via delle
numerose variazioni sul noto tema iniziale.
Ancora una
musicalità di primo livello, esternando una
leggerezza di tocco straordinaria, unitamente ad
incisività e cantabilità. L'ottima esecuzione
del concerto mendelssohniano ha visto
successivamente un'eccellente resa solistica
nella brillante La campanella, dove la
chiarezza del fraseggio e la solida struttura
complessiva dei tre movimenti, hanno ritrovato
l'elemento virtuosistico con una resa
d'apparente facilità d'esecuzione. Le
intonazioni perfette della Zhu, anche nei più
impervi sopracuti, realizzati con evidente
nitore espressivo e la bellezza delle timbriche
hanno portato ad un tripudio di applausi.
Eccellente il bis solistico concesso, con il
celebre Capriccio n.24 di Paganini,
quello di maggiore lunghezza per via delle
numerose variazioni sul noto tema iniziale.
Ancora
 applausi
sostenuti. I potenziali migliori dell'orchestra
d'archi si sono poi rivelati nell'ultimo brano
in programma. La Serenade in do maggiore op
48 di
Čajkovskij
è un gioiello compositivo
assoluto, dove l'equilibrio delle quattro ampie
parti che compongono questo capolavoro, travano
un'evidente bellezza nelle melodie di ogni
movimento, dall'Andante non troppo, allo
strepitoso Valse moderato, all'Elegia
e al Finale con il tema russo. Il
perfetto equilibrio era controllato dalla
straordinaria orchestrazione del
violinista-direttore Dodds, e la chiarezza dei
dettagli è stata di grande rilevanza estetica.
Applausi sostenuti dal pubblico presente in Sala
Verdi e un valido bis interpretato con profonda
espressività: Evening Song op.85 n.12 di
Robert Schumann nella riuscita trascrizione di
J. Svendsen. Eccellente serata! applausi
sostenuti. I potenziali migliori dell'orchestra
d'archi si sono poi rivelati nell'ultimo brano
in programma. La Serenade in do maggiore op
48 di
Čajkovskij
è un gioiello compositivo
assoluto, dove l'equilibrio delle quattro ampie
parti che compongono questo capolavoro, travano
un'evidente bellezza nelle melodie di ogni
movimento, dall'Andante non troppo, allo
strepitoso Valse moderato, all'Elegia
e al Finale con il tema russo. Il
perfetto equilibrio era controllato dalla
straordinaria orchestrazione del
violinista-direttore Dodds, e la chiarezza dei
dettagli è stata di grande rilevanza estetica.
Applausi sostenuti dal pubblico presente in Sala
Verdi e un valido bis interpretato con profonda
espressività: Evening Song op.85 n.12 di
Robert Schumann nella riuscita trascrizione di
J. Svendsen. Eccellente serata!
21 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Il pianista Axel Trolese
per "Musica con le
ali" al Museo della Scala
Ieri,
nel tardo pomeriggio, un nuovo appuntamento
musicale realizzato dall'associazione "Musica
con le ali" si è svolto nella Sala Esedra
del Museo Teatrale alla Scala. Il terzo incontro
dello splendido "Salotto Musicale" milanese, ha
visto un giovane valido interprete al pianoforte
quale Axel Trolese, ventiseienne di Genzano
(RM), che ha offerto un programma di brani
all'insegna del virtuosimo, iniziando con
J.S.Bach (1685-1750), passando per Isaac Albéniz
(1860-1909), arrivando a Maurice Ravel (1875- 1937)
e concludendo con Aleksandr Skrjabin
(1872-1915). Il Concerto Italiano BWV 971
del grande genio sassone ha rivelato la sicurezza
digitale di Trolese nell'imprimere un taglio
deciso e chiaro alle polifonie bachiane. I brani
di Albéniz, dal libro terzo di Iberia,
con i tre lavori El Albaicín, El Polo e
Lavapiés, sono di raro ascolto e di
straordinaria difficoltà esecutiva e
rappresentano una specialità del pianista che ha
già inciso in Cd tutta la serie. Le valide
esecuzioni hanno rivelato ancor più le doti
virtuosistiche di Trolese nell'esprimere con
chiarezza anche le più impervie dissonanze che
sono presenti, specie nel terzo pregnante lavoro.
Il brano successivo, più celebre del 1937)
e concludendo con Aleksandr Skrjabin
(1872-1915). Il Concerto Italiano BWV 971
del grande genio sassone ha rivelato la sicurezza
digitale di Trolese nell'imprimere un taglio
deciso e chiaro alle polifonie bachiane. I brani
di Albéniz, dal libro terzo di Iberia,
con i tre lavori El Albaicín, El Polo e
Lavapiés, sono di raro ascolto e di
straordinaria difficoltà esecutiva e
rappresentano una specialità del pianista che ha
già inciso in Cd tutta la serie. Le valide
esecuzioni hanno rivelato ancor più le doti
virtuosistiche di Trolese nell'esprimere con
chiarezza anche le più impervie dissonanze che
sono presenti, specie nel terzo pregnante lavoro.
Il brano successivo, più celebre del
 precedente
e molto eseguito nelle sale da concerto,
Gaspard de la nuit, del grande compositore
francese, è stato eseguito, senza soluzione di
continuità,
con Vers la flamme“ op. 72, opera di
straordinaria realizzazione del compositore
russo. Una scelta motivata da Trolese per
l'effettiva consonanza coloristico-timbrica
delle due importanti composizioni realizzate
nello stesso periodo storico, specie con il
conclusivo Scarbo della prima grande
opera. Ottima la discorsività complessiva dei
due lavori, ben delineati dal voluminoso
pianoforte Steinway & Sons, che ricordiamo
essere appartenuto a Liszt dal 1883 e da alcuni
anni utilizzato per i concerti del Museo
scaligero. Applausi calorosi in una Sala Esedra
colma di appassionati. Di profonda espressività
il bis concesso da Trolese, visibilmente
soddisfatto, con il primo, semplice ma profondo
brano tratto da Musica Callada del
catalano Frederic Mompou (1893-1987) e
denominato Angelico. Ancora calorosi
applausi. Il prossimo incontro per "Musica con
le ali" in Sala Esedra è per l'8 aprile con la
pianista Monica Zhang che eseguirà brani di
Beethoven, di Liszt e di Mussorgskij. Da non
perdere. precedente
e molto eseguito nelle sale da concerto,
Gaspard de la nuit, del grande compositore
francese, è stato eseguito, senza soluzione di
continuità,
con Vers la flamme“ op. 72, opera di
straordinaria realizzazione del compositore
russo. Una scelta motivata da Trolese per
l'effettiva consonanza coloristico-timbrica
delle due importanti composizioni realizzate
nello stesso periodo storico, specie con il
conclusivo Scarbo della prima grande
opera. Ottima la discorsività complessiva dei
due lavori, ben delineati dal voluminoso
pianoforte Steinway & Sons, che ricordiamo
essere appartenuto a Liszt dal 1883 e da alcuni
anni utilizzato per i concerti del Museo
scaligero. Applausi calorosi in una Sala Esedra
colma di appassionati. Di profonda espressività
il bis concesso da Trolese, visibilmente
soddisfatto, con il primo, semplice ma profondo
brano tratto da Musica Callada del
catalano Frederic Mompou (1893-1987) e
denominato Angelico. Ancora calorosi
applausi. Il prossimo incontro per "Musica con
le ali" in Sala Esedra è per l'8 aprile con la
pianista Monica Zhang che eseguirà brani di
Beethoven, di Liszt e di Mussorgskij. Da non
perdere.
20 marzo 2024 Cesare
Guzzardell a
Alessandro Deljavan
alle
Serate Musicali del Conservatorio milanese
Per la seconda volta ospite
di Serate Musicali, il pianista abruzzese
Alessandro Deljavan ha voluto impaginare un
programma tutto dedicato a Chopin. I 24 Studi,
tra Op.10 e Op.25, sono stati
anticipati da due Improvvisi, l'Op. 29
e l'Op.36, e le due serie di dodici
studi inframmezzati dall'Improvviso op.51.
È uno Chopin particolare quello del noto
pianista trentasettenne di origine
italo-persiane,
 certamente di qualità e
personale nell'estrema sintesi discorsiva che fa
sembrare i numerosi brani appartenenti ad un
unico lavoro unitario. Deljavan ha indubbiamente
le idee chiare su come rendere il suo Chopin. La
sua gestualità, spesso chiarificatrice delle sue
intenzioni, lo porta a definire le timbriche in
modo delicato, senza eccessi, con modalità
espressive molto interiorizzate e certamente di qualità e
personale nell'estrema sintesi discorsiva che fa
sembrare i numerosi brani appartenenti ad un
unico lavoro unitario. Deljavan ha indubbiamente
le idee chiare su come rendere il suo Chopin. La
sua gestualità, spesso chiarificatrice delle sue
intenzioni, lo porta a definire le timbriche in
modo delicato, senza eccessi, con modalità
espressive molto interiorizzate e
 trasparenti
nel rilevare frangenti discorsivi nei diversi
piani sonori, in un gioco di armonie prevalenti
rispetto il canto, che pur riconoscibile, è
sempre legato ad una concezione unitaria del
tessuto armonico. Momenti di straordinaria
raffinatezza sono emersi negli Improvvisi e
nella maggior parte dei celebri Studi. Il
pubblico, purtroppo non numeroso, presente in
Sala Verdi, ha assai apprezzato
l'interpretazione del noto pianista che ha
concesso come bis due splendide Mazurke,
l'Op.67 n.2 e l'Op.17 n.2 del
grande polacco, eseguite con incredibile
profondità estetica. Uno Chopin di grande
qualità quello di Alessandro Deljavan. trasparenti
nel rilevare frangenti discorsivi nei diversi
piani sonori, in un gioco di armonie prevalenti
rispetto il canto, che pur riconoscibile, è
sempre legato ad una concezione unitaria del
tessuto armonico. Momenti di straordinaria
raffinatezza sono emersi negli Improvvisi e
nella maggior parte dei celebri Studi. Il
pubblico, purtroppo non numeroso, presente in
Sala Verdi, ha assai apprezzato
l'interpretazione del noto pianista che ha
concesso come bis due splendide Mazurke,
l'Op.67 n.2 e l'Op.17 n.2 del
grande polacco, eseguite con incredibile
profondità estetica. Uno Chopin di grande
qualità quello di Alessandro Deljavan.
19 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
L’Orchestre Sorbonne
Université e
Giulia Rimonda per il Concerto op.35 di
Čajkovskij
all'Università degli Studi milanese
L’Orchestre Sorbonne Université, formata da un
centinaio di allievi ed ex allievi della
titolata Università parigina, è stata ospite,
all'Università degli Studi milanese,
dell'Orchestra Unimi per un concerto guidato dal
direttore argentino Nicolás Agulló. Agulló, da
alcuni anni dirige il COSU ovvero il Chœur
& Orchestre -
 Sorbonne
Université.
L'impaginato comprendeva
due importanti lavori, il primo, tra i più
popolari internazionalmente, era il Concerto
per violino in Re maggiore op. 35 di
Ciaikovskij, il secondo, meno frequentato ma
estremamente importante, la Sinfonia n. 7 in
Re minore op.70 di Antonín Dvořàk.
Protagonista del concerto del grande compositore
russo è stata la violinista Giulia Rimonda,
formatasi nell'ambiente musicale della Camerata
Ducale vercellese di Guido Rimonda e con
specializzazioni con importanti violinisti del
calibro di Shlomo Mintz, Pavel Berman e ancora
altri. Il Concerto op.35 di
Čaikovskij, composto tra il 1878 e il 1881,
inizialmente non ottenne il successo che
meritava, oggi è
invece quello tra i più eseguiti dai virtuosi di
fama mondiale. Presenta un primo movimento,
Allegro moderato, particolarmente corposo,
sviluppato, ricco di melodie e che sempre al
termine dell'esecuzione, Sorbonne
Université.
L'impaginato comprendeva
due importanti lavori, il primo, tra i più
popolari internazionalmente, era il Concerto
per violino in Re maggiore op. 35 di
Ciaikovskij, il secondo, meno frequentato ma
estremamente importante, la Sinfonia n. 7 in
Re minore op.70 di Antonín Dvořàk.
Protagonista del concerto del grande compositore
russo è stata la violinista Giulia Rimonda,
formatasi nell'ambiente musicale della Camerata
Ducale vercellese di Guido Rimonda e con
specializzazioni con importanti violinisti del
calibro di Shlomo Mintz, Pavel Berman e ancora
altri. Il Concerto op.35 di
Čaikovskij, composto tra il 1878 e il 1881,
inizialmente non ottenne il successo che
meritava, oggi è
invece quello tra i più eseguiti dai virtuosi di
fama mondiale. Presenta un primo movimento,
Allegro moderato, particolarmente corposo,
sviluppato, ricco di melodie e che sempre al
termine dell'esecuzione,
 strappa
gli applausi del pubblico, come è avvenuto anche
ieri. Il movimento centrale, Canzonetta.
Andante, di soave espressività, è
direttamente collegato all'Allegro
vivacissimo, un finale che mostra ancora le
qualità virtuosistiche di ogni interprete. Giulia
Rimonda, coadiuvata da un'eccellente compagine
orchestrale formata da giovani universitari,
quasi tutti studenti del Conservatorio parigino,
ha elargito con nitore espressivo, splendido
vibrato e incisività, ogni dettaglio del celebre
capolavoro, rivelando una comprensione totale
dell'intenso sfaccettato brano in una
convincente visione d'insieme. Eccellente la
direzione di Nicolás Agulló, attento ai rapporti
tra componente orchestrale e volumetrie del
solista. La Rimonda ha poi concesso un ottimo
bis bachiano, l'Allemande dalla
Partita n.2 per violino solo, eseguito con
maestria strappa
gli applausi del pubblico, come è avvenuto anche
ieri. Il movimento centrale, Canzonetta.
Andante, di soave espressività, è
direttamente collegato all'Allegro
vivacissimo, un finale che mostra ancora le
qualità virtuosistiche di ogni interprete. Giulia
Rimonda, coadiuvata da un'eccellente compagine
orchestrale formata da giovani universitari,
quasi tutti studenti del Conservatorio parigino,
ha elargito con nitore espressivo, splendido
vibrato e incisività, ogni dettaglio del celebre
capolavoro, rivelando una comprensione totale
dell'intenso sfaccettato brano in una
convincente visione d'insieme. Eccellente la
direzione di Nicolás Agulló, attento ai rapporti
tra componente orchestrale e volumetrie del
solista. La Rimonda ha poi concesso un ottimo
bis bachiano, l'Allemande dalla
Partita n.2 per violino solo, eseguito con
maestria
 nella
sua profonda espressività. Applausi calorosi
nell'Aula Magna universitaria al completo. Di
rilevante spessore l'interpretazione della
successiva Sinfonia n.7 del composiore
ceco. Lavoro del 1885, è tra le più interessanti
costruzioni architettonico-musicali di Dvořák,
anche se meno eseguito e meno popolare della
celebre Sinfonia n.9 "Dal nuovo mondo". La
complessità dei quattro movimenti, con il noto e
più orecchiabile Scherzo vivace, terzo
movimento, è stata affrontata con abilità da
ogni sezione orchestrale e il direttore
argentino ha trovato, mediante il suo gesto
discreto e producente, una restituzione ottimale.
Applausi calorosi e come bis il finale dello
Scherzo. Bravissimi! nella
sua profonda espressività. Applausi calorosi
nell'Aula Magna universitaria al completo. Di
rilevante spessore l'interpretazione della
successiva Sinfonia n.7 del composiore
ceco. Lavoro del 1885, è tra le più interessanti
costruzioni architettonico-musicali di Dvořák,
anche se meno eseguito e meno popolare della
celebre Sinfonia n.9 "Dal nuovo mondo". La
complessità dei quattro movimenti, con il noto e
più orecchiabile Scherzo vivace, terzo
movimento, è stata affrontata con abilità da
ogni sezione orchestrale e il direttore
argentino ha trovato, mediante il suo gesto
discreto e producente, una restituzione ottimale.
Applausi calorosi e come bis il finale dello
Scherzo. Bravissimi!
18 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Eleonora e Beatrice
Dallagnese a Palazzo Marino per i Ritratti
Musicali
Avevamo ascoltato le sorelle
Dallagnese recentemente nella Sala Esedra
del Museo Teatrale alla Scala e questa mattina
non ci siamo fatti sfuggire un
altro loro
concerto, in un luogo altrettanto prestigioso
quale Sala Alessi di Palazzo Marino.
L'iniziativa era inserita nella rassegna "
Ritratti Musicali" abbinata alla splendida
mostra di Giovan Battista
 Moroni ancora in corso
nelle vicine Gallerie d'Italia. Le ventitreenni
sorelle Eleonora e Beatrice hanno ancora una
volta dimostrato le loro straordinarie qualità
musicali in un programma per metà variato
rispetto la scorsa volta. I Six Morceaux
op.11 di Sergej Rachmaninov, opera giovanile
del russo per pianoforte a quattro mani
ascoltata al Museo scaligero, è stata anticipata
da uno Schubert doc per pianoforte a
quattro mani, con due brani celebri quali la
Fantasia in fa minore D 940 e
Lebensstürme, Allegro in la minore D 947. La
concordanza delle Dallagnese Moroni ancora in corso
nelle vicine Gallerie d'Italia. Le ventitreenni
sorelle Eleonora e Beatrice hanno ancora una
volta dimostrato le loro straordinarie qualità
musicali in un programma per metà variato
rispetto la scorsa volta. I Six Morceaux
op.11 di Sergej Rachmaninov, opera giovanile
del russo per pianoforte a quattro mani
ascoltata al Museo scaligero, è stata anticipata
da uno Schubert doc per pianoforte a
quattro mani, con due brani celebri quali la
Fantasia in fa minore D 940 e
Lebensstürme, Allegro in la minore D 947. La
concordanza delle Dallagnese
 nell'esprimere in
maniera unitaria i due maturi lavori del grande
viennese si è rivelata dalle prime note. La resa
espressiva, attraverso variazioni dinamiche
sottili, incisività di colore nei giusti
frangenti, e leggerezza discorsiva molto
viennese, hanno definito un'interpretazione di
alto livello per entrambi i lavori. Notevole,
forse ancor più del primo ascolto scaligero, i
bellissimi Morceaux del grande russo, e
di ottima resa discorsiva ed espressiva il bis
concesso dal primo movimento di Petruska
di Igor Stravinskij. Applausi calorosissimi
nella Sala Alessi stracolma di appassionati. Una
manifestazione complessiva di grande successo! nell'esprimere in
maniera unitaria i due maturi lavori del grande
viennese si è rivelata dalle prime note. La resa
espressiva, attraverso variazioni dinamiche
sottili, incisività di colore nei giusti
frangenti, e leggerezza discorsiva molto
viennese, hanno definito un'interpretazione di
alto livello per entrambi i lavori. Notevole,
forse ancor più del primo ascolto scaligero, i
bellissimi Morceaux del grande russo, e
di ottima resa discorsiva ed espressiva il bis
concesso dal primo movimento di Petruska
di Igor Stravinskij. Applausi calorosissimi
nella Sala Alessi stracolma di appassionati. Una
manifestazione complessiva di grande successo!
17 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
VENTO
FRANCESE ALL’AUDITORIUM DEDALO DI NOVARA
Ieri sera, sabato 16 marzo,
l’Auditorium della Scuola di musica Dedalo di
Novara ha ospitato un concerto dedicato a
composizioni per quintetto di fiati (flauto,
oboe, clarinetto, fagotto, corno) soli o con
pianoforte, tutte di autori francesi della prima
metà del ‘900 e ricordiamo che in francese i
nostri strumenti a fiato sono ‘Instruments à
Vent’, da cui il titolo della serata. L’organico
strumentale era formato dalla sezione fiati
dell’Ensemble Iri da Iri, in residence a Novara,
presso la Scuola Dedalo. ‘Iri da Iri’ è
citazione colta, dantesca per la precisione,
dall’ultimo canto della Divina Commedia, quello
in cui, al termine del suo viaggio ultraterreno,
Dante ha la visione del divino : ‘Iri, è forma
antica per ‘iride’, l’arcobaleno e allude alla
bellezza infinita della musica, arcobaleno
straordinario di suoni, emozioni, sentimenti,
che come i colori
 dell’arcobaleno
si dispongono in una magica, luminosa
architettura di echi, di corrispondenze
misteriose e sublimi, come la visione del divino
nel poema cosmico di Dante. I cinque
dell’ensemble erano Alessandra Altini (flauto e
ottavino), Francesca Alleva (oboe), Marco Sorge
(clarinetto), Gianmarco Canato (fagotto), Elisa
Giovangrandi (corno). Si tratta di giovani
intorno ai trent’anni, salvo il più anziano
Sorge, che hanno compiuto una ricca e
qualificata esperienza di studi musicali in
importanti istituti in Italia e in Europa, con
una già ampia attività concertistica di buon
livello sia in ambito orchestrale ( alcuni di
loro hanno suonato in orchestre come La
Filarmonica della Scala, la Filarmonica di S.
Cecilia, L’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai) , sia in ambito cameristico o
solistico. Da segnalare il curioso quartetto di
soli ottavini, fondato da Alessandra Altini,
Alt®e Frequenze, uno dei più originali quartetti,
crediamo, attualmente in Italia. Al pianoforte
sedeva Elena Brunello, il cui curriculum di
concorsi ha il suo momento culminante nel
secondo premio ottenuto nel 2012
all’International Piano Competition di S.
Pietroburgo, e anche le sue esibizioni
solistiche, cameristiche e in orchestra sono
decisamente significative. Il primo soffio di
vento francese è stato il Divertissement op.6
per pianoforte e quintetto di fiati (1906) di
Albert Roussel (1869-1937). Figura piuttosto
defilata nel vivacissimo panorama della musica
francese d’inizio ‘900, Roussel ne è in realtà
uno degli esponenti più interessanti e originali
e questo breve pezzo ne è una testimonianza,
come sintesi molto personale, di neoclassicismo,
fauvismo alla Stravinsky, ma con qualche anno
d’anticipo, e ‘impressionismo’ debussyano’.
L’ensemble Iri da Iri ha offerto, di questo
gioiellino musicale, un’interpretazione di alta
qualità, mettendone in evidenza il ritmo agile e
brillante, soprattutto nell’Animé iniziale, e
toccando il vertice della suggestione musicale
nelle sonorità evanescenti del Lento dell’arcobaleno
si dispongono in una magica, luminosa
architettura di echi, di corrispondenze
misteriose e sublimi, come la visione del divino
nel poema cosmico di Dante. I cinque
dell’ensemble erano Alessandra Altini (flauto e
ottavino), Francesca Alleva (oboe), Marco Sorge
(clarinetto), Gianmarco Canato (fagotto), Elisa
Giovangrandi (corno). Si tratta di giovani
intorno ai trent’anni, salvo il più anziano
Sorge, che hanno compiuto una ricca e
qualificata esperienza di studi musicali in
importanti istituti in Italia e in Europa, con
una già ampia attività concertistica di buon
livello sia in ambito orchestrale ( alcuni di
loro hanno suonato in orchestre come La
Filarmonica della Scala, la Filarmonica di S.
Cecilia, L’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai) , sia in ambito cameristico o
solistico. Da segnalare il curioso quartetto di
soli ottavini, fondato da Alessandra Altini,
Alt®e Frequenze, uno dei più originali quartetti,
crediamo, attualmente in Italia. Al pianoforte
sedeva Elena Brunello, il cui curriculum di
concorsi ha il suo momento culminante nel
secondo premio ottenuto nel 2012
all’International Piano Competition di S.
Pietroburgo, e anche le sue esibizioni
solistiche, cameristiche e in orchestra sono
decisamente significative. Il primo soffio di
vento francese è stato il Divertissement op.6
per pianoforte e quintetto di fiati (1906) di
Albert Roussel (1869-1937). Figura piuttosto
defilata nel vivacissimo panorama della musica
francese d’inizio ‘900, Roussel ne è in realtà
uno degli esponenti più interessanti e originali
e questo breve pezzo ne è una testimonianza,
come sintesi molto personale, di neoclassicismo,
fauvismo alla Stravinsky, ma con qualche anno
d’anticipo, e ‘impressionismo’ debussyano’.
L’ensemble Iri da Iri ha offerto, di questo
gioiellino musicale, un’interpretazione di alta
qualità, mettendone in evidenza il ritmo agile e
brillante, soprattutto nell’Animé iniziale, e
toccando il vertice della suggestione musicale
nelle sonorità evanescenti del Lento
 centrale
e nel lunare Animando finale. Finissima la cura
dei dettagli timbrici, essenziale per una
partitura di Roussel, in particolare del terzo
tempo, ove i limpidi passaggi del pianoforte nei
registri acuti della tastiera (ottima la
performance di Brunello) si intrecciano con il
fraseggio ampio , ma rarefatto e sospeso ai
limiti di un incantato silenzio, dei fiati, trai
quali il flauto e il corno conferiscono un
colore ‘in sordina’ particolarmente efficace:
davvero un arcobaleno sonoro di potente
suggestione, che ha strappato applausi
meritatissimi da parte del pubblico. La seconda
‘ventata’ è arrivata con un notissimo pezzo di
Ravel, di poco posteriore al Divertissement di
Roussel, ‘Ma mère l’oye’ (1908). È noto che il
brano, composto originariamente per pianoforte a
quattro mani, fu poi trascritto per orchestra
dallo stesso Ravel. Ieri ne abbiamo ascoltato
una versione abbastanza celebre, per quintetto
di fiati, opera di Joachim Linckelmann. Anche
questa seconda composizione ha visto i fiati di
Iri da Iri raggiungere livelli intrepretativi di
notevole valore, con un panneggio sonoro
ottimamente curato e smagliante, sia nella
raffinatezza timbrica e nella gestione delle
dinamiche, sia, più in generale, nell’esprimere
quell’incantevole atmosfera fiabesca e
sottilmente ironica a un tempo che è la
peculiarità di questo capolavoro di Ravel. I
momenti più alti di questa esecuzione sono stati
a nostro parere il primo movimento, ‘La Pavane
de la Belle au bois dormant’, dove il lungo tema
è stato suonato con una dolcezza e una
malinconia struggente eppure alleggerita dalle
oculate e intelligenti dinamiche e dalla
trasparenza del suono dei cinque fiati, compresi
quelli gravi (corno e fagotto) e l’ultimo, ‘Le
jardin féerique’, in cui il graduale trapasso
dalla sommessa sonorità iniziale all’esplosione
timbrica conclusiva è stato condotto con estrema
precisione centrale
e nel lunare Animando finale. Finissima la cura
dei dettagli timbrici, essenziale per una
partitura di Roussel, in particolare del terzo
tempo, ove i limpidi passaggi del pianoforte nei
registri acuti della tastiera (ottima la
performance di Brunello) si intrecciano con il
fraseggio ampio , ma rarefatto e sospeso ai
limiti di un incantato silenzio, dei fiati, trai
quali il flauto e il corno conferiscono un
colore ‘in sordina’ particolarmente efficace:
davvero un arcobaleno sonoro di potente
suggestione, che ha strappato applausi
meritatissimi da parte del pubblico. La seconda
‘ventata’ è arrivata con un notissimo pezzo di
Ravel, di poco posteriore al Divertissement di
Roussel, ‘Ma mère l’oye’ (1908). È noto che il
brano, composto originariamente per pianoforte a
quattro mani, fu poi trascritto per orchestra
dallo stesso Ravel. Ieri ne abbiamo ascoltato
una versione abbastanza celebre, per quintetto
di fiati, opera di Joachim Linckelmann. Anche
questa seconda composizione ha visto i fiati di
Iri da Iri raggiungere livelli intrepretativi di
notevole valore, con un panneggio sonoro
ottimamente curato e smagliante, sia nella
raffinatezza timbrica e nella gestione delle
dinamiche, sia, più in generale, nell’esprimere
quell’incantevole atmosfera fiabesca e
sottilmente ironica a un tempo che è la
peculiarità di questo capolavoro di Ravel. I
momenti più alti di questa esecuzione sono stati
a nostro parere il primo movimento, ‘La Pavane
de la Belle au bois dormant’, dove il lungo tema
è stato suonato con una dolcezza e una
malinconia struggente eppure alleggerita dalle
oculate e intelligenti dinamiche e dalla
trasparenza del suono dei cinque fiati, compresi
quelli gravi (corno e fagotto) e l’ultimo, ‘Le
jardin féerique’, in cui il graduale trapasso
dalla sommessa sonorità iniziale all’esplosione
timbrica conclusiva è stato condotto con estrema
precisione
 e
incisivo disegno dei vari impasti timbrici di
volta in volta selezionati dalla partitura.
Dobbiamo osservare, en passant, che, non certo
per colpa dei bravissimi strumentisti, questa
trascrizione per soli fiati è inadeguata a
rendere al meglio una delle parti più belle de
Ma mère l’oye, il terzo tempo, Laideronnette,
nella sua meravigliosa evocazione dei gamelan
orientali, per la quale i soli fiati non sono
sufficienti nel loro peculiare apporto timbrico,
sicché va inevitabilmente perduto uno dei
momenti musicalmente più suggestivi dell’intera
composizione. L’impaginato proponeva quindi un
breve brano di Jacques Ibert (1890-1962), i
Trois pièces brèves per quintetto di fiati.
(1930). Caratteri dominanti dello stile di Ibert
sono la limpida chiarezza delle strutture e la
sapienza costruttiva: il vario gioco dei timbri
appare subordinato allo scopo di dare rilievo
alla precisione delle forme. Questo aspetto
caratterizzante della musica di Ibert è emerso
con evidenza dall’interpretazione del quintetto
Iri da Iri, che ha sfoggiato un’eleganza e
trasparenza di suono ottimamente calibrate, pur
non rinunciando ai momenti più brillanti, in
particolare il vivace ritmo danzante della
seconda sezione dell’Allegro iniziale. Da
ricordare il duetto, che occupa gran parte
dell’Andante centrale, tra flauto e clarinetto,
per la morbidezza del clarinetto e la fulgida
chiarezza di suono, specie nel registro alto,
del flauto. Il concerto si chiudeva con un pezzo,
anch’esso celebre, di Francois Poulenc, il
Sextet per pianoforte e quintetto di fiati FP
100 (1932-1939). È nota la predilezione che
Poulenc dimostrò sempre per gli strumenti a
fiato, nella cui variegata sonorità trovò una
‘voce’ ideale per esprimere il suo mondo
musicale, sempre mutevole, instabile e
contraddittorio. Di questo mondo musicale il
Sextett FP 100 si può ritenere quasi un
manifesto, ancora una volta eseguito e
interpretato molto bene dall’Ensemble Iri da Iri,
a proprio agio sia con le sonorità delle parti
più ‘motoristiche’ e trascinanti del pezzo, come
il tema principale dell’Allegro vivace iniziale,
un impasto di neoclassicismo stravinskyano nei
suoi momenti più spumeggianti e di musica
jazzistica, sia con quelle dei momenti di più
ripiegata e quasi dolorosa cantabilità, come,
sempre nel primo tempo, la sezione centrale. Ma
un po’ ovunque c’è in questo pezzo, come in
moltissimi altri lavori di Poulenc, questo
strano contrapporsi di euforico e gioioso
abbandono a ritmi vorticosi, di sapore ora
burlesco, ora aggressivo, e di zone di andamento
melodioso-cantabile: il che significa continuo
mutare di ritmi, timbri, dinamiche, tonalità. I
giovani di Iri da Iri dominano questo
incandescente e complesso materiale musicale con
assoluta padronanza e con fine sensibilità. Per
i singoli apporti ci pare giusto qui citare la
bellissima cadenza del fagotto, con una voce
cupa e senza speranza, che apre la sezione
centrale del primo movimento, e il subito
successivo intervento del pianoforte, che
disegna con fraseggio delicato e di notevole
intensità espressiva, la dolorosa melodia
cantabile della sezione centrale. Oppure la
dolcezza intrisa di indefinita tristezza con cui
l’oboe suona il suo tema nel Divertissement
Andantino centrale, un tema che è una citazione
dal Mozart della sonata per pianoforte KV 454 in
Do maggiore. Bel concerto, applauditissimo, con
un programma intelligente e raffinato, che
promette bene per questa nuova stagione di
musica da camera della Dedalus, che va sempre
più affermandosi come un altro polo importante
della vita musicale novarese .Gli applausi
scroscianti di un pubblico che ha riempito ogni
posto dell’Auditorium non hanno ottenuto alcun
petit cadeau: il concerto è finito senza bis, ma
questo nulla toglie, ovviamente,
all’apprezzamento per una prestazione davvero di
alta qualità. e
incisivo disegno dei vari impasti timbrici di
volta in volta selezionati dalla partitura.
Dobbiamo osservare, en passant, che, non certo
per colpa dei bravissimi strumentisti, questa
trascrizione per soli fiati è inadeguata a
rendere al meglio una delle parti più belle de
Ma mère l’oye, il terzo tempo, Laideronnette,
nella sua meravigliosa evocazione dei gamelan
orientali, per la quale i soli fiati non sono
sufficienti nel loro peculiare apporto timbrico,
sicché va inevitabilmente perduto uno dei
momenti musicalmente più suggestivi dell’intera
composizione. L’impaginato proponeva quindi un
breve brano di Jacques Ibert (1890-1962), i
Trois pièces brèves per quintetto di fiati.
(1930). Caratteri dominanti dello stile di Ibert
sono la limpida chiarezza delle strutture e la
sapienza costruttiva: il vario gioco dei timbri
appare subordinato allo scopo di dare rilievo
alla precisione delle forme. Questo aspetto
caratterizzante della musica di Ibert è emerso
con evidenza dall’interpretazione del quintetto
Iri da Iri, che ha sfoggiato un’eleganza e
trasparenza di suono ottimamente calibrate, pur
non rinunciando ai momenti più brillanti, in
particolare il vivace ritmo danzante della
seconda sezione dell’Allegro iniziale. Da
ricordare il duetto, che occupa gran parte
dell’Andante centrale, tra flauto e clarinetto,
per la morbidezza del clarinetto e la fulgida
chiarezza di suono, specie nel registro alto,
del flauto. Il concerto si chiudeva con un pezzo,
anch’esso celebre, di Francois Poulenc, il
Sextet per pianoforte e quintetto di fiati FP
100 (1932-1939). È nota la predilezione che
Poulenc dimostrò sempre per gli strumenti a
fiato, nella cui variegata sonorità trovò una
‘voce’ ideale per esprimere il suo mondo
musicale, sempre mutevole, instabile e
contraddittorio. Di questo mondo musicale il
Sextett FP 100 si può ritenere quasi un
manifesto, ancora una volta eseguito e
interpretato molto bene dall’Ensemble Iri da Iri,
a proprio agio sia con le sonorità delle parti
più ‘motoristiche’ e trascinanti del pezzo, come
il tema principale dell’Allegro vivace iniziale,
un impasto di neoclassicismo stravinskyano nei
suoi momenti più spumeggianti e di musica
jazzistica, sia con quelle dei momenti di più
ripiegata e quasi dolorosa cantabilità, come,
sempre nel primo tempo, la sezione centrale. Ma
un po’ ovunque c’è in questo pezzo, come in
moltissimi altri lavori di Poulenc, questo
strano contrapporsi di euforico e gioioso
abbandono a ritmi vorticosi, di sapore ora
burlesco, ora aggressivo, e di zone di andamento
melodioso-cantabile: il che significa continuo
mutare di ritmi, timbri, dinamiche, tonalità. I
giovani di Iri da Iri dominano questo
incandescente e complesso materiale musicale con
assoluta padronanza e con fine sensibilità. Per
i singoli apporti ci pare giusto qui citare la
bellissima cadenza del fagotto, con una voce
cupa e senza speranza, che apre la sezione
centrale del primo movimento, e il subito
successivo intervento del pianoforte, che
disegna con fraseggio delicato e di notevole
intensità espressiva, la dolorosa melodia
cantabile della sezione centrale. Oppure la
dolcezza intrisa di indefinita tristezza con cui
l’oboe suona il suo tema nel Divertissement
Andantino centrale, un tema che è una citazione
dal Mozart della sonata per pianoforte KV 454 in
Do maggiore. Bel concerto, applauditissimo, con
un programma intelligente e raffinato, che
promette bene per questa nuova stagione di
musica da camera della Dedalus, che va sempre
più affermandosi come un altro polo importante
della vita musicale novarese .Gli applausi
scroscianti di un pubblico che ha riempito ogni
posto dell’Auditorium non hanno ottenuto alcun
petit cadeau: il concerto è finito senza bis, ma
questo nulla toglie, ovviamente,
all’apprezzamento per una prestazione davvero di
alta qualità.
17 marzo 2024 Bruno Busca
PER I
SABATI DEL CONSERVATORIO DI NOVARA IL PIANOFORTE
A QUATTRO MANI DI MOZART CON IL DUO G.
BELLORINI-G. CUCCO
I pianisti Giuliano Bellorini
e Giuliano Cucco hanno formato un duo che, da
circa vent’anni, ha avviato una nutrita attività
concertistica in Italia e non solo, nel cui
repertorio occupano un posto di primo piano le
composizioni per pianoforte a quattro mani di W.
A. Mozart, che i due Maestri hanno anche inciso
in vari CD. Bellorini, all’attività
concertistica, in coppia con Cucco o come
solista o in formazioni cameristiche e con
orchestra, affianca anche l’attività di
compositore, di raffinato musicologo
 e
di insegnante, presso il Conservatorio G. Verdi
di Milano. La fama che gli deriva da tali
molteplici attività è rafforzata dalle sue
frequenti partecipazioni a trasmissioni
radiofoniche di argomento musicale di Rai radio
tre. Giuliano Cucco è pianista affermatosi in
vari importanti concorsi italiani e
internazionali e con un’ampia attività di
concertista; attualmente insegna presso il
Conservatorio Cantelli di Novara. Bellorini e
Cucco, i protagonisti del concerto ascoltato
ieri pomeriggio, sabato 15/03, presso
l’Auditorium Olivieri del Cantelli, hanno
presentato un programma monograficamente
impaginato su due sonate per pianoforte a
quattro mani e una sonata per due pianoforti di
Mozart. La serie è stata inaugurata dalla Sonata
a quattro mani in Si bemolle maggiore Kv 358,
composta da un Mozart ancora diciottenne nel
1774, ad uso personale suo e della sorella
Nannerl, con la quale allora Wolfgang formava un
duo pianistico ‘fisso’, in occasione di
ricevimenti e serate musicali. L’interpretazione
di Ceccherini e Cucco ci pare abbia puntato su
due obiettivi: in primo luogo l’abile
sfruttamento della tecnica a quattro mani che
caratterizza questa sonata, sottolineandone il
carattere ‘dialogico’ che, superando il più o
meno rigido alternarsi o sottomettersi di un
pianista all’altro, proprio delle sonate a
quattro mani dell’epoca, affiora qua e là e
s’impone particolarmente nell’Allegretto
grazioso finale, in cui gli elementi motivici
che compongono il tema principale passano da un
pianista all’altro, con sorprendenti effetti
timbrici. La seconda caratteristica
dell’interpretazione di Bellorini e Cucco è
quella di portare in primo piano quello che è
forse il carattere più originale di questa
sonata, in cui lo stile galante alla Johann
Christian Bach, allora dominante, con le sue
frasi bilanciate ed equilibratamente melodiche,
i suoi eleganti ornamenti, è spezzato nei due
tempi esterni da un tono assertivo e da ritmi
puntati che Bellorini e e
di insegnante, presso il Conservatorio G. Verdi
di Milano. La fama che gli deriva da tali
molteplici attività è rafforzata dalle sue
frequenti partecipazioni a trasmissioni
radiofoniche di argomento musicale di Rai radio
tre. Giuliano Cucco è pianista affermatosi in
vari importanti concorsi italiani e
internazionali e con un’ampia attività di
concertista; attualmente insegna presso il
Conservatorio Cantelli di Novara. Bellorini e
Cucco, i protagonisti del concerto ascoltato
ieri pomeriggio, sabato 15/03, presso
l’Auditorium Olivieri del Cantelli, hanno
presentato un programma monograficamente
impaginato su due sonate per pianoforte a
quattro mani e una sonata per due pianoforti di
Mozart. La serie è stata inaugurata dalla Sonata
a quattro mani in Si bemolle maggiore Kv 358,
composta da un Mozart ancora diciottenne nel
1774, ad uso personale suo e della sorella
Nannerl, con la quale allora Wolfgang formava un
duo pianistico ‘fisso’, in occasione di
ricevimenti e serate musicali. L’interpretazione
di Ceccherini e Cucco ci pare abbia puntato su
due obiettivi: in primo luogo l’abile
sfruttamento della tecnica a quattro mani che
caratterizza questa sonata, sottolineandone il
carattere ‘dialogico’ che, superando il più o
meno rigido alternarsi o sottomettersi di un
pianista all’altro, proprio delle sonate a
quattro mani dell’epoca, affiora qua e là e
s’impone particolarmente nell’Allegretto
grazioso finale, in cui gli elementi motivici
che compongono il tema principale passano da un
pianista all’altro, con sorprendenti effetti
timbrici. La seconda caratteristica
dell’interpretazione di Bellorini e Cucco è
quella di portare in primo piano quello che è
forse il carattere più originale di questa
sonata, in cui lo stile galante alla Johann
Christian Bach, allora dominante, con le sue
frasi bilanciate ed equilibratamente melodiche,
i suoi eleganti ornamenti, è spezzato nei due
tempi esterni da un tono assertivo e da ritmi
puntati che Bellorini e
 Cucco
interpretano con la dovuta energia, e ancora una
volta, con una notevole finezza di giochi
timbrici. Fin da questa prima esecuzione emerge
la grande omogeneità e unità che lega i due
interpreti, essenziale per una buona riuscita di
un pezzo a quattro mani sul pianoforte. Molto
bello, nella sua pulizia e trasparenza, anche il
tocco, dei due pianisti, sia sui registri
medio-alti (Bellorini), sia su quelli bassi (Cucco)
A seguire, il programma proponeva all’ascolto la
sonata per quattro mani in Fa maggiore Kv 497
(1786). Opera di un Mozart ormai nel pieno della
sua maturità, è considerata il capolavoro
mozartiano nel genere: essa porta a compimento
quel carattere ‘dialogico’ della sonata a
quattro mani che nella ‘salisburghese’ Kv 358
era appena abbozzato. L’interpretazione di
Bellorini e Cucco, fondendo in una perfetta
unità d’intenti l’apporto di due diversi
pianisti, crea un fraseggio di squisita fattura,
molto efficace nei contrasti dinamici e timbrici,
anche plasticamente evidenziati dagli incroci,
talora quasi stupefacenti per il perfetto
sincronismo nei movimenti dei due interpreti. La
tecnica superba di Bellorini e Cucco ci
restituisce una Kv 497 che ormai non ha più
nulla dello stile galante degli esordi di Amadè,
come subito si annuncia nel colore livido delle
prime battute dell’Adagio introduttivo, e nella
complessità contrappuntistica o nei mossi, quasi
drammatici contrasti dello sviluppo dell’Allegro
iniziale, eseguito conferendo nitida trasparenza
alle linee contrappuntistiche, o ancora, facendo
affiorare, in certe sfumature dei momenti
melodicamente più intensi dell’Andante centrale,
precorrimenti schubertiani, intendiamo dello
Schubert del tardo stile delle ultime sonate per
pianoforte. A questa ottima esecuzione seguiva
infine, a chiudere il concerto una sonata per
due pianoforti la Kv 448 (1781) in Re maggiore:
la coppia Bellorini-Cucco diventa propriamente
un duo, termine che, a voler fare un po’ i
pedanti, è precisamente riservato ai due
pianisti che suonano su due pianoforti distinti.
I due pianoforti, rispetto al pianoforte a
quattro mani, ovviamente, aumentano assai il
volume del suono e quindi offrono possibilità di
sviluppo dialogico e di arricchimento della
tavolozza timbrica. Dal punto di viste dello
stile, dire che il tema principale dell’Allegro
con spirito iniziale è tratto di peso da una
composizione di J.C. Bach è già indicare una
precisa scelta da parte di Mozart nella
direzione dello stile galante, che in effetti
lascia la sua impronta in tutta la sonata. In
effetti la Kv 448 si può intendere come un
estremo omaggio di Mozart a un musicista al
quale guardò sempre con stima e ammirazione, Cucco
interpretano con la dovuta energia, e ancora una
volta, con una notevole finezza di giochi
timbrici. Fin da questa prima esecuzione emerge
la grande omogeneità e unità che lega i due
interpreti, essenziale per una buona riuscita di
un pezzo a quattro mani sul pianoforte. Molto
bello, nella sua pulizia e trasparenza, anche il
tocco, dei due pianisti, sia sui registri
medio-alti (Bellorini), sia su quelli bassi (Cucco)
A seguire, il programma proponeva all’ascolto la
sonata per quattro mani in Fa maggiore Kv 497
(1786). Opera di un Mozart ormai nel pieno della
sua maturità, è considerata il capolavoro
mozartiano nel genere: essa porta a compimento
quel carattere ‘dialogico’ della sonata a
quattro mani che nella ‘salisburghese’ Kv 358
era appena abbozzato. L’interpretazione di
Bellorini e Cucco, fondendo in una perfetta
unità d’intenti l’apporto di due diversi
pianisti, crea un fraseggio di squisita fattura,
molto efficace nei contrasti dinamici e timbrici,
anche plasticamente evidenziati dagli incroci,
talora quasi stupefacenti per il perfetto
sincronismo nei movimenti dei due interpreti. La
tecnica superba di Bellorini e Cucco ci
restituisce una Kv 497 che ormai non ha più
nulla dello stile galante degli esordi di Amadè,
come subito si annuncia nel colore livido delle
prime battute dell’Adagio introduttivo, e nella
complessità contrappuntistica o nei mossi, quasi
drammatici contrasti dello sviluppo dell’Allegro
iniziale, eseguito conferendo nitida trasparenza
alle linee contrappuntistiche, o ancora, facendo
affiorare, in certe sfumature dei momenti
melodicamente più intensi dell’Andante centrale,
precorrimenti schubertiani, intendiamo dello
Schubert del tardo stile delle ultime sonate per
pianoforte. A questa ottima esecuzione seguiva
infine, a chiudere il concerto una sonata per
due pianoforti la Kv 448 (1781) in Re maggiore:
la coppia Bellorini-Cucco diventa propriamente
un duo, termine che, a voler fare un po’ i
pedanti, è precisamente riservato ai due
pianisti che suonano su due pianoforti distinti.
I due pianoforti, rispetto al pianoforte a
quattro mani, ovviamente, aumentano assai il
volume del suono e quindi offrono possibilità di
sviluppo dialogico e di arricchimento della
tavolozza timbrica. Dal punto di viste dello
stile, dire che il tema principale dell’Allegro
con spirito iniziale è tratto di peso da una
composizione di J.C. Bach è già indicare una
precisa scelta da parte di Mozart nella
direzione dello stile galante, che in effetti
lascia la sua impronta in tutta la sonata. In
effetti la Kv 448 si può intendere come un
estremo omaggio di Mozart a un musicista al
quale guardò sempre con stima e ammirazione,
 anche
quando la sua ricerca musicale lo portò ad a
approdare ad un linguaggio musicale che con
quello del figlio del grande Johann Sebastian
Bach non aveva più nulla da spartire. Il merito
dell’interpretazione offerta da Bellorini e
Cucco consiste a nostro avviso nella riuscita
sintesi tra la gaia leggerezza, la festosa
brillantezza sonora del pezzo e la
valorizzazione di ciò che di più creativamente
mozartiano questo brano presenta: lo sviluppo a
fondo del dialogo concertante tra i due
pianoforti. Un’interpretazione, pertanto, che
cura con meticolosa precisione l’equilibrio tra
le due parti pianistiche, l’intreccio delle
sezioni, l’efficace sfruttamento delle sonorità
nei vari registri della tastiera, dando la
giusta trasparenza, con la pulizia del fraseggio,
alla limpida architettura dell’insieme,
caratteristica di fondo della musica mozartiana,
ciò che fa del cigno di Salisburgo il classico
della musica per eccellenza. Naturalmente non
possiamo non esprimere il nostro apprezzamento
anche per il virtuosismo che in questa pagina
mozartiana è subito presente con lo spumeggiare
di arpeggi, volate, trilli, agilità varie con
cui si apre, come un festoso sipario, la sonata;
e che il duo di bravissimi pianisti esegue con
olimpico dominio della tastiera; un virtuosismo
che le scelte metronomiche di Bellorini e Cucco
per i tempi esterni, piuttosto sostenute,
contribuisce non poco ad esaltare. Gli applausi
prolungati del pubblico, che, come sempre ormai,
da qualche anno stipava l’Auditorium Olivieri,
hanno indotto i due interpreti a regalare un
fuori programma: il primo tempo della sonata per
pianoforte a quattro mani, naturalmente di
Mozart, Kv 381 in Re maggiore, petit cadeau
molto gradito, ancora una volta, per l’alta
qualità dell’esecuzione. anche
quando la sua ricerca musicale lo portò ad a
approdare ad un linguaggio musicale che con
quello del figlio del grande Johann Sebastian
Bach non aveva più nulla da spartire. Il merito
dell’interpretazione offerta da Bellorini e
Cucco consiste a nostro avviso nella riuscita
sintesi tra la gaia leggerezza, la festosa
brillantezza sonora del pezzo e la
valorizzazione di ciò che di più creativamente
mozartiano questo brano presenta: lo sviluppo a
fondo del dialogo concertante tra i due
pianoforti. Un’interpretazione, pertanto, che
cura con meticolosa precisione l’equilibrio tra
le due parti pianistiche, l’intreccio delle
sezioni, l’efficace sfruttamento delle sonorità
nei vari registri della tastiera, dando la
giusta trasparenza, con la pulizia del fraseggio,
alla limpida architettura dell’insieme,
caratteristica di fondo della musica mozartiana,
ciò che fa del cigno di Salisburgo il classico
della musica per eccellenza. Naturalmente non
possiamo non esprimere il nostro apprezzamento
anche per il virtuosismo che in questa pagina
mozartiana è subito presente con lo spumeggiare
di arpeggi, volate, trilli, agilità varie con
cui si apre, come un festoso sipario, la sonata;
e che il duo di bravissimi pianisti esegue con
olimpico dominio della tastiera; un virtuosismo
che le scelte metronomiche di Bellorini e Cucco
per i tempi esterni, piuttosto sostenute,
contribuisce non poco ad esaltare. Gli applausi
prolungati del pubblico, che, come sempre ormai,
da qualche anno stipava l’Auditorium Olivieri,
hanno indotto i due interpreti a regalare un
fuori programma: il primo tempo della sonata per
pianoforte a quattro mani, naturalmente di
Mozart, Kv 381 in Re maggiore, petit cadeau
molto gradito, ancora una volta, per l’alta
qualità dell’esecuzione.
16
marzo 2024 Bruno Busca
Per la prima volta le
composizioni di Toscanini all'Archivio di
Stato di Milano
La rassegna Musica in
Archivio, che si svolge in via Senato a
Milano dallo scorso anno, ha proposto un breve
ma interessantissimo concerto dedicato a
Toscanini compositore. Pochi sanno che il
celebre direttore d'orchestra Arturo Toscanini
si dedicò, negli anni giovanili di studio, anche
alla composizione di romanze su testi poetici,
come era in uso in quel periodo storico che
dall'ultimo ventennio dell'Ottocento arriva fino
alla
 prima guerra mondiale. Nell'introduzione
all'ascolto dei brani in programma, di
particolare interesse sono stati gli interventi
di Annalisa Rossi, Soprintendente Archivistico e
Bibliografico della Lombardia e Direttore
dell'Archivio di Stato milanese, di Marina
Vaccarini, musicologa, e di Monica Cattarossi,
pianista e docente di Musica da camera presso il
Conservatorio "G.Verdi" di Milano. La Rossi ha
presentato i giovani interpreti, che frequentano
corsi di perfezionamento al Conservatorio; la
Vaccarini è entrata nello specifico della figura
di Toscanini direttore e compositore,
illustrando la documentazione della mostra
realizzata in una stanza dell'Archivio (manoscritti,
spartiti, fotografie e articoli di giornali
dell'epoca) . La Cattarossi ha presentato i
dieci brani per canto e pianoforte che sono
stati eseguiti insieme alla Berceuse per
pianoforte solo. L'unicità dell'iniziativa ha
prodotto poco più di trenta minuti di splendida
musica realizzata prima guerra mondiale. Nell'introduzione
all'ascolto dei brani in programma, di
particolare interesse sono stati gli interventi
di Annalisa Rossi, Soprintendente Archivistico e
Bibliografico della Lombardia e Direttore
dell'Archivio di Stato milanese, di Marina
Vaccarini, musicologa, e di Monica Cattarossi,
pianista e docente di Musica da camera presso il
Conservatorio "G.Verdi" di Milano. La Rossi ha
presentato i giovani interpreti, che frequentano
corsi di perfezionamento al Conservatorio; la
Vaccarini è entrata nello specifico della figura
di Toscanini direttore e compositore,
illustrando la documentazione della mostra
realizzata in una stanza dell'Archivio (manoscritti,
spartiti, fotografie e articoli di giornali
dell'epoca) . La Cattarossi ha presentato i
dieci brani per canto e pianoforte che sono
stati eseguiti insieme alla Berceuse per
pianoforte solo. L'unicità dell'iniziativa ha
prodotto poco più di trenta minuti di splendida
musica realizzata
 da Fabio Bossi al pianoforte,
Miwa Kuroda, soprano, e Lian Wang, tenore. I due
eccellenti cantanti si sono alternati
nell'esecuzione dei brani: il Canto di Mignon
ha subito rivelato la potenza vocale della
Kuroda, giapponese, laureata in canto lirico
all'università di Osaka, dotata di perfetta
intonazione e di notevole controllo dinamico;
nel secondo brano, Desolazione, è emersa
sin dalle prime note la superlativa voce
tenorile di Wang, cinese, laureato
all'Università di Nanchino. La bellezza timbrica,
unitamente alla precisa intonazione in ogni
registro e all'elegante portamento della
possente voce, ha permesso la valorizzazione del
lavoro toscaniniano. La Kuroda ha poi
interpretato con passione i brani V'amo, Il
pescatore, Sono sola e Son Gelosa;
mentre Wang ha cantato Primo bacio, Autunno,
Fior di siepe e I baci. Tutte di
grande da Fabio Bossi al pianoforte,
Miwa Kuroda, soprano, e Lian Wang, tenore. I due
eccellenti cantanti si sono alternati
nell'esecuzione dei brani: il Canto di Mignon
ha subito rivelato la potenza vocale della
Kuroda, giapponese, laureata in canto lirico
all'università di Osaka, dotata di perfetta
intonazione e di notevole controllo dinamico;
nel secondo brano, Desolazione, è emersa
sin dalle prime note la superlativa voce
tenorile di Wang, cinese, laureato
all'Università di Nanchino. La bellezza timbrica,
unitamente alla precisa intonazione in ogni
registro e all'elegante portamento della
possente voce, ha permesso la valorizzazione del
lavoro toscaniniano. La Kuroda ha poi
interpretato con passione i brani V'amo, Il
pescatore, Sono sola e Son Gelosa;
mentre Wang ha cantato Primo bacio, Autunno,
Fior di siepe e I baci. Tutte di
grande
 valore le interpretazioni dei giovani
cantanti, che hanno davvero saputo emozionare il
pubblico presente. Bravissimo il pianista, che
non solo ha accompagnato il canto con matura
sensibilità, ma ha anche eseguito la Berceuse,
brano originale sul versante melodico-armonico,
con ottima espressività. Una vera sorpresa è
anche la qualità compositiva del grande
direttore che, oltre alla capacità di forgiare
interessanti melodie, trova abilità di
costruzione armonica di alto livello. Peccato
che dopo il compimento del ventiquattresimo anno
d'età, nel 1891, Toscanini cessò di dedicarsi
alla composizione, impegnandosi solo
nell'attività che lo rese famoso, la direzione
d'orchestra. Un piacevolissimo "concerto-gioiello",
ben organizzato dalla responsabile del progetto
musicale dell'Archivio, la pianista e docente
Silvia Leggio. Applausi meritatissimi. valore le interpretazioni dei giovani
cantanti, che hanno davvero saputo emozionare il
pubblico presente. Bravissimo il pianista, che
non solo ha accompagnato il canto con matura
sensibilità, ma ha anche eseguito la Berceuse,
brano originale sul versante melodico-armonico,
con ottima espressività. Una vera sorpresa è
anche la qualità compositiva del grande
direttore che, oltre alla capacità di forgiare
interessanti melodie, trova abilità di
costruzione armonica di alto livello. Peccato
che dopo il compimento del ventiquattresimo anno
d'età, nel 1891, Toscanini cessò di dedicarsi
alla composizione, impegnandosi solo
nell'attività che lo rese famoso, la direzione
d'orchestra. Un piacevolissimo "concerto-gioiello",
ben organizzato dalla responsabile del progetto
musicale dell'Archivio, la pianista e docente
Silvia Leggio. Applausi meritatissimi.
14-03-2024 Cesare Guzzardella
Il pianista Ingolf
Wunder alla direzione
dell'Orchestra Maderna per la Società dei
Concerti
Il
pianista Ingolf Wunder, nella veste anche di
direttore d'orchestra e di compositore, ha
condotto l'Orchestra Maderna in un programma
particolare che prevedeva prima Mozart, poi
Wunder ed infine Beethoven. Ospitato in Sala
Verdi dalla Società dei Concerti,
Wunder alla direzione e
 al
pianoforte, ha iniziato con il Concerto in do
maggiore K 467 per pianoforte e orchestra
del grande salisburghese, lavoro celebre
soprattutto per l'Andante centrale,
movimento di esemplare equilibrio formale e di
straordinaria bellezza nelle semplici e intense
note del pianoforte. La valida interpretazione
complessiva ha trovato proprio nel delizioso
movimento centrale il frangente più toccante. A
seguire, la composizione dello stesso Wunder,
denominata A dream of a better tomorrow -
con l'autore nella veste solo di direttore- ha
interessato circa dieci minuti del concerto. Il
brano tonale, ha un al
pianoforte, ha iniziato con il Concerto in do
maggiore K 467 per pianoforte e orchestra
del grande salisburghese, lavoro celebre
soprattutto per l'Andante centrale,
movimento di esemplare equilibrio formale e di
straordinaria bellezza nelle semplici e intense
note del pianoforte. La valida interpretazione
complessiva ha trovato proprio nel delizioso
movimento centrale il frangente più toccante. A
seguire, la composizione dello stesso Wunder,
denominata A dream of a better tomorrow -
con l'autore nella veste solo di direttore- ha
interessato circa dieci minuti del concerto. Il
brano tonale, ha un
 introduzione
particolarmente interessante nelle timbriche dei
registri più bassi degli archi. Elementi
melodici più ritmatici e tradizionali subentrano
subito dopo, in un complessivo strumentale ben
costruito con rapidi cambiamenti dei centri di
riferimento e con situazioni coloristiche vicine
alla musica da film. Un buon lavoro che è stato
ben eseguito dai bravissimi orchestrali della
formazione di Forli, fondata nel 1996 e attiva
nei classici e nei contemporanei. Applausi
calorosi. Dopo il breve intervallo, l'ottima
esecuzione della Sinfonia n.7 in la maggiore
op.92 di L.v.Beethoven ha rivelato le
qualità della compagine orchestrale e una valida
direzione di Wunder incentrata su una scelta
interpretativa con andature spedite, come
nell'incisivo Allegro con brio finale,
con le ultime battute ripetute anche nel bis.
Applausi calorosi. introduzione
particolarmente interessante nelle timbriche dei
registri più bassi degli archi. Elementi
melodici più ritmatici e tradizionali subentrano
subito dopo, in un complessivo strumentale ben
costruito con rapidi cambiamenti dei centri di
riferimento e con situazioni coloristiche vicine
alla musica da film. Un buon lavoro che è stato
ben eseguito dai bravissimi orchestrali della
formazione di Forli, fondata nel 1996 e attiva
nei classici e nei contemporanei. Applausi
calorosi. Dopo il breve intervallo, l'ottima
esecuzione della Sinfonia n.7 in la maggiore
op.92 di L.v.Beethoven ha rivelato le
qualità della compagine orchestrale e una valida
direzione di Wunder incentrata su una scelta
interpretativa con andature spedite, come
nell'incisivo Allegro con brio finale,
con le ultime battute ripetute anche nel bis.
Applausi calorosi.
14 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Gidon Kremer,
la Kremerata Baltica e
Osokins alle Serate Musicali
Il
ritorno del violinista lettone Gidon Kremer e
della sua Kremerata Baltica, la compagine
cameristica da lui fondata nel 1997, è sempre
molto atteso per la qualità superlativa che la
formazione offre e per l'impaginato vario e
moderno, che trova sempre momenti dedicati alla
musica dei nostri giorni, spesso con
 prime
esecuzioni. Ieri sera si è ascoltato una specie
di "doppio concerto": dopo le performance di
Kremer insieme alla Kremerata, si è creato un
clima differente, con il giovane e virtuoso
pianista lettone Georgijs Osokins (1995) che ha
concluso il programma ufficiale con il
Concerto n. 2 in fa minore op. 23 di Chopin.
I tre brani che hanno anticipato l'esibizione di
Osokins - tutti tipici da "Kremerata" - erano
due prime esecuzioni italiane, inframmezzate
dalle celebri Las Cuatro Estaciones Porteñas
di Astor Piazzolla, arrangiate per violino e
archi da L.Destatnikov. prime
esecuzioni. Ieri sera si è ascoltato una specie
di "doppio concerto": dopo le performance di
Kremer insieme alla Kremerata, si è creato un
clima differente, con il giovane e virtuoso
pianista lettone Georgijs Osokins (1995) che ha
concluso il programma ufficiale con il
Concerto n. 2 in fa minore op. 23 di Chopin.
I tre brani che hanno anticipato l'esibizione di
Osokins - tutti tipici da "Kremerata" - erano
due prime esecuzioni italiane, inframmezzate
dalle celebri Las Cuatro Estaciones Porteñas
di Astor Piazzolla, arrangiate per violino e
archi da L.Destatnikov.
 Il
primo lavoro, dedicato a Gidon Kremer, era
Pages of a Biography per violino, vibrafono e
archi, del lituano Georgs Pelĕcis
(1947), di Riga,
concittadino di Kremer.
È un brano corposo di
particolare interesse, scritto con un linguaggio
tonale raffinato e fitto di riferimenti al
passato. L'intreccio di temi costruiti su
melodie anche folcloristiche e il riferimento a
importanti concerti solistici per violino del
passato ( il concerto di Beethoven, di
Sibelius), in una sorta di pastiche, dove
le singole parti, spesso identiche ai lavori
originali, vengono ricucite magistralmente con
le timbriche originali di Pelĕcis,
determina una
rilevante composizione, pacata, ricca di spunti
discorsivi, dalla valenza quasi paesaggistica,
con unità
espressiva di
straordinaria fattura. Esecuzione di altissimo
livello per la Kremerata, e parti solistiche di
Kremer, e non solo, eccellenti. Le celebri
Stagioni di Piazzolla, brani straordinari
del compositore argentino molto amato da Kremer,
hanno poi ancora una volta rivelato le qualità
del principale interprete, unitamente allo
straordinario spessore musicale del gruppo
cameristico. Molte prime parti emergono, una fra
tutte la violoncellista Giedre Il
primo lavoro, dedicato a Gidon Kremer, era
Pages of a Biography per violino, vibrafono e
archi, del lituano Georgs Pelĕcis
(1947), di Riga,
concittadino di Kremer.
È un brano corposo di
particolare interesse, scritto con un linguaggio
tonale raffinato e fitto di riferimenti al
passato. L'intreccio di temi costruiti su
melodie anche folcloristiche e il riferimento a
importanti concerti solistici per violino del
passato ( il concerto di Beethoven, di
Sibelius), in una sorta di pastiche, dove
le singole parti, spesso identiche ai lavori
originali, vengono ricucite magistralmente con
le timbriche originali di Pelĕcis,
determina una
rilevante composizione, pacata, ricca di spunti
discorsivi, dalla valenza quasi paesaggistica,
con unità
espressiva di
straordinaria fattura. Esecuzione di altissimo
livello per la Kremerata, e parti solistiche di
Kremer, e non solo, eccellenti. Le celebri
Stagioni di Piazzolla, brani straordinari
del compositore argentino molto amato da Kremer,
hanno poi ancora una volta rivelato le qualità
del principale interprete, unitamente allo
straordinario spessore musicale del gruppo
cameristico. Molte prime parti emergono, una fra
tutte la violoncellista Giedre
 Dirvanauskaite.
Dopo un breve melodico brano come bis, di ottima
fattura e profonda espressività, l'altra prima
esecuzione è stata "Lignum" per Orchestra ed
archi, svilpaunieki (ocarina popolare
lettone a forma di uccello) e percussioni,
del giovane compositore Jekabs Jancĕvskis
(1992).
È un brano che entra
subito nelle corde degli ascoltatori per
l'intenso legame delle timbriche sottili e
raffinate degli archi con il mondo naturale. Gli
alberi sono il riferimento di Lignum, con le
percussioni che richiamano i suoni della natura
e l'ocarina le voci degli uccelli. L'immagine
evocata è quella di una foresta nordica, in cui
l'ascoltatore si immerge in profonda comunione
spirituale con il mondo delle piante. Splendida
l'esecuzione della sola Kremerata. Infine,
Osokins Dirvanauskaite.
Dopo un breve melodico brano come bis, di ottima
fattura e profonda espressività, l'altra prima
esecuzione è stata "Lignum" per Orchestra ed
archi, svilpaunieki (ocarina popolare
lettone a forma di uccello) e percussioni,
del giovane compositore Jekabs Jancĕvskis
(1992).
È un brano che entra
subito nelle corde degli ascoltatori per
l'intenso legame delle timbriche sottili e
raffinate degli archi con il mondo naturale. Gli
alberi sono il riferimento di Lignum, con le
percussioni che richiamano i suoni della natura
e l'ocarina le voci degli uccelli. L'immagine
evocata è quella di una foresta nordica, in cui
l'ascoltatore si immerge in profonda comunione
spirituale con il mondo delle piante. Splendida
l'esecuzione della sola Kremerata. Infine,
Osokins
 ha
suonato in perfetta sintonia con la Kremerata:
eccellente la trascrizione del concerto
chopiniano, nella parte orchestrale, di Yevgeny
Sharlat. La componente degli archi risulta più
importante e volta a sottolineare efficacemente
le raffinatezze sia del compositore che di
Osokins, un interprete perfettamente a suo agio
nella scrittura del grande polacco, rivelando
sicurezza, discorsività ricca di colori e
perfezione di dettaglio. Un' interpretazione
complessiva diversa dal consueto e di ottima
qualità. Valido il bis concesso da Osokins con
il super- virtuosismo di Liszt della "Rákóczi
March", la Rapsodia ungherese n.15.
Applausi calorosissimi dal pubblico delle "Serate
Musicali". (Foto in alto di Alberto Panzani-Serate Musicali) ha
suonato in perfetta sintonia con la Kremerata:
eccellente la trascrizione del concerto
chopiniano, nella parte orchestrale, di Yevgeny
Sharlat. La componente degli archi risulta più
importante e volta a sottolineare efficacemente
le raffinatezze sia del compositore che di
Osokins, un interprete perfettamente a suo agio
nella scrittura del grande polacco, rivelando
sicurezza, discorsività ricca di colori e
perfezione di dettaglio. Un' interpretazione
complessiva diversa dal consueto e di ottima
qualità. Valido il bis concesso da Osokins con
il super- virtuosismo di Liszt della "Rákóczi
March", la Rapsodia ungherese n.15.
Applausi calorosissimi dal pubblico delle "Serate
Musicali". (Foto in alto di Alberto Panzani-Serate Musicali)
12 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
"Le ragazze del West"
a Musica
Maestri! in Conservatorio
Un
concerto di interpreti donne, con brani composti
da donne, quello ascoltato ieri nel tardo
pomeriggio per Musica Maestri!, la
rassegna musicale del Conservatorio milanese che
sta avendo un meriratissimo successo di pubblico
in Sala Puccini. L'impaginato,
 di
rarissimo ascolto, riguardava tre compositrici
americane con brani della prima metà del
Novecento. Marion Bauer (1882-1955), Rebecca
Clarke (1886-1979) e Amy Beach (1867-1944), sono
state scelte da una formazione cameristica per
l'occasione denominata "Le fanciulle del
West" e formata da Agnese Ferraro e
Margherita Ceruti ai violini, Rosaria
Mastrosimone alla viola, Marianna Sinagra al
violoncello e Monica Cattarossi al pianoforte.
In quintetto hanno suonato nell'ultimo brano in
programma, eseguendo il Quintetto in fa
diesis op. 67 per pianoforte e archi (1908)
di Amy Beach. Un brano corposo, ben articolato
che mostra certamente di
rarissimo ascolto, riguardava tre compositrici
americane con brani della prima metà del
Novecento. Marion Bauer (1882-1955), Rebecca
Clarke (1886-1979) e Amy Beach (1867-1944), sono
state scelte da una formazione cameristica per
l'occasione denominata "Le fanciulle del
West" e formata da Agnese Ferraro e
Margherita Ceruti ai violini, Rosaria
Mastrosimone alla viola, Marianna Sinagra al
violoncello e Monica Cattarossi al pianoforte.
In quintetto hanno suonato nell'ultimo brano in
programma, eseguendo il Quintetto in fa
diesis op. 67 per pianoforte e archi (1908)
di Amy Beach. Un brano corposo, ben articolato
che mostra certamente
 l'influenza
avuta dalla Beach dai musicisti europei
romantici, Brahms soprattutto, ma che rivela
anche l'alta cifra compositiva dell'autrice. La
Beach è stata la prima donna americana a
cimentarsi nella produzione di musica colta e
tra i primi compositori americani ad avere avuto
molto successo senza aver studiato in Europa. Di
spessore l'interpretazione ascoltata, con la
parte quartettistica degli archi l'influenza
avuta dalla Beach dai musicisti europei
romantici, Brahms soprattutto, ma che rivela
anche l'alta cifra compositiva dell'autrice. La
Beach è stata la prima donna americana a
cimentarsi nella produzione di musica colta e
tra i primi compositori americani ad avere avuto
molto successo senza aver studiato in Europa. Di
spessore l'interpretazione ascoltata, con la
parte quartettistica degli archi
 ben
coordinata dalle armonie pianistiche dell'ottima
Cattarossi. Di ottima qualità e di eccellente
resa timbrica Up the Ocklawaha op. 6 per
violino e pianoforte (1913) della Bauer.
Pregnante il vibrato della Ferraro ben
amalgamato con il pianoforte della Cattarossi.
Due i brani di Rebecca Clarke, compositrice
inglese, naturalizzata americana, entrambi del
1941. Il primo era Passacaglia on a old
English Tune per violoncello e pianoforte,
un lavoro cupo ben definito dalle ben
coordinata dalle armonie pianistiche dell'ottima
Cattarossi. Di ottima qualità e di eccellente
resa timbrica Up the Ocklawaha op. 6 per
violino e pianoforte (1913) della Bauer.
Pregnante il vibrato della Ferraro ben
amalgamato con il pianoforte della Cattarossi.
Due i brani di Rebecca Clarke, compositrice
inglese, naturalizzata americana, entrambi del
1941. Il primo era Passacaglia on a old
English Tune per violoncello e pianoforte,
un lavoro cupo ben definito dalle
 corpose
timbriche del violoncello della giovane Marianna
Sinagra. Il secondo,
più vario,, tra romantico e
neoclassico,
era Dumka per violino, viola e pianoforte.
Un lavoro assai piacevole, definito benissimo
dal violino della giovane Margherita Ceruti e
dalla viola di Rosaria Mastrosimone, entrambe in
ottima sinergia con il preciso, dettagliato
pianoforte della Cattarossi. Applausi
meritatissimi e come bis un'ottima trascrizione
per quintetto con pianoforte di Sergio Delmastro
dell'Intermezzo dalla Manon Lescaut di
Puccini, ricordando i 100 anni dalla sua
scomparsa. Applausi colorosissimi . Bravissime! corpose
timbriche del violoncello della giovane Marianna
Sinagra. Il secondo,
più vario,, tra romantico e
neoclassico,
era Dumka per violino, viola e pianoforte.
Un lavoro assai piacevole, definito benissimo
dal violino della giovane Margherita Ceruti e
dalla viola di Rosaria Mastrosimone, entrambe in
ottima sinergia con il preciso, dettagliato
pianoforte della Cattarossi. Applausi
meritatissimi e come bis un'ottima trascrizione
per quintetto con pianoforte di Sergio Delmastro
dell'Intermezzo dalla Manon Lescaut di
Puccini, ricordando i 100 anni dalla sua
scomparsa. Applausi colorosissimi . Bravissime!
11 marzo 2024
Cesare Guzzardella
La pianista veronese Ilaria
Loatelli agli Amici del Loggione per
Franz Liszt
"L'arte della parafrasi
operistica" l'abbiamo ascoltata questa mattina
agli Amici del Loggione del Teatro alla Scala
di via Silvio Pellico n.6 dalle mani della
pianista veronese Ilaria Loatelli. È venuta a
Milano per presentare un suo Cd dedicato al
 sommo virtuoso e compositore Liszt autore di
arie e parafrasi da celebri opere dei grandi
musicisti Verdi, Mozart, ecc. All'introduzione
di Mario Marcarini, factotum degli Amici,
sono seguite le chiare parole di Filippo
Michelangeli, direttore di importanti riviste
musicali. Questi ha anche intervistato
brevemente la Locatelli, che ha raccontato la
sua storia, come spesso accade ai bravi sommo virtuoso e compositore Liszt autore di
arie e parafrasi da celebri opere dei grandi
musicisti Verdi, Mozart, ecc. All'introduzione
di Mario Marcarini, factotum degli Amici,
sono seguite le chiare parole di Filippo
Michelangeli, direttore di importanti riviste
musicali. Questi ha anche intervistato
brevemente la Locatelli, che ha raccontato la
sua storia, come spesso accade ai bravi
 pianisti,
di " bambina prodigio" che ha sempre desiderato
di vivere di musica. La Loatelli ha poi
interpretato alcuni brani presenti nel disco,
due tra le più celebri parafrasi di Franz Liszt:
prima quella dal Don Giovanni mozartiano
e poi quella dal Rigoletto verdiano. Il virtuosismo trascendentale della Loatelli ha
portato ad una resa espressiva di pianisti,
di " bambina prodigio" che ha sempre desiderato
di vivere di musica. La Loatelli ha poi
interpretato alcuni brani presenti nel disco,
due tra le più celebri parafrasi di Franz Liszt:
prima quella dal Don Giovanni mozartiano
e poi quella dal Rigoletto verdiano. Il virtuosismo trascendentale della Loatelli ha
portato ad una resa espressiva di
 ottima qualità,
specie in Rigoletto dove l'alto livello
coloristico e l'efficace chiarezza nel delineare
le singole note e le voci nei diversi piani
sonori hanno esaltato le qualità dell'interprete.
Ancora più pregnante il brano concesso come bis:
la celebre Toccata di Sergej Prokof'ev,
eseguita con grande determinazione e dettaglio
dei particolari. Applausi nella sala al completo
e come sempre al termine un brindisi con ottime
degustazioni di vini e formaggi doc. ottima qualità,
specie in Rigoletto dove l'alto livello
coloristico e l'efficace chiarezza nel delineare
le singole note e le voci nei diversi piani
sonori hanno esaltato le qualità dell'interprete.
Ancora più pregnante il brano concesso come bis:
la celebre Toccata di Sergej Prokof'ev,
eseguita con grande determinazione e dettaglio
dei particolari. Applausi nella sala al completo
e come sempre al termine un brindisi con ottime
degustazioni di vini e formaggi doc.
10 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
IL TRIO PER PIANOFORTE ED
ARCHI PROTAGONISTA DEI CONCERTI DEL SABATO AL
CONSERVATORIO DI NOVARA
Per i Concerti del Sabato, la
stagione di musica da camera del Conservatorio
di Novara, ieri, sabato 9 marzo, si è esibito
all’Auditorium un trio formato da strumentisti
decisamente di notevole livello: al pianoforte
sedeva Emanuele Delucchi, nato nel 1987,
milanese di adozione, affermatosi grazie ad una
ormai vasta attività concertistica come solista
e in ambito cameristico, attualmente docente al
Conservatorio di Rovigo; con lui suonavano la
violinista emiliana Rita Mascagna (n.1984) anche
lei con una esperienza formativa e concertistica
di notevole spessore, docente dello strumento
presso il Conservatorio Cantelli di Novara, ed
il violoncellista Fabio Mureddu, accomunato agli
altri due membri del trio da una più che
significativa attività concertistica sia in
orchestra (Filarmonica della Scala e Filarmonica
di S. Cecilia), sia e soprattutto nella musica
da camera, di cui è insegnante al Cantelli.
Attraente il programma del concerto, aperto dal
Trio ‘pathetique’ in Re min. del padre della
musica russa dell’800, Mikhail Glinka. Questo
Trio è per la verità la versione per archi e
pianoforte di un originale previsto per
clarinetto, fagotto e pianoforte, anche se
Glinka stesso prevedeva la possibilità di
sostituire il violoncello al fagotto. La scelta
interpretativa di Delucchi, Mascagna e Mureddu è
stata quella di accentuare il carattere
concertante del Trio, in cui ogni strumento è un
‘personaggio’ impegnato in un dialogo
contrastato con gli altri due: sicuramente il
modello ispiratore di questo Trio è il
melodramma italiano, che Glinka ha modo di
conoscere a fondo durante il suo soggiorno in
Italia negli anni ’30 dell’800, legandosi
 di
amicizia con i grandi cantanti di allora, dalla
Pasta a Rubini, e all’editore Ricordi, che gli
pubblicò questo Trio. Ecco allora che il violino,
delicato ed energico a un tempo, di Rita
Mascagna, il violoncello di raffinata morbidezza
di Fabio Mureddu, il pianoforte di Emanuele
Delucchi, bravissimo nell’accompagnare con
squisiti arabeschi, veri ‘trini’ sonori di
perlaceo nitore con scale e trilli della mano
destra, i due archi nel tempo più bello del
pezzo, l’Adagio, diventano altrettante voci di
un pezzo di puro belcantismo italiano, in cui il
suono svaria suggestivamente dall’appassionato
del primo tempo all’effuso patetismo del Largo.
Seguiva il Trio in Do min. op.101 di J. Brahms.
Composizione caratterizzata da una concisione ed
essenzialità di scrittura, che alleggerisce
quella densità contrappuntistica e tematica
tipiche del comporre brahmsiano, si caratterizza
semmai per una poliedrica varietà di ritmi, che
l’esecuzione di Delucchi, Mascagna e Mureddu
incide con il dovuto rilievo, a cominciare
dall’energia ‘beethoveniana’ del tema principale
dell’Allegro iniziale (‘energico’ appunto,
secondo la definizione in partitura) per passare
a quell’Allegro non assai, che, pur essendo in
tempo binario, fa le veci di uno Scherzo, in
seconda posizione, forse il tempo più
ritmicamente articolato: sono molto bravi, i tre
strumentisti, a trovare la giusta agogica per
dare voce al carattere sfuggente, di un ‘botta e
risposta’ sottilmente inquietante e misterioso
del tema principale, rimbalzante tra i due archi
e la tastiera, e all’estrosità del trio centrale,
per finire coll’andamento capriccioso e
scattante del tema principale del Finale Allegro
Molto, in cui il ricco proliferare d’idee,
tipico di Brahms, torna ad affacciarsi, ma
sempre puntando sull’effetto ritmico, teso a
scompensare ogni regolarità nello svolgimento
melodico. Va aggiunto, a merito dei tre
validissimi protagonisti del concerto di ieri,
che questa raffinata e un po’ stravagante
ricerca ritmica di Brahms, è sempre stata
eseguita con un elegante e composto equilibrio
nel controllo del materiale sonoro, nel giusto
rispetto della sovrana ‘classicità’ che domina
la musica del grande amburghese. Ma accanto a
questa particolare attenzione per l’elemento
ritmico, Delucchi, Mascagna e Mureddu hanno dato
prova, in questo Trio op.101, di saper scavare
nelle profondità più suggestive del suono di
Brahms, in particolare nel terzo tempo, un
Andantino grazioso, che, nonostante la tonalità
maggiore in contrasto con la minore d’impianto
della composizione, appare come il movimento più
velato di ombre crepuscolari e autunnali,
tipiche dell’ultimo Brahms, suggestivamente
espresse dai tre strumenti con una sapiente
calibratura dei chiaroscuri nelle dinamiche e
nei timbri. Nella sognante melodia del secondo
tema, in particolare, il dialogo fra i due archi
e il pianoforte raggiunge davvero livelli di
raffinatezza ammirevole, realizzando quel ‘non
so che’ di indefinibile malinconia tipicamente
brahmsiano, con la soave cantabilità del violino,
la vellutata tenerezza del violoncello nei
registri medio-alti e la delicatezza di tocco
del pianoforte, velata dalle sfumature di di
amicizia con i grandi cantanti di allora, dalla
Pasta a Rubini, e all’editore Ricordi, che gli
pubblicò questo Trio. Ecco allora che il violino,
delicato ed energico a un tempo, di Rita
Mascagna, il violoncello di raffinata morbidezza
di Fabio Mureddu, il pianoforte di Emanuele
Delucchi, bravissimo nell’accompagnare con
squisiti arabeschi, veri ‘trini’ sonori di
perlaceo nitore con scale e trilli della mano
destra, i due archi nel tempo più bello del
pezzo, l’Adagio, diventano altrettante voci di
un pezzo di puro belcantismo italiano, in cui il
suono svaria suggestivamente dall’appassionato
del primo tempo all’effuso patetismo del Largo.
Seguiva il Trio in Do min. op.101 di J. Brahms.
Composizione caratterizzata da una concisione ed
essenzialità di scrittura, che alleggerisce
quella densità contrappuntistica e tematica
tipiche del comporre brahmsiano, si caratterizza
semmai per una poliedrica varietà di ritmi, che
l’esecuzione di Delucchi, Mascagna e Mureddu
incide con il dovuto rilievo, a cominciare
dall’energia ‘beethoveniana’ del tema principale
dell’Allegro iniziale (‘energico’ appunto,
secondo la definizione in partitura) per passare
a quell’Allegro non assai, che, pur essendo in
tempo binario, fa le veci di uno Scherzo, in
seconda posizione, forse il tempo più
ritmicamente articolato: sono molto bravi, i tre
strumentisti, a trovare la giusta agogica per
dare voce al carattere sfuggente, di un ‘botta e
risposta’ sottilmente inquietante e misterioso
del tema principale, rimbalzante tra i due archi
e la tastiera, e all’estrosità del trio centrale,
per finire coll’andamento capriccioso e
scattante del tema principale del Finale Allegro
Molto, in cui il ricco proliferare d’idee,
tipico di Brahms, torna ad affacciarsi, ma
sempre puntando sull’effetto ritmico, teso a
scompensare ogni regolarità nello svolgimento
melodico. Va aggiunto, a merito dei tre
validissimi protagonisti del concerto di ieri,
che questa raffinata e un po’ stravagante
ricerca ritmica di Brahms, è sempre stata
eseguita con un elegante e composto equilibrio
nel controllo del materiale sonoro, nel giusto
rispetto della sovrana ‘classicità’ che domina
la musica del grande amburghese. Ma accanto a
questa particolare attenzione per l’elemento
ritmico, Delucchi, Mascagna e Mureddu hanno dato
prova, in questo Trio op.101, di saper scavare
nelle profondità più suggestive del suono di
Brahms, in particolare nel terzo tempo, un
Andantino grazioso, che, nonostante la tonalità
maggiore in contrasto con la minore d’impianto
della composizione, appare come il movimento più
velato di ombre crepuscolari e autunnali,
tipiche dell’ultimo Brahms, suggestivamente
espresse dai tre strumenti con una sapiente
calibratura dei chiaroscuri nelle dinamiche e
nei timbri. Nella sognante melodia del secondo
tema, in particolare, il dialogo fra i due archi
e il pianoforte raggiunge davvero livelli di
raffinatezza ammirevole, realizzando quel ‘non
so che’ di indefinibile malinconia tipicamente
brahmsiano, con la soave cantabilità del violino,
la vellutata tenerezza del violoncello nei
registri medio-alti e la delicatezza di tocco
del pianoforte, velata dalle sfumature di
 un’abile gestione del pedale di risonanza.
Concludeva il concerto un altro pezzo brahmsiano,
il Trio in Sol magg. op.36, in realtà
trascrizione ad opera di Th. Kirchner del
sestetto per archi di Brahms op.36 n.2, il
celebre “Agathe Sextett”. L’esecuzione ascoltata
ieri all’Auditorium del Conservatorio è stata di
qualità veramente apprezzabile, sia sotto il
profilo tecnico, per la precisione
nell’intonazione, la scelta dei tempi, la
perfezione nelle entrate dei singoli strumenti,
sia sotto il profilo propriamente espressivo,
con una cura molto attenta delle dinamiche e
soprattutto della paletta timbrica, assai varia
e sottile, come sempre in Brahms. In particolare
è da sottolineare la duttilità con cui Delucchi,
Mascagna e Mureddu hanno saputo trovare il suono
adeguato all’atmosfera delicata, appena
adombrata da una sfumata vena malinconica,
virata improvvisamente verso toni di vera
disperazione nella sezione sviluppo, propria del
primo tempo, alla fresca cantabilità del tema
principale dello Scherzo, alla melodia sognante
dell’Adagio, e infine a quel finale Poco
Allegro, piuttosto singolare, in cui è stato
accentuato in particolare il carattere ironico,
quasi burlesco, in strana contraddizione col
rigore strutturale della forma di Rondò-Sonata.
Gran successo di pubblico, che riempiva tutti i
posti dell’Auditorium, sottolineato dai
prolungati applausi, senza, tuttavia, che la
richiesta di bis venisse soddisfatta. Ottimo
concerto, dunque, quello offerto ieri dal
Conservatorio di Novara, che sempre più si va
confermando protagonista irrinunciabile della
vita musicale novarese. un’abile gestione del pedale di risonanza.
Concludeva il concerto un altro pezzo brahmsiano,
il Trio in Sol magg. op.36, in realtà
trascrizione ad opera di Th. Kirchner del
sestetto per archi di Brahms op.36 n.2, il
celebre “Agathe Sextett”. L’esecuzione ascoltata
ieri all’Auditorium del Conservatorio è stata di
qualità veramente apprezzabile, sia sotto il
profilo tecnico, per la precisione
nell’intonazione, la scelta dei tempi, la
perfezione nelle entrate dei singoli strumenti,
sia sotto il profilo propriamente espressivo,
con una cura molto attenta delle dinamiche e
soprattutto della paletta timbrica, assai varia
e sottile, come sempre in Brahms. In particolare
è da sottolineare la duttilità con cui Delucchi,
Mascagna e Mureddu hanno saputo trovare il suono
adeguato all’atmosfera delicata, appena
adombrata da una sfumata vena malinconica,
virata improvvisamente verso toni di vera
disperazione nella sezione sviluppo, propria del
primo tempo, alla fresca cantabilità del tema
principale dello Scherzo, alla melodia sognante
dell’Adagio, e infine a quel finale Poco
Allegro, piuttosto singolare, in cui è stato
accentuato in particolare il carattere ironico,
quasi burlesco, in strana contraddizione col
rigore strutturale della forma di Rondò-Sonata.
Gran successo di pubblico, che riempiva tutti i
posti dell’Auditorium, sottolineato dai
prolungati applausi, senza, tuttavia, che la
richiesta di bis venisse soddisfatta. Ottimo
concerto, dunque, quello offerto ieri dal
Conservatorio di Novara, che sempre più si va
confermando protagonista irrinunciabile della
vita musicale novarese.
10 marzo 2024 Bruno Busca
Ultime repliche al
Teatro
alla Scala per Il ratto dal serraglio di
Mozart
Meritato successo alla penultima
rappresentazione di Die Entführung Aus Dem
Serail, il Singspiel in tre atti di W.A.
Mozart su libretto di Johann Gottlieb Stephanie
jn. da C.F. Bretzner. L'ottima orchestrazione
del giovane direttore tedesco
 Thomas Guggeis
certamente rappresenta un punto di favore per
un'opera storica assai nota per la regia di
Giorgio Strehler. È una messinscena che ha
segnato un momento importante nelle rappresentazioni liriche del Teatro alla Scala.
Il Singspiel tedesco - genere nel quale alle
parti recitate si alternano i pezzi cantati- non
è certo tra le opere più rappresentate del
grande salisburghese. Il ricordo di Giorgio
Strehler, a ventisei anni dalla sua scomparsa, e
di Luciano Damiani, qui scenografo e costumista,
a sedici anni dalla sua dipartita, ed il loro
classico allestimento rappresentato in Scala la
prima volta nel 1972 e prima ancora a Salisburgo Thomas Guggeis
certamente rappresenta un punto di favore per
un'opera storica assai nota per la regia di
Giorgio Strehler. È una messinscena che ha
segnato un momento importante nelle rappresentazioni liriche del Teatro alla Scala.
Il Singspiel tedesco - genere nel quale alle
parti recitate si alternano i pezzi cantati- non
è certo tra le opere più rappresentate del
grande salisburghese. Il ricordo di Giorgio
Strehler, a ventisei anni dalla sua scomparsa, e
di Luciano Damiani, qui scenografo e costumista,
a sedici anni dalla sua dipartita, ed il loro
classico allestimento rappresentato in Scala la
prima volta nel 1972 e prima ancora a Salisburgo
 nel '65, certamente resta indelebile per chi ha
potuto assistervi. L'ultima volta di questo
allestimento nel teatro del Piermarini è stato
nel 2017, per la direzione di Zubin Mehta. Ieri
sera abbiamo trovato un cast vocale all'altezza
del compito assegnato. Bravissimi anche
attorialmente tutti, con molti movimenti tipici
della commedia dell'arte. Segnaliamo
particolarmente la voce di Jessica Pratt in
Kostanze, la cantante più applaudita. Ottimi
tutti gli altri: Daniel Behle in Belmonte,
Jasmin Delfs in nel '65, certamente resta indelebile per chi ha
potuto assistervi. L'ultima volta di questo
allestimento nel teatro del Piermarini è stato
nel 2017, per la direzione di Zubin Mehta. Ieri
sera abbiamo trovato un cast vocale all'altezza
del compito assegnato. Bravissimi anche
attorialmente tutti, con molti movimenti tipici
della commedia dell'arte. Segnaliamo
particolarmente la voce di Jessica Pratt in
Kostanze, la cantante più applaudita. Ottimi
tutti gli altri: Daniel Behle in Belmonte,
Jasmin Delfs in
 Blonde, Peter Rose in
Osmin, Michael Laurenz in Pedrillo e
poi l'eccellente parte recitata di Sven-Eric
Bechtole, Selim e quella mimata di Marco
Merlini, il Servo muto. Di rilievo il
Coro preparato da Giorgio Martano con i relativi
solisti: Roberta Salvati, Alessandra Fratelli,
Luigi Albani e Giuseppe Capoferri. L'ultima
rappresentazione sarà domani, 10 marzo alle ore
14.30. Rimangono ancora pochi posti. Da non
perdere. (prime due foto di Brescia e Amisano-
Archivio della Scala) Blonde, Peter Rose in
Osmin, Michael Laurenz in Pedrillo e
poi l'eccellente parte recitata di Sven-Eric
Bechtole, Selim e quella mimata di Marco
Merlini, il Servo muto. Di rilievo il
Coro preparato da Giorgio Martano con i relativi
solisti: Roberta Salvati, Alessandra Fratelli,
Luigi Albani e Giuseppe Capoferri. L'ultima
rappresentazione sarà domani, 10 marzo alle ore
14.30. Rimangono ancora pochi posti. Da non
perdere. (prime due foto di Brescia e Amisano-
Archivio della Scala)
9 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Presentata a Milano la
26esima rassegna musicale Echos. I luoghi e
la musica
Dal 27 aprile al 23 giugno si
svolgerà la 26esima edizione del festival
musicale itinerante piemontese Echos - I
Luoghi e la Musica, un incontro tra il
patrimonio storico, artistico e paesaggistico
del Monferrato alessandrino con la musica. Come
ricordato dal direttore artistico, il pianista e
organizzatore di eventi musicali dell'Associazione
Musicale
 Ondasonora APS, Sergio Marchegiani,
nella splendida location gastronomica di via
Laghetto a Milano, sono previsti 23 concerti in
diversi comuni della provincia di Alessandria a
cominciare da sabato 27 aprile quando avverrà l'
inaugurazione con l’Orchestra ICO Suoni del Sud,
con il violinista Ettore Pellegrino, il trio
Nosso Brasil e Roberto Molinelli alla direzione.
Tra i numerosissimi ospiti, tutti di
straordinaria qualità, troviamo anche Angela
Hewitt, Ilia Kim, Maurizio Baglini, il Duo Hauri-Moos,
e il Trio Johanne. Scopo della rassegna non è
solo quello di fare ascoltare ottima musica con
eccellenti interpreti, ma anche proporre la
possibile conoscenza di luoghi storici
straordinari di quella parte del Piemonte che
tra Alessandria e il Monferrato occupa una zona
estesa della regione Piemonte tra le più
meritevoli di conoscenza. A questi elementi si
unisce anche la possibilità di assaporare la
migliore cucina italiana e gli eccellenti vini,.
"I luoghi dei vini" celebrerà la nomina
del "GranMonferrato", rappresentato dalle città
di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada, come
Città Europea del vino 2024. Si auspica una di
grande partecipazione anche da chi proviene da
aree territoriali limitrofe ai "luoghi", come
tutta l'area milanese. Per ulteriori
informazioni consultare il sito
Www.festivalechos.it Ondasonora APS, Sergio Marchegiani,
nella splendida location gastronomica di via
Laghetto a Milano, sono previsti 23 concerti in
diversi comuni della provincia di Alessandria a
cominciare da sabato 27 aprile quando avverrà l'
inaugurazione con l’Orchestra ICO Suoni del Sud,
con il violinista Ettore Pellegrino, il trio
Nosso Brasil e Roberto Molinelli alla direzione.
Tra i numerosissimi ospiti, tutti di
straordinaria qualità, troviamo anche Angela
Hewitt, Ilia Kim, Maurizio Baglini, il Duo Hauri-Moos,
e il Trio Johanne. Scopo della rassegna non è
solo quello di fare ascoltare ottima musica con
eccellenti interpreti, ma anche proporre la
possibile conoscenza di luoghi storici
straordinari di quella parte del Piemonte che
tra Alessandria e il Monferrato occupa una zona
estesa della regione Piemonte tra le più
meritevoli di conoscenza. A questi elementi si
unisce anche la possibilità di assaporare la
migliore cucina italiana e gli eccellenti vini,.
"I luoghi dei vini" celebrerà la nomina
del "GranMonferrato", rappresentato dalle città
di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada, come
Città Europea del vino 2024. Si auspica una di
grande partecipazione anche da chi proviene da
aree territoriali limitrofe ai "luoghi", come
tutta l'area milanese. Per ulteriori
informazioni consultare il sito
Www.festivalechos.it
Marzo 2024 dalla redazione
Torna "Il Pianoforte
in Ateneo"
all'Università Cattolica milanese con il
pianista Elia Cecino
"Il
Pianoforte in Ateneo", la rassegna musicale
dedicata al pianoforte, è tornata all'Università
Cattolica del Sacro Cuore con il primo
appuntamento della nuova Stagione. Organizzatori
delle serate musicali, che quest'anno saranno
ben sette, sono il prof. Enrico Reggiani,
direttore dello Studium Musicale di Ateneo
e il Maestro Davide Cabassi,
pianista-concertista e docente al Conservatorio
" G. Verdi" di Milano. Ieri sera abbiamo
ascoltato
 alla
tastiera del prestigioso Shigeru Kawai il
giovane Lia Cecino, interprete che per le
sorprendenti doti virtuosistiche è già da tempo
inserito nel circuito concertistico più ampio
con performance sostenute in Europa e in
altre regioni del mondo. L'esecuzione dei brani
è stata preceduta dalla presentazione dei
concerti in rassegna da parte del direttore
musicale Davide Cabassi. Il prof. Reggiani
invece ha fatto un interessante intervento sul
pianoforte come oggetto appartenente ad un
contesto culturale più ampio, dove la resa
musicale rappresenta solo una parte di una più
ampia contestualizzazione. Si è passati poi alla
musica. alla
tastiera del prestigioso Shigeru Kawai il
giovane Lia Cecino, interprete che per le
sorprendenti doti virtuosistiche è già da tempo
inserito nel circuito concertistico più ampio
con performance sostenute in Europa e in
altre regioni del mondo. L'esecuzione dei brani
è stata preceduta dalla presentazione dei
concerti in rassegna da parte del direttore
musicale Davide Cabassi. Il prof. Reggiani
invece ha fatto un interessante intervento sul
pianoforte come oggetto appartenente ad un
contesto culturale più ampio, dove la resa
musicale rappresenta solo una parte di una più
ampia contestualizzazione. Si è passati poi alla
musica. L'impaginato scelto dal ventitreenne trevigiano
era improntato al grande pianismo romantico di
tre grandi compositori quali Chopin, con la
Sonata n.2 in si bem. minore op.35 composta
tra il 1837 e il 1839; di Mendelssohn con le
Variations Sérieuses op. 54 completate nel
1841, ed infine con gli Studi Sinfonici op.13
di Schumann, composti nel 1834. Tutti brani
celebri, pensati ad una distanza temporale, tra
il primo e l'ultimo lavoro, di soli sette anni.
Cecino ha individuato i giusti tempi per la
corposa Sonata chopiniana, fornendo una
valida interpretazione mediata da una solidità
strutturale di pregnante espressività.
L'impaginato scelto dal ventitreenne trevigiano
era improntato al grande pianismo romantico di
tre grandi compositori quali Chopin, con la
Sonata n.2 in si bem. minore op.35 composta
tra il 1837 e il 1839; di Mendelssohn con le
Variations Sérieuses op. 54 completate nel
1841, ed infine con gli Studi Sinfonici op.13
di Schumann, composti nel 1834. Tutti brani
celebri, pensati ad una distanza temporale, tra
il primo e l'ultimo lavoro, di soli sette anni.
Cecino ha individuato i giusti tempi per la
corposa Sonata chopiniana, fornendo una
valida interpretazione mediata da una solidità
strutturale di pregnante espressività.
 Altrettanto
valide le successive Variations Sérieuses
mendelssohniane, nella loro progressione di
trasformazione del tema principale in un ottima
unità stilistica. I corposi e geniali Studi
Sinfonici di Schumann, hanno trovato
maggiore espressività nel corso
dell'interpretazioni con gli ultimi Studi, anche
questi straordinarie varianti del tema iniziale,
via via più espressivi e definiti con maggiore
grinta e profondità. Applausi sostenuti nella
splendida Aula magna dell'università al completo
e ben due i bis concessi
con un nitido Piccolo Valzer (1894)
pucciniano (per i cento anni dalla morte) , poi
inserito nell'Aria di Musetta - Quando
me n'vo- in Bohème, ed una trasparente ed
elegante Mazurka in si bem. minore di
Chopin. Bravissimo! Altrettanto
valide le successive Variations Sérieuses
mendelssohniane, nella loro progressione di
trasformazione del tema principale in un ottima
unità stilistica. I corposi e geniali Studi
Sinfonici di Schumann, hanno trovato
maggiore espressività nel corso
dell'interpretazioni con gli ultimi Studi, anche
questi straordinarie varianti del tema iniziale,
via via più espressivi e definiti con maggiore
grinta e profondità. Applausi sostenuti nella
splendida Aula magna dell'università al completo
e ben due i bis concessi
con un nitido Piccolo Valzer (1894)
pucciniano (per i cento anni dalla morte) , poi
inserito nell'Aria di Musetta - Quando
me n'vo- in Bohème, ed una trasparente ed
elegante Mazurka in si bem. minore di
Chopin. Bravissimo!
8 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Contrasti musicali ai
concerti de I Pomeriggi del Dal Verme
Un
programma variegato quello ascoltato
all'anteprima del mattino con l'Orchestra de
I Pomeriggi Musicali e il suo direttore
James Feddeck. A iniziare, andando a ritroso nel
tempo, da un brano contemporaneo per strumenti a
fiato e
 percussioni
di Alberto Cara (1975) con il suo Wedding and
Funeral Marching Band, passando per il
milanese Nino Rota ( 1911-1979) con il raro ma
efficace Divertimento concertante per
Contrabbasso e Orchestra, arrivando poi a
Beethoven (1770-1827) con l'Ouverture in do
minore op.62 "Coriolano" seguita dalla
Sinfonia n.8 in fa maggiore op.93. Il
recente lavoro di Cara offre momenti di vitalità
coloristica nei riusciti contrasti tra le
timbriche melodiose dei fiati e le brusche
ritmiche delle percussini che in vari percussioni
di Alberto Cara (1975) con il suo Wedding and
Funeral Marching Band, passando per il
milanese Nino Rota ( 1911-1979) con il raro ma
efficace Divertimento concertante per
Contrabbasso e Orchestra, arrivando poi a
Beethoven (1770-1827) con l'Ouverture in do
minore op.62 "Coriolano" seguita dalla
Sinfonia n.8 in fa maggiore op.93. Il
recente lavoro di Cara offre momenti di vitalità
coloristica nei riusciti contrasti tra le
timbriche melodiose dei fiati e le brusche
ritmiche delle percussini che in vari
 momenti
entrano per modificare il tempo e per
vivacizzare con grinta le sequenze coloristiche
altrimenti uniformi. Un ottimo lavoro con
meritati applausi conclusivi anche al
compositore in palcoscenico. Rota, celebre in
tutti i suoi brani felliniani, ci offre qui un
brano ampio, in quattro movimenti, in stile
neoclassico che ricorda certo Prokofiev o certo
Šostakovič. Punto di riferimento centrale le
note gravi del contrabbasso di Paolo Speziale,
che in territorio tonale, come la valida
orchestrazione ben diretta da Feddeck, ci ha
portato melodie sognanti dai colori momenti
entrano per modificare il tempo e per
vivacizzare con grinta le sequenze coloristiche
altrimenti uniformi. Un ottimo lavoro con
meritati applausi conclusivi anche al
compositore in palcoscenico. Rota, celebre in
tutti i suoi brani felliniani, ci offre qui un
brano ampio, in quattro movimenti, in stile
neoclassico che ricorda certo Prokofiev o certo
Šostakovič. Punto di riferimento centrale le
note gravi del contrabbasso di Paolo Speziale,
che in territorio tonale, come la valida
orchestrazione ben diretta da Feddeck, ci ha
portato melodie sognanti dai colori
 onirici
di efficace impatto
coloristico.
Bravissimo
Paolo
Speziale Ancora applausi meritati. Dopo la breve,
pausa un Beethoven più
potente con l'Ouverture
da Coriolano, e uno di passaggio verso la
Nona Sinfonia, con un'Ottava ben
delineata dai bravi orchestrali de I
Pomeriggi, ci hanno portato al termine della
riuscita mattinata. Questa sera alle ore 20.00
la prima ufficiale e sabato alle 17.00 la
replica. onirici
di efficace impatto
coloristico.
Bravissimo
Paolo
Speziale Ancora applausi meritati. Dopo la breve,
pausa un Beethoven più
potente con l'Ouverture
da Coriolano, e uno di passaggio verso la
Nona Sinfonia, con un'Ottava ben
delineata dai bravi orchestrali de I
Pomeriggi, ci hanno portato al termine della
riuscita mattinata. Questa sera alle ore 20.00
la prima ufficiale e sabato alle 17.00 la
replica.
7 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
L'Orchestra della Toscana
diretta da Diego Ceretta per un “Omaggio a
Wolfgang”
Un
programma di straordinario interesse quello
ascoltato ieri sera in Conservatorio per la "Società
dei Concerti". L' Omaggio a Wolfgang
- naturalmente si tratta di Mozart- era
incentrato su due capolavori del genio
salisburghese quali il Concerto per
pianoforte e orchestra in re minore K 466 e
la Sinfonia n. 41 in
 do maggiore K 551
“Jupiter”, anticipati però da un recente
lavoro di Lera Auerbach, con il suo Eterniday,
sottotitolato Hommage to W.A. Mozart.
L'Orchestra della Toscana è venuta spesso in
Sala Verdi ospite della Società dei Concerti,
ma per la prima volta con il giovanissimo
direttore milanese Diego Ceretta, nato nel 1996
e ancora ventisettenne. Ceretta è dal marzo 2023
nuovo direttore stabile della ORT, una delle
compagini orchestrali tra le migliori italiane.
Protagonisti del concerto, oltre al direttore
d'orchestra anche la russa Lera Auerbach, nel
doppio ruolo di compositrice, per il primo
lavoro in programma, e di pianista per il
Concerto K 466 di Mozart. do maggiore K 551
“Jupiter”, anticipati però da un recente
lavoro di Lera Auerbach, con il suo Eterniday,
sottotitolato Hommage to W.A. Mozart.
L'Orchestra della Toscana è venuta spesso in
Sala Verdi ospite della Società dei Concerti,
ma per la prima volta con il giovanissimo
direttore milanese Diego Ceretta, nato nel 1996
e ancora ventisettenne. Ceretta è dal marzo 2023
nuovo direttore stabile della ORT, una delle
compagini orchestrali tra le migliori italiane.
Protagonisti del concerto, oltre al direttore
d'orchestra anche la russa Lera Auerbach, nel
doppio ruolo di compositrice, per il primo
lavoro in programma, e di pianista per il
Concerto K 466 di Mozart.
 È certamente nota
internazionalmente per la sua creatività che si
divide tra composizione, direzione d'orchestra,
interpretazione pianistica, per quello che
concerne il mondo musicale; ma è anche una
scultrice e una poetessa. Artista quindi a 360
gradi, ha dimostrato le sue qualità sia nello
scuro e pregnante brano Eterniday, un lavoro
ispirato da Mozart ma decisamente personale
anche nell'organizzazione orchestrale che
prevede una piccola formazione da camera insieme
alla più ampia orchestra. Le timbriche
suggestive degli orchestrali e dei singoli
strumentisti che spesso intervengono in modo
concertante, avevano nel brano una definizione
molto precisa, curata nei dettagli e in questo
senso molto mozartiana. Un ottimo lavoro diretto
con dovizia di dettaglio da Ceretta. Con i brani
mozartiani siamo entrati in un altro clima
musicale. La creatività della Auerbach è emersa
nel suo modo d'interpretare Mozart. Il profondo
Concerto in re minore K 466 ha trovato
un'intensità espressiva È certamente nota
internazionalmente per la sua creatività che si
divide tra composizione, direzione d'orchestra,
interpretazione pianistica, per quello che
concerne il mondo musicale; ma è anche una
scultrice e una poetessa. Artista quindi a 360
gradi, ha dimostrato le sue qualità sia nello
scuro e pregnante brano Eterniday, un lavoro
ispirato da Mozart ma decisamente personale
anche nell'organizzazione orchestrale che
prevede una piccola formazione da camera insieme
alla più ampia orchestra. Le timbriche
suggestive degli orchestrali e dei singoli
strumentisti che spesso intervengono in modo
concertante, avevano nel brano una definizione
molto precisa, curata nei dettagli e in questo
senso molto mozartiana. Un ottimo lavoro diretto
con dovizia di dettaglio da Ceretta. Con i brani
mozartiani siamo entrati in un altro clima
musicale. La creatività della Auerbach è emersa
nel suo modo d'interpretare Mozart. Il profondo
Concerto in re minore K 466 ha trovato
un'intensità espressiva
 rilevante nella
restituzione orchestrale. La componente
pianistica è stata delineata con rigore e
chiarezza dalla Auerbach, che ha avuto come
momenti creativi rivelatori le due ampie
Cadenze solistiche, la prima nell'Allegro
iniziale e la seconda nel Rondò.Allegro assai
finale. La parte cadenzata era opera
interamente della compositrice che si è
sbizzarrita
- con ottimo risultato- a trovare un
compromesso tra Mozart e il suo modo di generare
armonie. Valida la resa complessiva. Ottimi i
due bis concessi dalla stessa Auerbach: prima un
Étude Tableaux
di Rachmaninov di
pregnante resa emotiva e poi una
Sonata
di Scarlatti tra le più celebri,
interpretata con
una personalizzazione eccellente nell' andamento
rapido scelto con perfetta coerenza stilistica.
Applausi fragorosi meritatissimi. La seconda
parte del concerto
( iniziata in ritardo per una
sfortunata caduta di un anziano spettatore
ultranovantenne durante l'intervallo e l'attesa
dell'ambulanza) ha visto la celebre rilevante nella
restituzione orchestrale. La componente
pianistica è stata delineata con rigore e
chiarezza dalla Auerbach, che ha avuto come
momenti creativi rivelatori le due ampie
Cadenze solistiche, la prima nell'Allegro
iniziale e la seconda nel Rondò.Allegro assai
finale. La parte cadenzata era opera
interamente della compositrice che si è
sbizzarrita
- con ottimo risultato- a trovare un
compromesso tra Mozart e il suo modo di generare
armonie. Valida la resa complessiva. Ottimi i
due bis concessi dalla stessa Auerbach: prima un
Étude Tableaux
di Rachmaninov di
pregnante resa emotiva e poi una
Sonata
di Scarlatti tra le più celebri,
interpretata con
una personalizzazione eccellente nell' andamento
rapido scelto con perfetta coerenza stilistica.
Applausi fragorosi meritatissimi. La seconda
parte del concerto
( iniziata in ritardo per una
sfortunata caduta di un anziano spettatore
ultranovantenne durante l'intervallo e l'attesa
dell'ambulanza) ha visto la celebre
 Jupiter K
551, ultima delle sinfonie mozartiane, che
ha come ultimo movimento quell' incredibile
Molto Allegro
dalla evidente
coralità
polifonica . Diego Ceretta ha trovato un
perfetto dosaggio nei tempi, nelle dinamiche e
nei colori, arrivando poi nel gran finale ad una
resa interpretativa di elevato livello estetico.
Eccellente la compagine orchestrale in ogni
sezione orchestrale. Applausi sostenuti dal
numeroso pubblico presente in Sala Verdi,
con numerose uscite del giovane bravissimo direttore. Jupiter K
551, ultima delle sinfonie mozartiane, che
ha come ultimo movimento quell' incredibile
Molto Allegro
dalla evidente
coralità
polifonica . Diego Ceretta ha trovato un
perfetto dosaggio nei tempi, nelle dinamiche e
nei colori, arrivando poi nel gran finale ad una
resa interpretativa di elevato livello estetico.
Eccellente la compagine orchestrale in ogni
sezione orchestrale. Applausi sostenuti dal
numeroso pubblico presente in Sala Verdi,
con numerose uscite del giovane bravissimo direttore.
7 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Il pianista Ali
Hirèche all'Archivio
di Stato di Milano
Per la rassegna "Musica in
Archivio" è stato presentato il recente Cd
del pianista parigino Ali Hirèche e l'opera
pittorica di Giulio Frigo, autore dell'immagine
di copertina dell'incisione discografica.
Annalisa Rossi, direttrice
 dell'Archivio di
Stato di Milano, Luca Ciammarughi, musicologo e pianista, Andrea Chersicla, esperto d'arte,
Silvia Leggio, pianista e docente di pianoforte
al Conservatorio "G.Verdi"
di Milano e curatrice
della rassegna musicale, hanno presentato il
musicista e l'opera del pittore purtroppo non
presente. dell'Archivio di
Stato di Milano, Luca Ciammarughi, musicologo e pianista, Andrea Chersicla, esperto d'arte,
Silvia Leggio, pianista e docente di pianoforte
al Conservatorio "G.Verdi"
di Milano e curatrice
della rassegna musicale, hanno presentato il
musicista e l'opera del pittore purtroppo non
presente.
 Dopo gli interessanti interventi, con
Ciammarughi che ha con competenza approfondito
gli aspetti musicali dei brani di Schubert e
di
Liszt presenti nel Cd, inquadrandoli
storicamente e delineando la personalità dei due
grandi musicisti, e con Chersicla che ha messo
in risalto l'originale dipinto di Giulio Frigo
nelle sue caratteristiche peculiari, il Maestro
Hiréche ha dato saggio delle sue eccellenti
qualità virtuosistiche eseguendo due Dopo gli interessanti interventi, con
Ciammarughi che ha con competenza approfondito
gli aspetti musicali dei brani di Schubert e
di
Liszt presenti nel Cd, inquadrandoli
storicamente e delineando la personalità dei due
grandi musicisti, e con Chersicla che ha messo
in risalto l'originale dipinto di Giulio Frigo
nelle sue caratteristiche peculiari, il Maestro
Hiréche ha dato saggio delle sue eccellenti
qualità virtuosistiche eseguendo due
 brani
inclusi nel cd (la recensione è in questo
giornale) e precisamente la Sonata in si
minore di F.Liszt e Gretchen am Spinnrade
di Schubert- Liszt. Le interpretazioni di
alto livello, hanno messo in risalto la forza
espressiva di Hirèche nel delineare con impeto e
chiarezza enunciativa i passaggi spesso impervi
del celebre capolavoro lisztiano. Applausi
sostenuti dal numeroso pubblico intervenuto ed
eccellente il bis concesso dal pianista parigino
con lo Studio n.12 Op.10 di F. Chopin. brani
inclusi nel cd (la recensione è in questo
giornale) e precisamente la Sonata in si
minore di F.Liszt e Gretchen am Spinnrade
di Schubert- Liszt. Le interpretazioni di
alto livello, hanno messo in risalto la forza
espressiva di Hirèche nel delineare con impeto e
chiarezza enunciativa i passaggi spesso impervi
del celebre capolavoro lisztiano. Applausi
sostenuti dal numeroso pubblico intervenuto ed
eccellente il bis concesso dal pianista parigino
con lo Studio n.12 Op.10 di F. Chopin.
6 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Roberto Cominati
alle Serate
Musicali del Conservatorio
Roberto
Cominati, pianista napoletano, classe 1969, è
salito alla ribalta concertistica dopo la
vittoria nei prestigiosi concorsi internazionali
"Alfredo Casella" (1991) e "Ferruccio Busoni"
(1993). La sua attività di pilota d'aerei di
linea non gli ha impedito di dedicarsi a
numerosi concerti in tutto il mondo. Ieri sera,
per le Serate Musicali al Conservatorio, ha
scelto due compositori a lui
 cari,
quali Claude Debussy e Robert Schumann. Entrambi
importanti innovatori di linguaggi armonici, sia
il francese che il tedesco hanno inciso molto
nella storia della musica, soprattutto
pianistica, ma non solo, per la loro vasta
produzione nella quale la componente di ricerca
anche coloristica risulta fondamentale. Di
Debussy, Cominati ha scelto il libro n.2
dei Préludes, mentre di Schumann una
rarità esecutiva quale la Sonata n.3 in fa
minore op.14 "Concerto senza orchestra".
L'ottima interpretazione dei dodici preludi,
eseguiti senza soluzione di continuità, ha
rivelato la cari,
quali Claude Debussy e Robert Schumann. Entrambi
importanti innovatori di linguaggi armonici, sia
il francese che il tedesco hanno inciso molto
nella storia della musica, soprattutto
pianistica, ma non solo, per la loro vasta
produzione nella quale la componente di ricerca
anche coloristica risulta fondamentale. Di
Debussy, Cominati ha scelto il libro n.2
dei Préludes, mentre di Schumann una
rarità esecutiva quale la Sonata n.3 in fa
minore op.14 "Concerto senza orchestra".
L'ottima interpretazione dei dodici preludi,
eseguiti senza soluzione di continuità, ha
rivelato la
 raffinatezza
di un pianista dal tocco leggero, accompagnato a
tecnica precisa e sintesi discorsiva di chi ha
interiorizzato completamente il materiale sonoro.
Cominati ha delineato con maestria i colori del
compositore francese, di cui, a fine concerto,
come bis, ha interpretato con meditazione e
chiarezza il celebre Clair de lune. La
sonata di Schumann, scritta dal giovane genio a
soli venticinque anni ma già ricca di armonie,
dal linguaggio elaborato e dalle timbriche molto
orchestrali, è stata resa da Cominati con
un'ottima sintesi dei quattro movimenti che la
compongono. Lunghi applausi meritatissimi e,
come secondo bis, un classico brano americano di
Harold Arlen, "Over the Rainbow",
interpretato con raffinate influenze jazz. raffinatezza
di un pianista dal tocco leggero, accompagnato a
tecnica precisa e sintesi discorsiva di chi ha
interiorizzato completamente il materiale sonoro.
Cominati ha delineato con maestria i colori del
compositore francese, di cui, a fine concerto,
come bis, ha interpretato con meditazione e
chiarezza il celebre Clair de lune. La
sonata di Schumann, scritta dal giovane genio a
soli venticinque anni ma già ricca di armonie,
dal linguaggio elaborato e dalle timbriche molto
orchestrali, è stata resa da Cominati con
un'ottima sintesi dei quattro movimenti che la
compongono. Lunghi applausi meritatissimi e,
come secondo bis, un classico brano americano di
Harold Arlen, "Over the Rainbow",
interpretato con raffinate influenze jazz.
5 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Piercarlo Sacco
e Luca
Schieppati allo Spazio Teatro 89 per un
concerto dedicato a Tolstoj
Da
quindici anni suonano in duo il
violinista Piercarlo Sacco e il pianista Luca
Schieppati. Ieri pomeriggio alla Spazio
Teatro 89 di via Fretelli Zoia a Milano,
hanno voluto rendere omaggio al grande
romanziere russo Lev Tolstoj (1828-1910) con un
concerto denominato "Qualcosa di terribile-
Tolstoj, la musica e
 altre
invettive". Come accennato da Schieppati
nella presentazione del concerto, Tolstoj amava
la musica; la moglie pianista accompagnava molti
strumentisti e lui stesso compose alcuni
semplici brani. Ammirava i grandi geni della
musica, a cominciare dal suo contemporaneo ed
amico P.I.Čaikovskij
(1840-1893). Del musicista russo
è stato eseguito il brano
"Méditation" da Souvenir d'un lieu
cher, op.42, nella trascrizione per violino
e pianoforte. È un lavoro di pregnante
espressività romantica interpretato con passione
da Sacco e da Schieppati. Il successivo, un
semplice e grazioso Valzer per pianoforte
di Lev Tolstoj - poche note del grande
romanziere - anticipava il brano di Carlo
Galante (1959), Per Sof'ja Tolstaja. Piccola
Sonata in forma altre
invettive". Come accennato da Schieppati
nella presentazione del concerto, Tolstoj amava
la musica; la moglie pianista accompagnava molti
strumentisti e lui stesso compose alcuni
semplici brani. Ammirava i grandi geni della
musica, a cominciare dal suo contemporaneo ed
amico P.I.Čaikovskij
(1840-1893). Del musicista russo
è stato eseguito il brano
"Méditation" da Souvenir d'un lieu
cher, op.42, nella trascrizione per violino
e pianoforte. È un lavoro di pregnante
espressività romantica interpretato con passione
da Sacco e da Schieppati. Il successivo, un
semplice e grazioso Valzer per pianoforte
di Lev Tolstoj - poche note del grande
romanziere - anticipava il brano di Carlo
Galante (1959), Per Sof'ja Tolstaja. Piccola
Sonata in forma
 di Diario , eseguito alla
presenza del compositore milanese. È un lavoro
in due movimenti, un Mosso e un
Agitato, il secondo tempo composto alcuni
anni dopo il primo, sempre per il duo Sacco/Schieppati.
Galante ha tratto ispirazione dalla lettura dei
diari della moglie del romanziere, Sof'ja, una
donna che ebbe certo una convivenza sofferta con
un genio dal carattere particolarmente difficile.
Il brano, ricco di forti contrasti, nell'ottima
costruzione compositiva che fa dialogare con
grinta il melodioso violino di Sacco con le
armonie pianistiche di Schieppati, riflette le
situazioni spesso burrascose nella vita della
celebre coppia russa. Nalla parte centrale
compare anche un riferimento al grazioso tema di
Valzer di Tolstoj. Un lavoro di ottima
qualità, che ancora una volta ritrova un
compositore che scrive in modo espressivo, con
un linguaggio accessibile, che crea emozioni. Il
brano successivo, Morceaux de Salon op.6 n.2
di Sergej Rachmaninov (1873-1943) è una
rarità esecutiva di felice impatto virtuosistico
e di eccellente integrazione timbrica tra i due
strumenti. È stato scelto Rachmaninov ricordando
che ebbe anche lui modo di conoscere
personalmente Tolstoj, di Diario , eseguito alla
presenza del compositore milanese. È un lavoro
in due movimenti, un Mosso e un
Agitato, il secondo tempo composto alcuni
anni dopo il primo, sempre per il duo Sacco/Schieppati.
Galante ha tratto ispirazione dalla lettura dei
diari della moglie del romanziere, Sof'ja, una
donna che ebbe certo una convivenza sofferta con
un genio dal carattere particolarmente difficile.
Il brano, ricco di forti contrasti, nell'ottima
costruzione compositiva che fa dialogare con
grinta il melodioso violino di Sacco con le
armonie pianistiche di Schieppati, riflette le
situazioni spesso burrascose nella vita della
celebre coppia russa. Nalla parte centrale
compare anche un riferimento al grazioso tema di
Valzer di Tolstoj. Un lavoro di ottima
qualità, che ancora una volta ritrova un
compositore che scrive in modo espressivo, con
un linguaggio accessibile, che crea emozioni. Il
brano successivo, Morceaux de Salon op.6 n.2
di Sergej Rachmaninov (1873-1943) è una
rarità esecutiva di felice impatto virtuosistico
e di eccellente integrazione timbrica tra i due
strumenti. È stato scelto Rachmaninov ricordando
che ebbe anche lui modo di conoscere
personalmente Tolstoj,
 davanti
al quale suonò alcuni suoi pezzi. Ne ricevette
ahimè critiche, non consensi, in un momento, per
di più, di grave depressione del giovane
compositore. Eccellente l'interpretazione di un
lavoro che trova una discorsività dal sapore
lisztiano. Il capolavoro conclusivo era la
celebre Sonata op.47 "A Kreutzer" di
Beethoven (1770-1827). Questa volta è Tolstoj
debitore al genio tedesco, in quanto ne fu
ispirato per il suo omonimo romanzo breve del
1889. Un'interpretazione di valore, con
timbriche decise, robuste nell'ottima sinergia
dei protagonisti. Applausi fragorosi dai
numerosi intervenuti e come bis la Vision
Congolaise, secondo brano dal Trittico
op.136 di Camille Saint-Saëns. Di assoluta
originalità, è inserito nel recente Cd uscito
per Da Vinci Classics (recensione su
questo giornale) ed interamente dedicato alle
musiche per violino e pianoforte del compositore
francese: lavori eseguiti benissimo
dall'affiatato duo Sacco-Schieppati. davanti
al quale suonò alcuni suoi pezzi. Ne ricevette
ahimè critiche, non consensi, in un momento, per
di più, di grave depressione del giovane
compositore. Eccellente l'interpretazione di un
lavoro che trova una discorsività dal sapore
lisztiano. Il capolavoro conclusivo era la
celebre Sonata op.47 "A Kreutzer" di
Beethoven (1770-1827). Questa volta è Tolstoj
debitore al genio tedesco, in quanto ne fu
ispirato per il suo omonimo romanzo breve del
1889. Un'interpretazione di valore, con
timbriche decise, robuste nell'ottima sinergia
dei protagonisti. Applausi fragorosi dai
numerosi intervenuti e come bis la Vision
Congolaise, secondo brano dal Trittico
op.136 di Camille Saint-Saëns. Di assoluta
originalità, è inserito nel recente Cd uscito
per Da Vinci Classics (recensione su
questo giornale) ed interamente dedicato alle
musiche per violino e pianoforte del compositore
francese: lavori eseguiti benissimo
dall'affiatato duo Sacco-Schieppati.
4
marzo 2024
Cesare Guzzardella
Ritornano a Milano
i concerti di Villa Mirabello
 Ritornano
a Villa Mirabello i concerti di musica classica
organizzati da Alessio Bidoli, violinista e
organizzatore di eventi musicali. Sono due serie
di serate previste nei mesi di marzo e di giugno.
Le prime tre nelle date del 7 marzo, del 14 e
del 21 marzo, avranno come protagonisti il
violoncellosta Vito Paternoster e il pianista
Pierluigi Camicia; seguirà il 14 marzo il
pianista Andrea Bacchetti e il 21 marzo è la
volta dell'Amaranta Trio con
Silvia Cattaneo al pianoforte, Stella Chiara
Cattaneo al violino ed Ester Vianello al
violoncello. Programmi variegati con brani noti
di eccellente qualità. Concerti imperdibili sia
per la rilevanza degli interpreti che per la
particolare storica location dove
avvengono le serate musicali. Siete tutti
invitati! Ritornano
a Villa Mirabello i concerti di musica classica
organizzati da Alessio Bidoli, violinista e
organizzatore di eventi musicali. Sono due serie
di serate previste nei mesi di marzo e di giugno.
Le prime tre nelle date del 7 marzo, del 14 e
del 21 marzo, avranno come protagonisti il
violoncellosta Vito Paternoster e il pianista
Pierluigi Camicia; seguirà il 14 marzo il
pianista Andrea Bacchetti e il 21 marzo è la
volta dell'Amaranta Trio con
Silvia Cattaneo al pianoforte, Stella Chiara
Cattaneo al violino ed Ester Vianello al
violoncello. Programmi variegati con brani noti
di eccellente qualità. Concerti imperdibili sia
per la rilevanza degli interpreti che per la
particolare storica location dove
avvengono le serate musicali. Siete tutti
invitati!
4 marzo 2024 Cesare
Guzzardella
Successo
al Teatro alla Scala per Madina con le
musiche di Fabio Vacchi e la coreografia di
Mauro Bigonzetti
È tornato
alla scala Madina, non solo un balletto ma
un'opera di Teatro-danza multiforme e
sfaccettata, che ebbe la prima rappresentazione
nell'ottobre del 2021. La pregnante musica di
Fabio Vacchi, di quasi ottanta minuti
nell'intensa orchestrazione di Michele Gamba, è
la componente unificante dei vari linguaggi
 presenti
nel riuscito lavoro. Danzatori, cantanti, attori,
video, immagini, si alternano, si integrano,
interagiscono nella prorompente musica del
compositore bolognese, musica che ha anche in sè
una grandiosa componente corale, preparata
dall'eccellente direttore di coro Alberto
Malazzi. Sembrano in antitesi, ma sono in realtà
complementari le solide strutture musicali di
Vacchi, ricche di emozioni, scritte ragionando
su ogni singola nota, in un linguaggio non
semplice ma accessibile all'ascolto, e la parte
visiva variegata, sempre in movimento, quella
inventata dal coreografo Mauro Bigonzetti, dallo
scenografo e ideatore delle luci presenti
nel riuscito lavoro. Danzatori, cantanti, attori,
video, immagini, si alternano, si integrano,
interagiscono nella prorompente musica del
compositore bolognese, musica che ha anche in sè
una grandiosa componente corale, preparata
dall'eccellente direttore di coro Alberto
Malazzi. Sembrano in antitesi, ma sono in realtà
complementari le solide strutture musicali di
Vacchi, ricche di emozioni, scritte ragionando
su ogni singola nota, in un linguaggio non
semplice ma accessibile all'ascolto, e la parte
visiva variegata, sempre in movimento, quella
inventata dal coreografo Mauro Bigonzetti, dallo
scenografo e ideatore delle luci
 Carlo
Cerri, dai video designer ( ancora Cerri, con
Alessandro Grisendi e Marco Noviello), dal
costumista Maurizio Millenotti. La protagonista
Madina, sempre riconoscibile nel suo costume
rosso acceso, è la superlativa ballerina
Antonella Albano. L'attore Francesco Aricò
declama ad alta voce i testi tratti dal romanzo
"La ragazza che non voleva morire" di Emmanuelle
de Villepin, autrice anche del libretto. Il
tenore Paolo Antognetti e il mezzo-soprano
Anna-Doris Capitelli si alternano nel cantare la
triste vicenda e sono rispettivamente
Sultan/Louis e Madina/Olga. Nella terza
rappresentazione, vista ieri sera in una Scala
al completo, l'eccellente Roberto Bolle è
Kamzan, lo zio di Madina che, divenuto
terrorista, vuole spingere la nipote a diventare
kamikaze. Gioacchino Starace è Louis,
caporedattore di un giornale francese Carlo
Cerri, dai video designer ( ancora Cerri, con
Alessandro Grisendi e Marco Noviello), dal
costumista Maurizio Millenotti. La protagonista
Madina, sempre riconoscibile nel suo costume
rosso acceso, è la superlativa ballerina
Antonella Albano. L'attore Francesco Aricò
declama ad alta voce i testi tratti dal romanzo
"La ragazza che non voleva morire" di Emmanuelle
de Villepin, autrice anche del libretto. Il
tenore Paolo Antognetti e il mezzo-soprano
Anna-Doris Capitelli si alternano nel cantare la
triste vicenda e sono rispettivamente
Sultan/Louis e Madina/Olga. Nella terza
rappresentazione, vista ieri sera in una Scala
al completo, l'eccellente Roberto Bolle è
Kamzan, lo zio di Madina che, divenuto
terrorista, vuole spingere la nipote a diventare
kamikaze. Gioacchino Starace è Louis,
caporedattore di un giornale francese
 che
ascolterà e incontrerà Olga- l'ottima Alessandra
Vassallo- , la zia russa di Madina di cui poi si
innamorerà. Il bravissimo Gabriele Corrado è
Sultan, il padre di Kamzan, che vuole salvare
Madina. Come racconta Fabio Vacchi "..Madina
si trova risucchiata da una spirale di violenza.
Non vuole uccidere. Ma si toglie la cintura
esplosiva sottraendosi all'attacco
omicida-suicida, sulla spinta di quell'istinto
di sopravvivenza che accomuna gli abitanti della
Terra..". Nel disinnescare la cintura
esplosiva morirà l'artificiere. Madina verrà
processata e condannata. Kamzan sarà ucciso. che
ascolterà e incontrerà Olga- l'ottima Alessandra
Vassallo- , la zia russa di Madina di cui poi si
innamorerà. Il bravissimo Gabriele Corrado è
Sultan, il padre di Kamzan, che vuole salvare
Madina. Come racconta Fabio Vacchi "..Madina
si trova risucchiata da una spirale di violenza.
Non vuole uccidere. Ma si toglie la cintura
esplosiva sottraendosi all'attacco
omicida-suicida, sulla spinta di quell'istinto
di sopravvivenza che accomuna gli abitanti della
Terra..". Nel disinnescare la cintura
esplosiva morirà l'artificiere. Madina verrà
processata e condannata. Kamzan sarà ucciso.
 Una
vicenda attualissima dove il territorio ceceno,
in cui si svolge il dramma, potrebbe essere
sostituito da altri dove oggi si combattono
guerre sanguinose e si commettono terribili
atrocità. La formula del teatro-danza di Vacchi
è in Madina perfettamente realizzata, grazie
anche alle grandi qualità di Manuel Legris,
direttore del Corpo di Ballo scaligero. Un
lavoro eccellente, imperdibile, che avrà ancora
tre repliche il 6, il 7 e il 9 marzo. (
prime due foto di Brescia, Amisano, Archivio
Scala) Una
vicenda attualissima dove il territorio ceceno,
in cui si svolge il dramma, potrebbe essere
sostituito da altri dove oggi si combattono
guerre sanguinose e si commettono terribili
atrocità. La formula del teatro-danza di Vacchi
è in Madina perfettamente realizzata, grazie
anche alle grandi qualità di Manuel Legris,
direttore del Corpo di Ballo scaligero. Un
lavoro eccellente, imperdibile, che avrà ancora
tre repliche il 6, il 7 e il 9 marzo. (
prime due foto di Brescia, Amisano, Archivio
Scala)
3 marzo 2024
Cesare Guzzardella
Arthur & Lucas Jussen
diretti da Jaume Santonja in Béla Bartók
Sono
tornati in Auditorium con l'Orchestra Sinfonica
di Milano i pianisti Arthur & Lucas Jussen
per interpretare Béla Bartók sotto la
direzione di Jaume Santonja, Direttore Ospite
Principale della Sinfonica milanese e molto
presente nella sala concertistica. L'impaginato
prevedeva una prima parte del concerto
interamente
 dedicata
alle musiche del compositore ungherese: prima i
Canti contadini ungheresi e poi il
Concerto per due pianoforti, percussioni e
orchestra Sz.115. Dopo l'intervallo, cambio
di registro con la celebre Sinfonia n.2 in re
maggiore op.73 di Johannes Brahms.
L'anticipazione orchestrale bartókiana dei
folcloristici Canti contadini ungheresi
(1914-18) ha rivelato i primi lavori di Bartók
(1881-1945) composti in età giovanile con un
linguaggio comprensibile, immediato, ma già
tipico delle modalità di scrittura bartókiane.
Sono una serie di canti molto ritmati,
orchestrati nel 1933 e presi dalla tradizione
popolare ungherese. Ottima la resa espressiva di
Santonja e degli orchestrali. Un Bartók più
evoluto ed emancipato è invece quello del
secondo brano. Il Concerto Sz. 115 dedicata
alle musiche del compositore ungherese: prima i
Canti contadini ungheresi e poi il
Concerto per due pianoforti, percussioni e
orchestra Sz.115. Dopo l'intervallo, cambio
di registro con la celebre Sinfonia n.2 in re
maggiore op.73 di Johannes Brahms.
L'anticipazione orchestrale bartókiana dei
folcloristici Canti contadini ungheresi
(1914-18) ha rivelato i primi lavori di Bartók
(1881-1945) composti in età giovanile con un
linguaggio comprensibile, immediato, ma già
tipico delle modalità di scrittura bartókiane.
Sono una serie di canti molto ritmati,
orchestrati nel 1933 e presi dalla tradizione
popolare ungherese. Ottima la resa espressiva di
Santonja e degli orchestrali. Un Bartók più
evoluto ed emancipato è invece quello del
secondo brano. Il Concerto Sz. 115
 prevede
due pianoforti e l'uso di una serie di
percussioni, ieri sera nelle mani di Viviana
Mologni e di Simone Beneventi. Il corposo
concerto ha anche timbriche percussive nei
pianoforti. Il brano, particolarmente
caratterizzante della modernità del grande
compositore ungherese, è stato composto tra il
1938 e il 1940, quindi è un lavoro decisamente
maturo. L'interpretazione, non facile, è stata
affrontata con determinazione dai quattro
protagonisti. I fratelli, nella suddivisione
della parte pianistica, hanno interagito con le
percussioni creando un'atmosfera scura e
suggestivamente barbarica nei tre densi
movimenti che formano il brano: Assai lento,
Lento ma non troppo e Allegro non troppo.
Ottima la resa complessiva e applausi fragorosi
al termine per tutti i protagonisti. Bis per due
pianoforti di grande levatura estetica quello
concesso dai Jussen con il brano prevede
due pianoforti e l'uso di una serie di
percussioni, ieri sera nelle mani di Viviana
Mologni e di Simone Beneventi. Il corposo
concerto ha anche timbriche percussive nei
pianoforti. Il brano, particolarmente
caratterizzante della modernità del grande
compositore ungherese, è stato composto tra il
1938 e il 1940, quindi è un lavoro decisamente
maturo. L'interpretazione, non facile, è stata
affrontata con determinazione dai quattro
protagonisti. I fratelli, nella suddivisione
della parte pianistica, hanno interagito con le
percussioni creando un'atmosfera scura e
suggestivamente barbarica nei tre densi
movimenti che formano il brano: Assai lento,
Lento ma non troppo e Allegro non troppo.
Ottima la resa complessiva e applausi fragorosi
al termine per tutti i protagonisti. Bis per due
pianoforti di grande levatura estetica quello
concesso dai Jussen con il brano
 "La
Coquette", dalla Suite n.2 "Silhouettes"
del russo Anton Arenskij (1861-1906) . Dopo
l'intervallo la calebre Sinfonia n.2 op.73
di Brahms (1877) ha trovato un'ottima resa
nella direzione di Santonja con un andatura
riflessiva nell'Allegro non troppo
iniziale e un'andatura piuttosto spedita e
contrastata nel quarto movimento, Allegro con
spirito. Chiare le timbriche delle sezioni
orchestrali anche nell'Adagio e nell'Allegretto
giocoso. Applausi sostenuti dal numeroso
pubblico intervenuto in Auditorium. Domani,
domenica, alle ore 16.00 la replica. Da non
perdere! "La
Coquette", dalla Suite n.2 "Silhouettes"
del russo Anton Arenskij (1861-1906) . Dopo
l'intervallo la calebre Sinfonia n.2 op.73
di Brahms (1877) ha trovato un'ottima resa
nella direzione di Santonja con un andatura
riflessiva nell'Allegro non troppo
iniziale e un'andatura piuttosto spedita e
contrastata nel quarto movimento, Allegro con
spirito. Chiare le timbriche delle sezioni
orchestrali anche nell'Adagio e nell'Allegretto
giocoso. Applausi sostenuti dal numeroso
pubblico intervenuto in Auditorium. Domani,
domenica, alle ore 16.00 la replica. Da non
perdere!
2 marzo 2024
Cesare Guzzardella
FEBBRAIO 2024
Ai Pomeriggi Musicali del Dal
Verme due brani tra i più popolari diretti da
George Pehlivanian
Il Concerto n.1 per
pianoforte e orchestra op.23 di
Čaikovskij
e la Sinfonia op.95 "Dal Nuovo Mondo" di
Dvořák godono di una
popolarità universale per la orecchiabilità dei
principali temi conduttori. Il Concerto in Si
bem.maggiore del grande russo rappresenta
anche un campo di battaglia di virtuosismo per i
migliori pianisti, unitamente alla non facile
capacità di dare
 espressività alla melodicità
sempre presente, come nel pregnante Andantino
semplice centrale. Al pianoforte questa
mattina c'era un giovanissimo virtuoso, per la
prima volta in Italia: Roman Borisov. espressività alla melodicità
sempre presente, come nel pregnante Andantino
semplice centrale. Al pianoforte questa
mattina c'era un giovanissimo virtuoso, per la
prima volta in Italia: Roman Borisov.
 Ad ascoltarlo all'anteprima, un pubblico con anche
centinaia di studenti provenienti dalle scuole
milanesi. Borisov, siberiano nato nel 2002, ha
vinto prestigiosi concorsi internazionali e ha
già frequentato le più importanti sale da
concerto europee. Coadiuvato ottimamente dalla
direzione del franco- americano George
Pehlivanian, direttore spesso presente ai
Pomeriggi Musicali , ha sostenuto con
disinvoltura discorsiva sia le parti più
melodiche del concerto, sia i momenti più
virtuosistici espressi con decisione unitamente Ad ascoltarlo all'anteprima, un pubblico con anche
centinaia di studenti provenienti dalle scuole
milanesi. Borisov, siberiano nato nel 2002, ha
vinto prestigiosi concorsi internazionali e ha
già frequentato le più importanti sale da
concerto europee. Coadiuvato ottimamente dalla
direzione del franco- americano George
Pehlivanian, direttore spesso presente ai
Pomeriggi Musicali , ha sostenuto con
disinvoltura discorsiva sia le parti più
melodiche del concerto, sia i momenti più
virtuosistici espressi con decisione unitamente
 ad una leggerezza assai producente. Ottima la
lunga cadenza dell'Allegro non troppo
iniziale, elargita con passione e rigore tecnico.
Applausi calorosi. Dopo il breve intervallo,
decisa e piena d'energia la Sinfonia in Mi
minore "Dal Nuovo Mondo" del musicista ceco.
Di pregio la sinergia tra Pehlivanian e gli
orchestrali e validi i numerosi interventi
solistici del celebre, ma non unico, capolavoro
di Antonin Dvořák.
Applausi calorosissimi. Questa sera alle
ore
20.00 la prima ufficiale e sabato alle 17.00 la
replica. Da non perdere! ad una leggerezza assai producente. Ottima la
lunga cadenza dell'Allegro non troppo
iniziale, elargita con passione e rigore tecnico.
Applausi calorosi. Dopo il breve intervallo,
decisa e piena d'energia la Sinfonia in Mi
minore "Dal Nuovo Mondo" del musicista ceco.
Di pregio la sinergia tra Pehlivanian e gli
orchestrali e validi i numerosi interventi
solistici del celebre, ma non unico, capolavoro
di Antonin Dvořák.
Applausi calorosissimi. Questa sera alle
ore
20.00 la prima ufficiale e sabato alle 17.00 la
replica. Da non perdere!
29 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
L'Orchestra UNIMI
diretta Hankyeol Yoon
L'Orchestra dell'Università
agli Studi di Milano da molti anni ha una valida
programmazione e trova anche ottime direzioni e
validi solisti, oltre a mettere in risalto anche
brani del nostro tempo, alcuni commissionati a
giovani compositori dall'orchestra stessa.
 Ieri
nell'Aula Magna dell'Università Statale, colma
di spettatori, un ottimo direttore emergente
come il sud-coreano Hankyeol Yoon, vincitore nel
2023 del Premio Herbert von Karajan per
giovani direttori d'orchestra, è riuscito ha
produrre ottime esecuzioni dai giovani
orchestrali. Tre i brani in programma.
Il
primo era una commissione dell'Orchestra
UNIMI
a Leonardo Damiani, recente vincitore
del Premio di composizione del Conservatorio
milanese. Il suo Un azzurro intenso, senza
pietà, lavoro del 2023, prevedeva uno raro
strumento solista quale l'eufonio, un ottone con
sonorità particolarmente penetranti Ieri
nell'Aula Magna dell'Università Statale, colma
di spettatori, un ottimo direttore emergente
come il sud-coreano Hankyeol Yoon, vincitore nel
2023 del Premio Herbert von Karajan per
giovani direttori d'orchestra, è riuscito ha
produrre ottime esecuzioni dai giovani
orchestrali. Tre i brani in programma.
Il
primo era una commissione dell'Orchestra
UNIMI
a Leonardo Damiani, recente vincitore
del Premio di composizione del Conservatorio
milanese. Il suo Un azzurro intenso, senza
pietà, lavoro del 2023, prevedeva uno raro
strumento solista quale l'eufonio, un ottone con
sonorità particolarmente penetranti
 suonato dalla bravissima Marina Boselli, anche
lei vincitrice del Premio del Conservatorio di
Milano nel 2022 come migliore strumentista
dell'anno. Il concerto serale era stato
preceduto da un incontro presieduto da Francesco
Antonioni - compositore e organizzatore- con i
tre protagonisti citati che hanno chiarito molti
aspetti della loro attività e del concerto
serale. Il brano di Damiani, compositore nato a
Perugia nel 1991, attraverso sonorità penetranti
dell'orchestra, ha messo in risalto le timbriche
particolari dell'eufonio, in un dialogo
denso di effetti sonori ben costruiti e
d'intensa suggestione. Molto brava la Boselli ad
esprimere le non facili sonorità del suo
ingombrante strumento. Yoon, direttore e suonato dalla bravissima Marina Boselli, anche
lei vincitrice del Premio del Conservatorio di
Milano nel 2022 come migliore strumentista
dell'anno. Il concerto serale era stato
preceduto da un incontro presieduto da Francesco
Antonioni - compositore e organizzatore- con i
tre protagonisti citati che hanno chiarito molti
aspetti della loro attività e del concerto
serale. Il brano di Damiani, compositore nato a
Perugia nel 1991, attraverso sonorità penetranti
dell'orchestra, ha messo in risalto le timbriche
particolari dell'eufonio, in un dialogo
denso di effetti sonori ben costruiti e
d'intensa suggestione. Molto brava la Boselli ad
esprimere le non facili sonorità del suo
ingombrante strumento. Yoon, direttore e
 anche
compositore, ha condotto molto bene l'esecuzione
entrando nei non semplici dettagli coloristici.
Lavoro molto applaudito e compositore in
palcoscenico con i protagonisti. La serata è
continuata con l'esecuzione di due noti brani:
prima l'Ouverture, il Notturno e
lo Scherzo dalla Suite Sogno da una
notte di mezza estate (1846) di
F.Mendelssohn; poi la Sinfonia n.38 in re
maggiore "Praga" (1786) di W.A. Mozart.
Soprattutto in quest'ultimo capolavoro del
salisburghese il direttore Hankyeol Yoon ha
esaltato i potenziali degli orchestrali per un
interpretazione di ottima qualità. Applausi
calorosi a tutti i protagonisti e ripetizione
del bellissimo ultimo movimento
Finale.
Presto. anche
compositore, ha condotto molto bene l'esecuzione
entrando nei non semplici dettagli coloristici.
Lavoro molto applaudito e compositore in
palcoscenico con i protagonisti. La serata è
continuata con l'esecuzione di due noti brani:
prima l'Ouverture, il Notturno e
lo Scherzo dalla Suite Sogno da una
notte di mezza estate (1846) di
F.Mendelssohn; poi la Sinfonia n.38 in re
maggiore "Praga" (1786) di W.A. Mozart.
Soprattutto in quest'ultimo capolavoro del
salisburghese il direttore Hankyeol Yoon ha
esaltato i potenziali degli orchestrali per un
interpretazione di ottima qualità. Applausi
calorosi a tutti i protagonisti e ripetizione
del bellissimo ultimo movimento
Finale.
Presto.
28 febbraio 2024 Cesare Guzzardella
Il pianista Roberto
Cappello
alle
Serate Musicali del
Conservatorio milanese
Torna
puntualmente il pianista pugliese Roberto
Cappello ai concerti organizzati da "Serate
Musicali". Ieri un impaginato denominato "Il
canto dell'anima" ha raggiunto certamente i
cuori dei presenti in Sala Verdi. La scelta di
pagine arcinote era suddivisa in due importanti
momenti musicali: prima opere di L.V. Beethoven
e poi quelle di F. Chopin. Due mondi sonori
 parzialmente
in contrasto, che hanno in comune una profondità
di scrittura compositiva che arriva rapidamente
nel mondo delle emozioni di ogni appassionato di
musica. Cappello ha iniziato il concerto con la
Sonata n.14 in do diesis minore "Al chiaro di
luna" per proseguire con la Sonata n.23
in fa minore "Appassionata". Tra le più
eseguite del genio tedesco, entrambe presentano
situazioni dove la struttura musicale più
semplice deve essere riempita dalla forza di
penetrazione dell'interprete, con una carica di
espressività che solo eccellenti pianisti
possono far emergere. Altri movimenti sono più
virtuosistici. Mi riferisco soprattutto al
celebre Adagio sostenuto, movimento
iniziale della Sonata op.27 n.2 "Al chiaro di
luna". Cappello, con un'andatura
particolarmente riflessiva ha dato spessore
straordinario alle centellinate note del tema
iniziale, creando forti emozioni nel perfetto
equilibrio delle componenti melodico-armoniche.
Entrambe le sonate beethoveniane hanno rivelato
lo spessore interpretativo di un pianista che
cerca il più possibile la creazione di forti
contrasti, sempre mantenendo una bellezza
significativa delle timbriche. Sia il Presto
agitato parzialmente
in contrasto, che hanno in comune una profondità
di scrittura compositiva che arriva rapidamente
nel mondo delle emozioni di ogni appassionato di
musica. Cappello ha iniziato il concerto con la
Sonata n.14 in do diesis minore "Al chiaro di
luna" per proseguire con la Sonata n.23
in fa minore "Appassionata". Tra le più
eseguite del genio tedesco, entrambe presentano
situazioni dove la struttura musicale più
semplice deve essere riempita dalla forza di
penetrazione dell'interprete, con una carica di
espressività che solo eccellenti pianisti
possono far emergere. Altri movimenti sono più
virtuosistici. Mi riferisco soprattutto al
celebre Adagio sostenuto, movimento
iniziale della Sonata op.27 n.2 "Al chiaro di
luna". Cappello, con un'andatura
particolarmente riflessiva ha dato spessore
straordinario alle centellinate note del tema
iniziale, creando forti emozioni nel perfetto
equilibrio delle componenti melodico-armoniche.
Entrambe le sonate beethoveniane hanno rivelato
lo spessore interpretativo di un pianista che
cerca il più possibile la creazione di forti
contrasti, sempre mantenendo una bellezza
significativa delle timbriche. Sia il Presto
agitato
 finale
del "Chiaro di luna", che l'Allegro ma
non troppo, finale dell'Appassionata,
hanno poi evidenziato il forte segno timbrico
dell'interprete in una tessitura robusta, un
segno certamente vicino al tormentato carattere
beethoveniano. Esecuzioni prestigiose. Senza
intervallo, Cappello è passato al linguaggio
chopiniano, un mondo diverso quello dei celebri
Valzer, tra i quali il pianista ne ha
selezionati otto, i più celebri. Partendo da
quelli brillanti, il primo era proprio il
Grande Valzer brillante in mi bem.maggiore
op.18. L'alternanza tra i valzer in
maggiore e in minore, con andature a
volte rapide alternate ad altre molto riflessive,
ci hanno rivelato il mondo chopiniano di
Cappello. Dopo l'op.18 ha eseguito l'op.
34 n.1 e n.2, l'op.42, l'op.64
n.2, l'op.69 n.1, l'op. 70 n.1
e il Valzer in mi minore KK IV n.15.
Interpretazioni coerenti, articolate, che
scavano in profondità nelle timbriche. I valzer
in minore hanno trovato andature particolarmente
riflessive riempite di carattere e in contrasto
con momenti di discorsività virtuosistica
espressa brillantemente e con grande chiarezza
negli ampi registri del pianoforte. Il virtuoso
ha poi concluso l'impaginato chopiniano con
un'eccellente Polacca op. 53 "Eroica",
dimostrando una tenuta complessiva esemplare,
vista la lunghezza del programma. Ha concesso
anche due bis: prima uno Studio di
Chopin, il n.12 in do minore op.25 e poi
un Beethoven meditato con il movimento centrale,
Adagio cantabile, della Sonata "Patetica"
. Ottimi entrambi. Applausi fragorosi dal
pubblico presente in Sala Verdi
per una serata straordinaria. finale
del "Chiaro di luna", che l'Allegro ma
non troppo, finale dell'Appassionata,
hanno poi evidenziato il forte segno timbrico
dell'interprete in una tessitura robusta, un
segno certamente vicino al tormentato carattere
beethoveniano. Esecuzioni prestigiose. Senza
intervallo, Cappello è passato al linguaggio
chopiniano, un mondo diverso quello dei celebri
Valzer, tra i quali il pianista ne ha
selezionati otto, i più celebri. Partendo da
quelli brillanti, il primo era proprio il
Grande Valzer brillante in mi bem.maggiore
op.18. L'alternanza tra i valzer in
maggiore e in minore, con andature a
volte rapide alternate ad altre molto riflessive,
ci hanno rivelato il mondo chopiniano di
Cappello. Dopo l'op.18 ha eseguito l'op.
34 n.1 e n.2, l'op.42, l'op.64
n.2, l'op.69 n.1, l'op. 70 n.1
e il Valzer in mi minore KK IV n.15.
Interpretazioni coerenti, articolate, che
scavano in profondità nelle timbriche. I valzer
in minore hanno trovato andature particolarmente
riflessive riempite di carattere e in contrasto
con momenti di discorsività virtuosistica
espressa brillantemente e con grande chiarezza
negli ampi registri del pianoforte. Il virtuoso
ha poi concluso l'impaginato chopiniano con
un'eccellente Polacca op. 53 "Eroica",
dimostrando una tenuta complessiva esemplare,
vista la lunghezza del programma. Ha concesso
anche due bis: prima uno Studio di
Chopin, il n.12 in do minore op.25 e poi
un Beethoven meditato con il movimento centrale,
Adagio cantabile, della Sonata "Patetica"
. Ottimi entrambi. Applausi fragorosi dal
pubblico presente in Sala Verdi
per una serata straordinaria.
27 febbraio 2024
Cesare Guzzardella
Il violinista Luca Kaufman
per Musica Maestri!
in Conservatorio
Il
giovanissimo violinista Luca Kaufman ha vinto
nel 2023 il primo Premio come migliore
strumentista del Consevatorio milanese. Lo
conosciamo bene avendolo già ascoltato nella
nota formazione cameristica del Trio Kaufman,
insieme alla gemella Chiara, violoncellista, e
alla sorella maggiore Valentina, pianista. Ieri
per la rassegna "Musica Maestri!", nel
tardo pomeriggio si è presentato in Sala Puccini
insieme alla valida pianista Eunmi Park per un
impaginato classico con brani di cinque
compositori:
 Beethoven (1770-1827), Brahms
(1833-1897), Grieg (1843-1907), Kreisler
(1875-1962) e Wieniawski (1835-1880). L'ottima
intesa tra i due giovane è apparsa da subito
nella Sonata per violino e pianoforte n. 8 in
sol maggiore op. 30 n. 3 del primo grande
compositore tedesco. Una discorsività resa con
disinvoltura da entrambi gli interpreti. Il
celebre Scherzo in do minore dalla
Sonata F.A.E. di Johannes Brahms ha quindi
restituito un virtuosismo più ricco specie nella
componente violinistica di Kaufman e anche nella
successiva e rara Sonata n. 2 in solo minore
op. 13 di Edvard Grieg Beethoven (1770-1827), Brahms
(1833-1897), Grieg (1843-1907), Kreisler
(1875-1962) e Wieniawski (1835-1880). L'ottima
intesa tra i due giovane è apparsa da subito
nella Sonata per violino e pianoforte n. 8 in
sol maggiore op. 30 n. 3 del primo grande
compositore tedesco. Una discorsività resa con
disinvoltura da entrambi gli interpreti. Il
celebre Scherzo in do minore dalla
Sonata F.A.E. di Johannes Brahms ha quindi
restituito un virtuosismo più ricco specie nella
componente violinistica di Kaufman e anche nella
successiva e rara Sonata n. 2 in solo minore
op. 13 di Edvard Grieg
 abbiamo trovato uno
spessore interpretativo già maturo. Con il
Recitativo e Scherzo op. 6 di Fritz
Kreisler, brano per violino solo, le qualità
virtuosistiche ed espressive del violino di
Kaufman si sono ancor più rivelate. È un brano
assai difficile, con difficoltà tecniche
presenti in ogni registro e complessità superate
con facilità dal virtuoso diciannovenne.
L'ultimo brano in programna, lo Scherzo
tarantelle op.16 di Henryk Wieniawski, era
ancora all'insegna delle più ardite difficoltà
in un contesto con andatura molto rapida che
necessita di grande fluidità anche nella parte
pianistica. Ottima la resa del duo tra
gli applausi sostenuti e ripetuti dal pubblico
presente nell'affollata Sala Puccini del
Conservatorio milanese. Bis all'insegna del
folclore con una Polka di Sasha
Rozhdestvenski che ha strappato ancora fragorosi
applausi. Bravissimi. abbiamo trovato uno
spessore interpretativo già maturo. Con il
Recitativo e Scherzo op. 6 di Fritz
Kreisler, brano per violino solo, le qualità
virtuosistiche ed espressive del violino di
Kaufman si sono ancor più rivelate. È un brano
assai difficile, con difficoltà tecniche
presenti in ogni registro e complessità superate
con facilità dal virtuoso diciannovenne.
L'ultimo brano in programna, lo Scherzo
tarantelle op.16 di Henryk Wieniawski, era
ancora all'insegna delle più ardite difficoltà
in un contesto con andatura molto rapida che
necessita di grande fluidità anche nella parte
pianistica. Ottima la resa del duo tra
gli applausi sostenuti e ripetuti dal pubblico
presente nell'affollata Sala Puccini del
Conservatorio milanese. Bis all'insegna del
folclore con una Polka di Sasha
Rozhdestvenski che ha strappato ancora fragorosi
applausi. Bravissimi.
26 febbraio 2024
Cesare
Guzzardella
Successo all'ultima
recita di
Simon Boccanegra
alla Scala
Ieri
l'ultima replica del verdiano Simon
Boccanegra al Teatro alla Scala ha trovato
uno straordinario successo di pubblico. È stato
scritto molto su questa messinscena di Daniele
Abbado con giudizi per lo più concordanti sui
vari aspetti che non hanno soddisfatto
pienamente la critica. La debolezza complessiva
della regia, specie in alcuni frangenti, ha
trovato in contrapposizione una resa
ineccepibile nella direzione di Lorenzo Viotti.
Il direttore
 svizzero-
di origine italo-francese- ha proposto un
eccellente equilibrio nel dosaggio tra la
componente orchestrale, le voci soliste e
l'ottimo Coro preparato da Alberto Malazzi. Nei
momenti dove le sonorità orchestrali raggiungono
vette "sinfoniche", e in questa opera in un
Prologo e tre atti, sono molti - come nella
toccante orchestrazione dell'ultimo atto- Viotti
ha rivelato ancor più le sue alte qualità
direttoriali. Le aveva dimostrate alcuni giorni
prima nel bellissimo concerto sinfonico
replicato due volte. Voce centrale per ruolo,
certamente la più rilevante timbricamente, è
stata quella di Luca Salsi, un Simon
Boccanegra che da solo svizzero-
di origine italo-francese- ha proposto un
eccellente equilibrio nel dosaggio tra la
componente orchestrale, le voci soliste e
l'ottimo Coro preparato da Alberto Malazzi. Nei
momenti dove le sonorità orchestrali raggiungono
vette "sinfoniche", e in questa opera in un
Prologo e tre atti, sono molti - come nella
toccante orchestrazione dell'ultimo atto- Viotti
ha rivelato ancor più le sue alte qualità
direttoriali. Le aveva dimostrate alcuni giorni
prima nel bellissimo concerto sinfonico
replicato due volte. Voce centrale per ruolo,
certamente la più rilevante timbricamente, è
stata quella di Luca Salsi, un Simon
Boccanegra che da solo
 ha
alzato il livello scenico. Di qualità e spesso
pregnante per bellezza timbrica, Irina Lungu,
un' Amelia (Maria) inizialmente non molto
voluminosa ma poi in netto miglioramento. La
Lungu ha sostituito nelle ultime due recite
Anita Hartig assente per motivi di salute.
Matteo Lippi, Gabriele Adorno, ha fatto
bene la sua parte esprimendo un sicuro timbro
tondo tenorile. Sottotono Ain Anger, Jacopo
Fiesco, un basso dalla voluminosità non
sempre adeguata. Bene Roberto De Candia,
Paolo Albiani, Andrea Pellegrini, Pietro
e gli altri. Da questa sera e per sei
rappresentazioni, il teatro scaligero propone di
W.A.Mozart "Die Entführung Aus Dem Serail",
singspiel in tre atti in tedesco. La regia è
quella storica di Goorgio Strehler, con scene e
costumi di Luciano Damiani. Alla direzione il
giovane Thomas Guggeis. Da non perdere! ha
alzato il livello scenico. Di qualità e spesso
pregnante per bellezza timbrica, Irina Lungu,
un' Amelia (Maria) inizialmente non molto
voluminosa ma poi in netto miglioramento. La
Lungu ha sostituito nelle ultime due recite
Anita Hartig assente per motivi di salute.
Matteo Lippi, Gabriele Adorno, ha fatto
bene la sua parte esprimendo un sicuro timbro
tondo tenorile. Sottotono Ain Anger, Jacopo
Fiesco, un basso dalla voluminosità non
sempre adeguata. Bene Roberto De Candia,
Paolo Albiani, Andrea Pellegrini, Pietro
e gli altri. Da questa sera e per sei
rappresentazioni, il teatro scaligero propone di
W.A.Mozart "Die Entführung Aus Dem Serail",
singspiel in tre atti in tedesco. La regia è
quella storica di Goorgio Strehler, con scene e
costumi di Luciano Damiani. Alla direzione il
giovane Thomas Guggeis. Da non perdere!
25 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
IL
FLAUTO DI ALBERTO NAVARRA PROTAGONISTA AL
VIOTTIFESTIVAL DI VERCELLI
Ieri
sera, sabato 24 febbraio, il Teatro Civico di
Vercelli ha ospitato, nell'ambito del XXVI
ViottiFestival, un recital del giovane, ma ormai
affermato flautista Alberto Navarra. Piemontese
di Mondovì, ove è nato nel 1997, è stato
lanciato nell'orbita dello 'star system' della 'classica'
dal primo premio al concorso flautistico
internazionale Carl Nielsen 2022, uno dei più
importanti concorsi per questo strumento, che
gli ha spalancato le porte della più grande
orchestra al mondo, i Berliner Philarmoniker.
Sul palcoscenico del Civico era presente anche
il Camerata Ducale Ensemble, un quartetto
d'archi formato da Paolo Chiesa e Giacomo Lucato
(violini), Lorenzo Lombardo (viola) e Giorgio
Lucchini (violoncello). Il compito di dare
inizio al concerto è stato affidato, com'era
giusto nel bicentenario viottiano, al quartetto
per flauto, violino, viola e violoncello in Do
min. WII: 17 di G. B. Viotti, composto dal
musicista vercellese a Londra intorno al 1806
per l'amico violinista e flautista Philip
Cipriani Potter. Il 'periodo londinese' segna la
piena maturità del compositore e violinista di
Fontanetto Po. E' un'opera, aggiungiamo noi,
appartenente a quel mondo musicale avvolto
ancora nella penombra di un quasi totale oblio,
che è la musica cameristica di Viotti, e perciò
tanto più interessante. Questo quartetto si
distingue per il pieno dominio della forma, che
è quella, per quanto finora ci è dato conoscere,
tipica dei quartetti di Viotti e che definiremmo
'brillante-dialogata', un garbato, elegante,
raffinato e continuo dialogo tra gli strumenti,
in cui peraltro a dominare sono il flauto e il
violino che guidano il vario succedersi delle
linee tematiche. È, inoltre, un quartetto
scritto
 chiaramente
da un violinista, ove il flauto è, in molti
momenti significativi della composizione, in
tutto e per tutto un primo violino (e infatti di
questo quartetto esiste anche una versione per
soli archi). Il tempo più riccamente elaborato è
il primo, in cui l'ascoltatore è subito attratto
dall'agogica di crescente intensità, ove è da
ammirare il sottile gioco della timbrica che
l'intrecciarsi di flauto e violino avvolge in un
raffinato velo sonoro. Un gioiello di eleganza,
ove senti ancora affiorare l'ultima eco dello
stile galante. Nel Menuetto (sic) centrale,
forse il tempo più riuscito del quartetto,
erompono tutta la fresca vitalità e la grazia,
che è uno dei tratti inconfondibili della musica
di Viotti che lo lega ancora ad un clima
musicale settecentesco. L'Allegro agitato e con
fuoco finale risente di una temperie
preromantica, ma non si sottrae a quel vigile
controllo formale che è un altro dei caratteri
inconfondibile della musica di Viotti, alieno,
almeno in questo quartetto, da
quell'inquietudine cupa che è tipica del do
minore mozartiano e successivamente esasperata
da Beethoven e dai Romantici. Ottima
l'esecuzione a cominciare dal flauto di Navarra,
distintosi per il suono pulito e cristallino,
sostenuto da un'emissione del fiato sempre
aperta ed elastica nel restituire le varie
dinamiche del pezzo, e di grande fluidità nei
cambi di registro: il risultato è quello di un
suono capace di potenziare al massimo la grazia
tipica del flauto, che brilla ed incanta nelle
note alte del registro acuto. Ma un plauso
convinto spetta anche agli archi, che hanno
dialogato con perfetta intesa col flauto, sempre
precisi e sicuri nelle entrate, ottimi nella
gestione dei timbri e delle dinamiche. Tipico
esempio di quartetto 'concertante' è invece il
successivo quartetto in Re magg. KV 285 di
Mozart, composto un trentennio prima del
quartetto di Viotti. Qui ai momenti 'dialogici'
si alternano momenti in cui il flauto acquista
decisamente il ruolo di strumento solista,
specie nell'Adagio centrale, che è praticamente
un assolo del flauto, con il delicato
accompagnamento in pizzicato degli archi. Con il
quartetto KV 285 la magia creatrice di Mozart ci
regala un gioiello musicale anche per uno
strumento che il compositore dichiarava di "non
sopportare" (ed è, per l'autore del "Flauto
magico" dichiarazione un po' paradossale). È
chiaro però che le parole del genio
salisburghese vanno riferite al flauto del suo
tempo, ben lontano per qualità di suono,
intonazione e volume dal flauto moderno. In
questo pezzo Navarra mostra tutte le sue doti di
virtuoso e la perfetta padronanza tecnica dello
strumento nel primo movimento in Allegro,
soprattutto nella ripresa, con trilli, balzi
bruschi di ottave e di registri, il tutto
eseguito con quella splendida fluidità e purezza
di suono che contraddistinguono lo stile del
flautista monregalese.
L'Adagio poi, si diceva, è
un assolo in cui il flauto è sfidato da Mozart
ad esprimere tutte le sue potenzialità
espressive, con una melodia cui la dolcezza di
suono di Navarra dona un'intensità e una carica
sentimentale, capaci di suscitare profonda
emozione nell'ascoltatore. Ma, ancora una volta,
va citata l'ottima prestazione degli archi, in
particolare nell'Allegro iniziale, ove, nella
sezione sviluppo, presenta un ricco avvicendarsi
di chiaroscuri, con il ricorso frequente al tono
minore, eseguiti al meglio dal flauto e dagli
archi, anche con una calibratura finissima delle
dinamiche. All'insegna della più pura grazia
mozartiana il Rondò finale, in cui tutti gli
strumenti, intrecciando variamente le entrate,
concorrono, con eleganza e finezza di suono, a
confezionare un pezzo di delizioso abbandono
alla gioia del fare (e ascoltare) musica. Con un
brusco salto ai nostri giorni, il programma del
concerto prevedeva un pezzo per flauto
violoncello e gong, la Petite suite, composto da
Joerg Widmann (che è un grande clarinettista)
nel 2016, come 'tombeau' alla flautista svizzera
Aurèle Nicolet, allora da poco scomparsa,
suddiviso in tre tempi, chiaramente
da un violinista, ove il flauto è, in molti
momenti significativi della composizione, in
tutto e per tutto un primo violino (e infatti di
questo quartetto esiste anche una versione per
soli archi). Il tempo più riccamente elaborato è
il primo, in cui l'ascoltatore è subito attratto
dall'agogica di crescente intensità, ove è da
ammirare il sottile gioco della timbrica che
l'intrecciarsi di flauto e violino avvolge in un
raffinato velo sonoro. Un gioiello di eleganza,
ove senti ancora affiorare l'ultima eco dello
stile galante. Nel Menuetto (sic) centrale,
forse il tempo più riuscito del quartetto,
erompono tutta la fresca vitalità e la grazia,
che è uno dei tratti inconfondibili della musica
di Viotti che lo lega ancora ad un clima
musicale settecentesco. L'Allegro agitato e con
fuoco finale risente di una temperie
preromantica, ma non si sottrae a quel vigile
controllo formale che è un altro dei caratteri
inconfondibile della musica di Viotti, alieno,
almeno in questo quartetto, da
quell'inquietudine cupa che è tipica del do
minore mozartiano e successivamente esasperata
da Beethoven e dai Romantici. Ottima
l'esecuzione a cominciare dal flauto di Navarra,
distintosi per il suono pulito e cristallino,
sostenuto da un'emissione del fiato sempre
aperta ed elastica nel restituire le varie
dinamiche del pezzo, e di grande fluidità nei
cambi di registro: il risultato è quello di un
suono capace di potenziare al massimo la grazia
tipica del flauto, che brilla ed incanta nelle
note alte del registro acuto. Ma un plauso
convinto spetta anche agli archi, che hanno
dialogato con perfetta intesa col flauto, sempre
precisi e sicuri nelle entrate, ottimi nella
gestione dei timbri e delle dinamiche. Tipico
esempio di quartetto 'concertante' è invece il
successivo quartetto in Re magg. KV 285 di
Mozart, composto un trentennio prima del
quartetto di Viotti. Qui ai momenti 'dialogici'
si alternano momenti in cui il flauto acquista
decisamente il ruolo di strumento solista,
specie nell'Adagio centrale, che è praticamente
un assolo del flauto, con il delicato
accompagnamento in pizzicato degli archi. Con il
quartetto KV 285 la magia creatrice di Mozart ci
regala un gioiello musicale anche per uno
strumento che il compositore dichiarava di "non
sopportare" (ed è, per l'autore del "Flauto
magico" dichiarazione un po' paradossale). È
chiaro però che le parole del genio
salisburghese vanno riferite al flauto del suo
tempo, ben lontano per qualità di suono,
intonazione e volume dal flauto moderno. In
questo pezzo Navarra mostra tutte le sue doti di
virtuoso e la perfetta padronanza tecnica dello
strumento nel primo movimento in Allegro,
soprattutto nella ripresa, con trilli, balzi
bruschi di ottave e di registri, il tutto
eseguito con quella splendida fluidità e purezza
di suono che contraddistinguono lo stile del
flautista monregalese.
L'Adagio poi, si diceva, è
un assolo in cui il flauto è sfidato da Mozart
ad esprimere tutte le sue potenzialità
espressive, con una melodia cui la dolcezza di
suono di Navarra dona un'intensità e una carica
sentimentale, capaci di suscitare profonda
emozione nell'ascoltatore. Ma, ancora una volta,
va citata l'ottima prestazione degli archi, in
particolare nell'Allegro iniziale, ove, nella
sezione sviluppo, presenta un ricco avvicendarsi
di chiaroscuri, con il ricorso frequente al tono
minore, eseguiti al meglio dal flauto e dagli
archi, anche con una calibratura finissima delle
dinamiche. All'insegna della più pura grazia
mozartiana il Rondò finale, in cui tutti gli
strumenti, intrecciando variamente le entrate,
concorrono, con eleganza e finezza di suono, a
confezionare un pezzo di delizioso abbandono
alla gioia del fare (e ascoltare) musica. Con un
brusco salto ai nostri giorni, il programma del
concerto prevedeva un pezzo per flauto
violoncello e gong, la Petite suite, composto da
Joerg Widmann (che è un grande clarinettista)
nel 2016, come 'tombeau' alla flautista svizzera
Aurèle Nicolet, allora da poco scomparsa,
suddiviso in tre tempi,
 Allemande,
Lamento, Sarabande: l'intervento del violoncello
e del gong è limitato alla Sarabanda finale,
mentre i primi due tempi sono per flauto solo.
Splendida l'interpretazione di Navarra, sia
sotto il profilo tecnico che espressivo. Sotto
il profilo squisitamente tecnico il giovane
flautista piemontese dà prova di tutta la sua
bravura nel rendere al meglio i passaggi più
inquieti e nervosi dell'Allemande, con frequenti
cambi di registro, con un'emissione di purezza
ed energia straordinarie delle note sovracute,
con scale di vertiginosa rapidità. Una tensione
che si riproduce nel Lamento centrale, ove alle
agilità già presenti nell'Allemande si
aggiungono trilli e frullati, suonati con una
trasparenza e una limpidezza davvero ammirevoli.
Sul piano espressivo Navarra ha saputo dare
pienamente voce a quel tono di intenso dolore,
di meditazione sul tragico destino dell'uomo che
ovviamente è presente in tutto il pezzo, ma che
si fa particolarmente intenso nella finale
Sarabande, in cui il registro acuto è un grido
di dolore, e straziante è il progressivo
spegnersi del suono che conduce alla conclusione
del brano. La linea espressiva del flauto già
intensa di suo, traeva ulteriore potenza
suggestiva dal suono grave, di un brunito cupo e
senza speranza del violoncello, con lo schianto
del gong che precede la chiusura in pianissimo
del flauto Una composizione bellissima, nella
sua essenzialità e concentrazione, suonata
benissimo. Chiudeva il programma della serata
una delle più belle pagine della letteratura per
Quartetto d'archi, il n.12 op. 96, "Americano"
di A. Dvoràk, presentata nella versione per
flauto e archi. Anche in questo caso Navarra e
gli elementi del Camerata Ducale Ensemble han
dato un'ottima interpretazione, a cominciare già
dall'iniziale Allegro ma non troppo, con la
trepidante, leggera malinconia che vena il suono
vellutato della viola nell'enunciazione del tema
principale, un tema lirico pentatonico, che
risente dell'influenza della musica religiosa
degli Spirituals (ricordiamo che il quartetto fu
composto durante il soggiorno americano del
grande compositore boemo, da cui il titolo).
Diremmo che in questo capolavoro di Dvoràk
l'intensità espressiva del flauto di Navarra
tocca il suo vertice, in particolare nei primi
due movimenti, i più lirici dei quattro in cui è
diviso il pezzo. In particolare la
valorizzazione dei vari registri dinamici, la
cui gestione è essenziale in questo pezzo, è
stata accuratissima, con un gioco chiaroscurale
che si faceva emozione pura nei momenti in cui
il suono del flauto, nel registro basso, si
faceva misterioso mormorio, carico di
suggestione, nell'intreccio coi timbri degli
archi, tra i quali si distingueva in particolare,
per un suono di altissima qualità, nella sua
avvolgente e delicata morbidezza, il violoncello
di Giorgio Lucchini. Ma è naturalmente l'intera
compagine a ottenere un ottimo risultato nel
suono d'insieme, calibrato con grande efficacia
nei frequenti passaggi dei vari strumenti in
tremolo, o nei ribattuti sincopati e nei ritmi
puntati, che evocano come un sommesso singhiozzo
che sembra attraversare l'intero primo tempo.
Bravissimi sono stati Navarra e i i giovani
talenti dell'Ensemble nel valorizzare tutte le
potenzialità espressive e timbriche del tema del
Lento, anch'esso improntato al tono di
nostalgica cantilena dello Spiritual, e dove
ogni strumento fa sentire la sua voce, nel vario
e sempre timbricamente diverso intreccio delle
linee strumentali. Il luminoso tema principale
del Molto vivace e l'alternarsi nel Finale in
forma di Rondò, di un trascinante ritmo di danza,
e di due couplet di dolce e malinconico lirismo,
trovano nell'interpretazione, nella qualità del
suono e del fraseggiare del flauto e degli archi
un tono espressivo di grande qualità, sia nei
momenti più brillanti, sia in quelli di più
intimistico ripiegamento sentimentale. Abbiamo
insomma ascoltato un'esecuzione di un pezzo
bello e celebre, ispirata da collaudata
consapevolezza tecnica unita a matura capacità
di scavo espressivo nella partitura e possiamo
dire che la versione per flauto non fa per nulla
rimpiangere l'originale per quartetto di soli
archi. Vorremmo aggiungere una nostra
considerazione: la sagace e straordinaria 'politica'
perseguita da anni dalla Camerata Ducale nella
valorizzazione e formazione di giovani
strumentisti sta producendo i frutti meritati,
potendo ormai contare su un gruppo di talenti di
notevole qualità professionale e animati da
quell'entusiasmo e da quella gioia del suonare
insieme che nei giovani dà la spinta a offrire
il meglio di se stessi. Bellissimo concerto,
salutato dagli applausi di un pubblico come
sempre numeroso e con presenza giovanile,
crediamo, sopra la media italiana: a VercellI
sembra talvolta di trovarsi in qualche sala da
concerto austriaca o tedesca. Col bis,
Summertime di Gershwin, sempre in una versione
per flauto e archi, si è conclusa un'altra
memorabile serata al Teatro Civico di Vercelli.
(Foto in alto Uff. Stampa Vercelli) Allemande,
Lamento, Sarabande: l'intervento del violoncello
e del gong è limitato alla Sarabanda finale,
mentre i primi due tempi sono per flauto solo.
Splendida l'interpretazione di Navarra, sia
sotto il profilo tecnico che espressivo. Sotto
il profilo squisitamente tecnico il giovane
flautista piemontese dà prova di tutta la sua
bravura nel rendere al meglio i passaggi più
inquieti e nervosi dell'Allemande, con frequenti
cambi di registro, con un'emissione di purezza
ed energia straordinarie delle note sovracute,
con scale di vertiginosa rapidità. Una tensione
che si riproduce nel Lamento centrale, ove alle
agilità già presenti nell'Allemande si
aggiungono trilli e frullati, suonati con una
trasparenza e una limpidezza davvero ammirevoli.
Sul piano espressivo Navarra ha saputo dare
pienamente voce a quel tono di intenso dolore,
di meditazione sul tragico destino dell'uomo che
ovviamente è presente in tutto il pezzo, ma che
si fa particolarmente intenso nella finale
Sarabande, in cui il registro acuto è un grido
di dolore, e straziante è il progressivo
spegnersi del suono che conduce alla conclusione
del brano. La linea espressiva del flauto già
intensa di suo, traeva ulteriore potenza
suggestiva dal suono grave, di un brunito cupo e
senza speranza del violoncello, con lo schianto
del gong che precede la chiusura in pianissimo
del flauto Una composizione bellissima, nella
sua essenzialità e concentrazione, suonata
benissimo. Chiudeva il programma della serata
una delle più belle pagine della letteratura per
Quartetto d'archi, il n.12 op. 96, "Americano"
di A. Dvoràk, presentata nella versione per
flauto e archi. Anche in questo caso Navarra e
gli elementi del Camerata Ducale Ensemble han
dato un'ottima interpretazione, a cominciare già
dall'iniziale Allegro ma non troppo, con la
trepidante, leggera malinconia che vena il suono
vellutato della viola nell'enunciazione del tema
principale, un tema lirico pentatonico, che
risente dell'influenza della musica religiosa
degli Spirituals (ricordiamo che il quartetto fu
composto durante il soggiorno americano del
grande compositore boemo, da cui il titolo).
Diremmo che in questo capolavoro di Dvoràk
l'intensità espressiva del flauto di Navarra
tocca il suo vertice, in particolare nei primi
due movimenti, i più lirici dei quattro in cui è
diviso il pezzo. In particolare la
valorizzazione dei vari registri dinamici, la
cui gestione è essenziale in questo pezzo, è
stata accuratissima, con un gioco chiaroscurale
che si faceva emozione pura nei momenti in cui
il suono del flauto, nel registro basso, si
faceva misterioso mormorio, carico di
suggestione, nell'intreccio coi timbri degli
archi, tra i quali si distingueva in particolare,
per un suono di altissima qualità, nella sua
avvolgente e delicata morbidezza, il violoncello
di Giorgio Lucchini. Ma è naturalmente l'intera
compagine a ottenere un ottimo risultato nel
suono d'insieme, calibrato con grande efficacia
nei frequenti passaggi dei vari strumenti in
tremolo, o nei ribattuti sincopati e nei ritmi
puntati, che evocano come un sommesso singhiozzo
che sembra attraversare l'intero primo tempo.
Bravissimi sono stati Navarra e i i giovani
talenti dell'Ensemble nel valorizzare tutte le
potenzialità espressive e timbriche del tema del
Lento, anch'esso improntato al tono di
nostalgica cantilena dello Spiritual, e dove
ogni strumento fa sentire la sua voce, nel vario
e sempre timbricamente diverso intreccio delle
linee strumentali. Il luminoso tema principale
del Molto vivace e l'alternarsi nel Finale in
forma di Rondò, di un trascinante ritmo di danza,
e di due couplet di dolce e malinconico lirismo,
trovano nell'interpretazione, nella qualità del
suono e del fraseggiare del flauto e degli archi
un tono espressivo di grande qualità, sia nei
momenti più brillanti, sia in quelli di più
intimistico ripiegamento sentimentale. Abbiamo
insomma ascoltato un'esecuzione di un pezzo
bello e celebre, ispirata da collaudata
consapevolezza tecnica unita a matura capacità
di scavo espressivo nella partitura e possiamo
dire che la versione per flauto non fa per nulla
rimpiangere l'originale per quartetto di soli
archi. Vorremmo aggiungere una nostra
considerazione: la sagace e straordinaria 'politica'
perseguita da anni dalla Camerata Ducale nella
valorizzazione e formazione di giovani
strumentisti sta producendo i frutti meritati,
potendo ormai contare su un gruppo di talenti di
notevole qualità professionale e animati da
quell'entusiasmo e da quella gioia del suonare
insieme che nei giovani dà la spinta a offrire
il meglio di se stessi. Bellissimo concerto,
salutato dagli applausi di un pubblico come
sempre numeroso e con presenza giovanile,
crediamo, sopra la media italiana: a VercellI
sembra talvolta di trovarsi in qualche sala da
concerto austriaca o tedesca. Col bis,
Summertime di Gershwin, sempre in una versione
per flauto e archi, si è conclusa un'altra
memorabile serata al Teatro Civico di Vercelli.
(Foto in alto Uff. Stampa Vercelli)
25 febbraio 2024 Bruno Busca
Andrey Boreyko
dirige l'Orchestra Sinfonica di Milano
L'Orchestra
Sinfonica di Milano è stata diretta da
Andrey Boreyko, direttore principale della
compagine milanese dalla primavera del 2022. In
programna c'erano: prima una rarità del
compositore praghese Miloslav Kabeláč
(1908-1979) con il
suo Mystery of Time. Passacaglia per
orchestra op31, poi il noto Concerto per
pianoforte e orchestra n.2 in si bem.Maggiore
op.83 di Johannes Brahms.
Al pianoforte per il concerto dell'amburghese
l'ucraino Vadym Kholodenko, vincitore del
 prestigioso
"Concorso
Internazionale Van Cliburn nel 2013".
Un impaginato particolarmente impegnativo, con
il primo brano composto da Kabeláč
nel 1957 che
prevedeva un'ampia passacaglia che lentamente,
partendo da timbriche discrete, si sviluppava in
crescendo,
sino ad ampliare le
volumetrie in modo tumultuoso anche attraverso
le numerose percussioni
presenti in
orchestra.
Una valida composizione,
ottimamente interpretata
dalla Sinfonica di Milano. Prima del concerto
brahmsiano, Andrey Boreyko ha voluto salutare il
pubblico annunciando la fine del suo mandato con
l'orchestra e omaggiando i presenti prestigioso
"Concorso
Internazionale Van Cliburn nel 2013".
Un impaginato particolarmente impegnativo, con
il primo brano composto da Kabeláč
nel 1957 che
prevedeva un'ampia passacaglia che lentamente,
partendo da timbriche discrete, si sviluppava in
crescendo,
sino ad ampliare le
volumetrie in modo tumultuoso anche attraverso
le numerose percussioni
presenti in
orchestra.
Una valida composizione,
ottimamente interpretata
dalla Sinfonica di Milano. Prima del concerto
brahmsiano, Andrey Boreyko ha voluto salutare il
pubblico annunciando la fine del suo mandato con
l'orchestra e omaggiando i presenti
 con un
pregnante brano wagneriano, l'Elegia
nella trascrizione di Franco Mannino.
Un'interpretazione pregnante di nitore
coloristico. Dopo il breve intervallo
è salito sul
palcoscenico il pianista Kholodenko per il
celebre concerto, un lavoro molto "sinfonico"
dove la parte pianistica era resa con efficace
espressività nella modalità elegante e raffinata
del suo particolare ed essenziale tocco. L'ampio
concerto, in quattro movimenti, cosa rara per un
concerto pianistico, ha trovato una direzione
accurata e ben evidenziata in ogni sezione
orchestrale e Boreyko ha individuato benissimo
l'equilibrio dei movimenti, quello dei piani
sonori e una rispettosa integrazione pianistica
nel contesto orchestrale sino alle delicate
timbriche dell'Allegretto grazioso
finale. Applausi fragorosi dal numerosissimo
pubblico presente in Auditorium. Due i
riflessivi bis concessi dal pianista, tra i
quali il primo era una delicata Bagatella n.1
op.1 "Allegretto" del compositore ucraino
Valentin Silvestrov (1937) con un
pregnante brano wagneriano, l'Elegia
nella trascrizione di Franco Mannino.
Un'interpretazione pregnante di nitore
coloristico. Dopo il breve intervallo
è salito sul
palcoscenico il pianista Kholodenko per il
celebre concerto, un lavoro molto "sinfonico"
dove la parte pianistica era resa con efficace
espressività nella modalità elegante e raffinata
del suo particolare ed essenziale tocco. L'ampio
concerto, in quattro movimenti, cosa rara per un
concerto pianistico, ha trovato una direzione
accurata e ben evidenziata in ogni sezione
orchestrale e Boreyko ha individuato benissimo
l'equilibrio dei movimenti, quello dei piani
sonori e una rispettosa integrazione pianistica
nel contesto orchestrale sino alle delicate
timbriche dell'Allegretto grazioso
finale. Applausi fragorosi dal numerosissimo
pubblico presente in Auditorium. Due i
riflessivi bis concessi dal pianista, tra i
quali il primo era una delicata Bagatella n.1
op.1 "Allegretto" del compositore ucraino
Valentin Silvestrov (1937)
24 febbraio
2024 Cesare Guzzardella
Lorenzo Viotti dirige la
Filarmonica della Scala
Tra una
replica e l'altra del verdiano Simon Boccanegra,
il direttore svizzero Lorenzo Viotti - figlio di
italo/francesi- ha diretto un concerto sinfonico
particolarmente interessante con brani di
Rimskij-Korsakov, Ravel e Rachmaninov, tre
compositori che hanno in comune le loro
eccellenti qualità di orchestratori e di
direttori d'orchestra. Il Capriccio spagnolo
 op.34 del primo russo ha introdotto la
serata rivelando subito la valida cifra
interpretativa del giovane direttore alle prese
con un brano composto nel 1887 che vuole rendere
omaggio al mondo musicale spagnolo. Il celebre
Concerto in Sol (1929-31) del francese
Maurice Ravel ha visto poi al pianoforte solista
un altro francese, il quarantaduenne David Fray,
interprete molto apprezzato internazionalmente.
Elegante ed equilibrata la resa di un concerto
che risente parecchio dell'influenza jazzistica
e di Gershwin e che ha nel bellissimo movimento
centrale, Adagio assai, un momento di
grande riflessione resa ottimamente dalle note
centellinate e ben pesate da Fray, esguite con
eleganza in op.34 del primo russo ha introdotto la
serata rivelando subito la valida cifra
interpretativa del giovane direttore alle prese
con un brano composto nel 1887 che vuole rendere
omaggio al mondo musicale spagnolo. Il celebre
Concerto in Sol (1929-31) del francese
Maurice Ravel ha visto poi al pianoforte solista
un altro francese, il quarantaduenne David Fray,
interprete molto apprezzato internazionalmente.
Elegante ed equilibrata la resa di un concerto
che risente parecchio dell'influenza jazzistica
e di Gershwin e che ha nel bellissimo movimento
centrale, Adagio assai, un momento di
grande riflessione resa ottimamente dalle note
centellinate e ben pesate da Fray, esguite con
eleganza in
 un contesto orchestrale ideale. Il
solista, rimanendo in tema di note semplici, ha
concesso poi come bis la celebre Aria
iniziale delle Variazioni Goldberg di
J.S.Bach. Ottima interpretazione e applausi
fragorosi dal numerosissimo pubblico presente.
Dopo il breve intervallo, l'impatto massiccio
iniziale delle bellissime prime battute delle
Danze sinfoniche op.45 (1940) di Sergej
Rachmaninov ha dato ancora un tocco di
virtuosismo e di eleganza alla serata. La
bellissima orchestrazione di questo lavoro, che
spesso viene eseguito nella versione per due
pianoforti, ha messo in risalto le ottime
qualità della Filarmonica della Scala, orchestra
applauditissima al termine della splendida
serata. Questa sera alle ore 20.00 l'ultima
replica e sabato Viotti torna alla guida
dell'orchestra scaligera per l'ultima replica di
Simon Boccanegra. Da non perdere entrambi. un contesto orchestrale ideale. Il
solista, rimanendo in tema di note semplici, ha
concesso poi come bis la celebre Aria
iniziale delle Variazioni Goldberg di
J.S.Bach. Ottima interpretazione e applausi
fragorosi dal numerosissimo pubblico presente.
Dopo il breve intervallo, l'impatto massiccio
iniziale delle bellissime prime battute delle
Danze sinfoniche op.45 (1940) di Sergej
Rachmaninov ha dato ancora un tocco di
virtuosismo e di eleganza alla serata. La
bellissima orchestrazione di questo lavoro, che
spesso viene eseguito nella versione per due
pianoforti, ha messo in risalto le ottime
qualità della Filarmonica della Scala, orchestra
applauditissima al termine della splendida
serata. Questa sera alle ore 20.00 l'ultima
replica e sabato Viotti torna alla guida
dell'orchestra scaligera per l'ultima replica di
Simon Boccanegra. Da non perdere entrambi.
23 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Stefano Montanari
dirige
I Pomeriggi Musicali
in Haydn, Mozart e
Mendelssohn
Un
impaginato estremamente classico quello
ascoltato in anteprima al Dal Verme con I
Pomeriggi Musicali diretti da Stefano
Montanari. Queste mattinate musicali che
anticipano il concerto serale delle ore 20.00 e
la replica di sabato alle ore 17.00, stanno
diventando veramente importanti, visto la
numerosissima quantità di spettatori abituali ai
quali spesso si aggiungono centinaia di studenti
occasionali provenienti dalle scuole
 secondarie
milanesi. Montanari presenta i brani
rivolgendosi direttamente agli studenti, facendo
a loro domando, inquadrandoli all'attento
ascolto e sperando che questa venuta, con i loro
insegnanti, possa stimolarli per una futura
passione al mondo musicale classico.
L'impaginato prevedeva una rarità di F.J.Haydn
(1732-1809) con l'Ouverture da L'isola
disabitata, il Concerto per flauto e arpa
in do maggiore K 299 di W.A.Mozart
(1756-1791) e infine la celebre Sinfonia n.4
in la maggiore op.90 "Italiana" di F.
Mendelssohn ( 1809-1847). Il gesto energico ed
efficace di Montanari, ottimamente recepito
dagli orchestrali de "I Pomeriggi" ha
prodotto una valida esecuzione dell'Ouverture
haydniana, un brano di grande potenza espressiva
che andrebbe inserito spesso nei programmi
sinfonici. secondarie
milanesi. Montanari presenta i brani
rivolgendosi direttamente agli studenti, facendo
a loro domando, inquadrandoli all'attento
ascolto e sperando che questa venuta, con i loro
insegnanti, possa stimolarli per una futura
passione al mondo musicale classico.
L'impaginato prevedeva una rarità di F.J.Haydn
(1732-1809) con l'Ouverture da L'isola
disabitata, il Concerto per flauto e arpa
in do maggiore K 299 di W.A.Mozart
(1756-1791) e infine la celebre Sinfonia n.4
in la maggiore op.90 "Italiana" di F.
Mendelssohn ( 1809-1847). Il gesto energico ed
efficace di Montanari, ottimamente recepito
dagli orchestrali de "I Pomeriggi" ha
prodotto una valida esecuzione dell'Ouverture
haydniana, un brano di grande potenza espressiva
che andrebbe inserito spesso nei programmi
sinfonici.
 Protagonisti del successivo raffinato
concerto mozartiano erano il flautista Andrea
Manco e l'arpista Claudia Lucia Lamanna.
Coadiuvati benissimo dagli orchestrali, il duo
solistico è emerso per qualità espressiva
dominata da nitore timbrico nell'elargire la
gentile componente melodica del brano. Ottima la
miscela delle sonorità del flauto, con i tenui e
precisi colori dell'arpa. Perfetto l'equilibrio
complessivo del brano giovanile mozartiano.
Applausi fragorosi meritatissimi. La Sinfonia "Italiana",
penultima delle cinque sinfonie del Maestro
tedesco, è probabilmente la più popolare per via
di quel sorprendente attacco iniziale che si
ripercuote in tutto il lavoro. Ottima la decisa
direzione di Montanari con un risultato a mio
avviso migliore nei movimenti più energici
laterali, l'Allegro vivace iniziale e il
Saltarello.Presto finale. Un concerto
decisamente di qualità. Da non perdere la serata
ufficiale di questa sera e la replica di sabato. Protagonisti del successivo raffinato
concerto mozartiano erano il flautista Andrea
Manco e l'arpista Claudia Lucia Lamanna.
Coadiuvati benissimo dagli orchestrali, il duo
solistico è emerso per qualità espressiva
dominata da nitore timbrico nell'elargire la
gentile componente melodica del brano. Ottima la
miscela delle sonorità del flauto, con i tenui e
precisi colori dell'arpa. Perfetto l'equilibrio
complessivo del brano giovanile mozartiano.
Applausi fragorosi meritatissimi. La Sinfonia "Italiana",
penultima delle cinque sinfonie del Maestro
tedesco, è probabilmente la più popolare per via
di quel sorprendente attacco iniziale che si
ripercuote in tutto il lavoro. Ottima la decisa
direzione di Montanari con un risultato a mio
avviso migliore nei movimenti più energici
laterali, l'Allegro vivace iniziale e il
Saltarello.Presto finale. Un concerto
decisamente di qualità. Da non perdere la serata
ufficiale di questa sera e la replica di sabato.
22 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Meritato successo per
Fazil Say in Conservatorio
per la "Societa dei
Concerti"
È una
consuetudine sempre gradita il concerto che il
pianista turco Fazil Say tiene da moltissimi
anni in Conservatorio per la "Società dei
Concerti". Era venuto l'ultima volta nel
maggio del 2023 ottenendo, come sempre, un
meritato successo. Ieri è stata una serata
particolare, con una Sala Verdi al completo e
con centinaia di giovani ventenni, molti della
comunità turca, venuti -
 non
solo da Milano- per ascoltare un interprete
speciale, che ha fatto della creatività
personale la cifra estetica più riconoscibile.
Una parte dell'impaginato, quello "classico",
prevedeva brani di Bach-Busoni , Beethoven e
Janàček.
La seconda parte
"à
la carte",
ha visto solo composizioni
di Say tutte riconoscobili, brani che oramai
hanno fatto storia. Come detto in altre
occasioni, Say particolarmente conosciuto nella
sua terra d'origine, ha acquisito notorietà in
Italia e in Europa grazie anche ad alcune
pecurialità stilistiche e gestuali e anche per
essere un musicista 'trasversale", aperto al
jazz, alla musica folcloristica, al mondo colto,
con modalità interpretative ricche di
innovazioni timbriche, presenti soprattutto
nelle sue composizioni. Composte con un
linguaggio accessibile, i suoi lavori trovano
influenze legate alla sua terra, al mondo
europeo con riferimenti, nel melodiare, alla
canzone francese. Un pianista-compositore che
utilizza il pianoforte a 360 gradi, con effetti
percussivi sulla cassa di risonanza o smorzando
e riverberando le note ottenute con la mano
sinistra sulla cordiera. Il programma classico,
nello stile "alla Say", prevedeva la Ciaccona
dalla Partita n.2 per violino solo di
J.S.Bach nella nota trascrizione pianistica di
Ferruccio Busoni; quindi la Sonata n.17 in re
minore op.31 n.2 "la Tempesta" di L.v.
Beethoven e a conclusione la pregnante Sonata
"I - X- 1905" in mi bem.maggiore di non
solo da Milano- per ascoltare un interprete
speciale, che ha fatto della creatività
personale la cifra estetica più riconoscibile.
Una parte dell'impaginato, quello "classico",
prevedeva brani di Bach-Busoni , Beethoven e
Janàček.
La seconda parte
"à
la carte",
ha visto solo composizioni
di Say tutte riconoscobili, brani che oramai
hanno fatto storia. Come detto in altre
occasioni, Say particolarmente conosciuto nella
sua terra d'origine, ha acquisito notorietà in
Italia e in Europa grazie anche ad alcune
pecurialità stilistiche e gestuali e anche per
essere un musicista 'trasversale", aperto al
jazz, alla musica folcloristica, al mondo colto,
con modalità interpretative ricche di
innovazioni timbriche, presenti soprattutto
nelle sue composizioni. Composte con un
linguaggio accessibile, i suoi lavori trovano
influenze legate alla sua terra, al mondo
europeo con riferimenti, nel melodiare, alla
canzone francese. Un pianista-compositore che
utilizza il pianoforte a 360 gradi, con effetti
percussivi sulla cassa di risonanza o smorzando
e riverberando le note ottenute con la mano
sinistra sulla cordiera. Il programma classico,
nello stile "alla Say", prevedeva la Ciaccona
dalla Partita n.2 per violino solo di
J.S.Bach nella nota trascrizione pianistica di
Ferruccio Busoni; quindi la Sonata n.17 in re
minore op.31 n.2 "la Tempesta" di L.v.
Beethoven e a conclusione la pregnante Sonata
"I - X- 1905" in mi bem.maggiore di
 Leos
Janàček.
Ottime le
interpretazioni, alcune delle quali, quelle di
Bach-Busoni e di Beethoven, che avevamo già
ascoltato in
concerti passati Di pregnante valenza timbrica
la sonata di Janàček
definita da marcati contrasti nelle tre parti
che la compongono: Presentimento, Morte,
e Adagio, riuniti in un unico movimento.
Anche in questo brano la componente gestuale di
Say, atta a sottolineare l'evento musicale, era
un tutt'uno con l'
espressive sonorità.
Senza un momento di
pausa, Say è passato poi ad una serie di suoi
lavori, tutti oramai celebri tra cui il primo,
quello più conosciuto, divenuto un classico:
Black Earth. L'estemporaneità
dell'esecuzione del celebre brano porta Say a
fare sempre "modifiche in corso" .
Particolarmente toccante quella di ieri, con
effetti di riverbero e timbriche "orchestrali"
d' intensa pregnanza coloristica. Senza
soluzione di continuità ha eseguito altri brani
tra cui il melodico SES e le sue
Paganini Variazioni, con molte varianti
jazz. Applausi fragorosi dal pubblico più
giovane tutto in piedi e come bis la
popolarissima "Alla turca" di Mozart-Say
in versione jazz. Leos
Janàček.
Ottime le
interpretazioni, alcune delle quali, quelle di
Bach-Busoni e di Beethoven, che avevamo già
ascoltato in
concerti passati Di pregnante valenza timbrica
la sonata di Janàček
definita da marcati contrasti nelle tre parti
che la compongono: Presentimento, Morte,
e Adagio, riuniti in un unico movimento.
Anche in questo brano la componente gestuale di
Say, atta a sottolineare l'evento musicale, era
un tutt'uno con l'
espressive sonorità.
Senza un momento di
pausa, Say è passato poi ad una serie di suoi
lavori, tutti oramai celebri tra cui il primo,
quello più conosciuto, divenuto un classico:
Black Earth. L'estemporaneità
dell'esecuzione del celebre brano porta Say a
fare sempre "modifiche in corso" .
Particolarmente toccante quella di ieri, con
effetti di riverbero e timbriche "orchestrali"
d' intensa pregnanza coloristica. Senza
soluzione di continuità ha eseguito altri brani
tra cui il melodico SES e le sue
Paganini Variazioni, con molte varianti
jazz. Applausi fragorosi dal pubblico più
giovane tutto in piedi e come bis la
popolarissima "Alla turca" di Mozart-Say
in versione jazz.
22 febbraio
2024 Cesare Guzzardella
Sergei Babayan alle
Serate Musicali per le
"Variazioni Goldberg"
L'Aria
con 30 Variazioni in sol maggiore BWV 988,
ovvero le "Variazioni Goldberg", rappresentano
uno dei monumenti architettonico-musicali di
J.S.Bach. Composte nel 1741, in età matura, dal
genio tedesco, rappresentano un punto d'arrivo
per ogni grande virtuoso. L'armeno Sergei
Babayan (classe 1961) ha studiato al
Conservatorio di Mosca, avendo tra i maestri
anche Mikhail Pletnev, ed è un rinomato didatta
avendo avuto tra i suoi allievi il grande Daniil
Trifonov. È la seconda volta che viene in
 Conservatorio
ai concerti organizzati da Serate Musicali.
Nel maggio del 2022 l'impaginato era
variegato con brani di Bach-Busoni, Liszt e
Schumann resi con un linguaggio personale e
notevole espressività. Ieri sera il celebre
brano di Bach, vista la corposità di un lavoro-
che nell'interpretazione dell'armeno residente
negli Stati Uniti-, è durato esattamente 62
minuti, era l'unico in programma. Ho ascoltato
le Goldberg da numerosi ottimi interpreti,
un paio eccellenti, e per la prima volta da
Babayan. Sono rimasto decisamenre soddisfatto
della sua restituzione, giocata sulla varietà di
ricerca di adeguati andamenti, di timbriche mai
eccessive, d'intrecci delle voci di luminosa
resa estetica. Partendo con un'andatura
particolarmente riflessiva della celebre Aria
iniziale -32 battute di una semplice melodia
che poi ritornerà pressochè identica al termine
della trentesima variazione- l'interprete ha
rivelato un controllo totale di ogni elemento
costituente la complessa architettura. Conservatorio
ai concerti organizzati da Serate Musicali.
Nel maggio del 2022 l'impaginato era
variegato con brani di Bach-Busoni, Liszt e
Schumann resi con un linguaggio personale e
notevole espressività. Ieri sera il celebre
brano di Bach, vista la corposità di un lavoro-
che nell'interpretazione dell'armeno residente
negli Stati Uniti-, è durato esattamente 62
minuti, era l'unico in programma. Ho ascoltato
le Goldberg da numerosi ottimi interpreti,
un paio eccellenti, e per la prima volta da
Babayan. Sono rimasto decisamenre soddisfatto
della sua restituzione, giocata sulla varietà di
ricerca di adeguati andamenti, di timbriche mai
eccessive, d'intrecci delle voci di luminosa
resa estetica. Partendo con un'andatura
particolarmente riflessiva della celebre Aria
iniziale -32 battute di una semplice melodia
che poi ritornerà pressochè identica al termine
della trentesima variazione- l'interprete ha
rivelato un controllo totale di ogni elemento
costituente la complessa architettura.
 L'interiorizzazione
mnemonica di ogni dettaglio costruttivo ha
permesso la più completa penetrazione di un
lavoro ricco di contrasti, che comunque danno
modo all'interprete di esprimere la propria
creatività. Babayan ha aggiunto qualche
abbellimento perfettamente adeguato e tolto
alcuni ritornelli nella sua precisa visione del
capolavoro. La leggerezza timbrica, priva di
eccessi, ma di sicura resa nelle molteplici
dinamiche, e la riconoscibilità delle voci nei
differenti piani sonori sono indicativi di
un'nterpretazione d'eccellenza. Molto
interessante poi la timbrica "organistica" del
finale, nella ventinovesima e nella trentesima
variazione, che ha esaltato la musica del sommo
Bach, proiettandolo verso un'alta vetta
quasi irraggiungibile, ma da lui raggiunta con
naturalezza. Probabilmente la migliore delle
Goldberg ascoltate. Applausi fragorosi in
una Sala Verdi con un pubblico decisamente
entusiasta. L'interiorizzazione
mnemonica di ogni dettaglio costruttivo ha
permesso la più completa penetrazione di un
lavoro ricco di contrasti, che comunque danno
modo all'interprete di esprimere la propria
creatività. Babayan ha aggiunto qualche
abbellimento perfettamente adeguato e tolto
alcuni ritornelli nella sua precisa visione del
capolavoro. La leggerezza timbrica, priva di
eccessi, ma di sicura resa nelle molteplici
dinamiche, e la riconoscibilità delle voci nei
differenti piani sonori sono indicativi di
un'nterpretazione d'eccellenza. Molto
interessante poi la timbrica "organistica" del
finale, nella ventinovesima e nella trentesima
variazione, che ha esaltato la musica del sommo
Bach, proiettandolo verso un'alta vetta
quasi irraggiungibile, ma da lui raggiunta con
naturalezza. Probabilmente la migliore delle
Goldberg ascoltate. Applausi fragorosi in
una Sala Verdi con un pubblico decisamente
entusiasta.
20 febbraio
2024 Cesare Guzzardella
Il pianista Pier
Francesco Forlenza
allo Spazio Teatro 89
"Cosi
vicini, cosi lontani - quando i musicisti sono
amici, ma non troppo": questo il titolo scelto
da Luca Schieppati per il concerto tenuto dal
pianista materese Pier Francesco Forlenza, dove
la scelta dell'impaginato prevedeva brani di due
coppie di musicisti, ossia Brahms - Herzogenberg
e Debussy - Satie, amici, ma non sempre, con
momenti anche di forti contrasti nei loro
rapporti non solo musicali. Forlenza, nato nel
1970, interprete ma anche
 compositore,
a soli 22 anni già docente di ruolo al
Conservatorio, ha voluto introdurre il
pomeriggio musicale con tre rarità pianistiche
di Heinrich von Herzogenger (1843- 1900),
musicista tedesco contemporaneo di Brahms (1833-
1897). Di lui ha eseguito Commodo op. 68 n.
2, Impromptu op. 37 n. 1 e Menuet op. 37
n. 5, brani molto interessanti e ben
interpretati da Forlenza. A questi lavori sono
seguite le celebri due Rapsodie op.79 del
musicista amburghese, dedicate a Elisabeth von
Herzogenberg nata Stockhausen, moglie del primo
compositore. Elisabeth era una valida pianista e
anche compositrice, allieva di Brahms; di
famiglia aristocratica e colta, di notevole
importanza all'epoca, aveva entrambi i genitori
dedicatari di opere di Chopin. Forlenza, con
timbriche sicure ed energiche, ha ottimamente
eseguito i lavori brahmsiani. Con un netto
cambio di registro si è passati ad un clima
musicale differente, dove i brani di Satie e
Debussy sono stati preceduti e intervallati da
tre brevi composizioni di Forlenza: il primo,
B Flat, è una riuscita ninna nanna con
armonie legate al jazz, un po' alla Bill Evans,
collegata a due notissimi brani di Erik Satie
(1866-1925), Gymnopedie n.1 e
Gnossienne n.1, compositore,
a soli 22 anni già docente di ruolo al
Conservatorio, ha voluto introdurre il
pomeriggio musicale con tre rarità pianistiche
di Heinrich von Herzogenger (1843- 1900),
musicista tedesco contemporaneo di Brahms (1833-
1897). Di lui ha eseguito Commodo op. 68 n.
2, Impromptu op. 37 n. 1 e Menuet op. 37
n. 5, brani molto interessanti e ben
interpretati da Forlenza. A questi lavori sono
seguite le celebri due Rapsodie op.79 del
musicista amburghese, dedicate a Elisabeth von
Herzogenberg nata Stockhausen, moglie del primo
compositore. Elisabeth era una valida pianista e
anche compositrice, allieva di Brahms; di
famiglia aristocratica e colta, di notevole
importanza all'epoca, aveva entrambi i genitori
dedicatari di opere di Chopin. Forlenza, con
timbriche sicure ed energiche, ha ottimamente
eseguito i lavori brahmsiani. Con un netto
cambio di registro si è passati ad un clima
musicale differente, dove i brani di Satie e
Debussy sono stati preceduti e intervallati da
tre brevi composizioni di Forlenza: il primo,
B Flat, è una riuscita ninna nanna con
armonie legate al jazz, un po' alla Bill Evans,
collegata a due notissimi brani di Erik Satie
(1866-1925), Gymnopedie n.1 e
Gnossienne n.1,
 due lavori tanto semplici
quanto profondi, eseguiti da Forlenza con
intensa espressività e andamento riflessivo. Gli
altri due brani di Forlenza, Satie's faction
e Valse lunatique, sono risultati
entrambi molto validi e piacevoli, legati al
mondo di Satie, con il secondo più sviluppato
nel contrasto tra i due momenti differenti.
Ottimi lavori! Numerosi i brani di Claude
Debussy conclusivi: due Preludi dal libro
secondo, Bruyères e Feux d'artifice,
la prima serie di Image e per ultimo
L'isle joyeuse. Tutti interpretati con
grande perizia e sensibilità da Forlenza, a
dimostrazione di un'indubbia affinità con il
compositore francese. Applausi calorosi e
meritatissimi, anche dopo il bis, una preziosa
rarità: un breve brano delicato e scritto
benissimo, un Intermezzo in la maggiore
in stile brahmsiano, di Elisabeth Stockhausen
von Herzogenberg trascritto dal pianista. Il 3
marzo, sempre alle ore 17.00, concerto del duo
Sacco-Schieppati (violino e pianoforte) in un
interessante programma denominato "Qualcosa di
terribile - Tolstoj, la musica e altre invettive":
in programma anche la beethoveniana Sonata op.
47 " a Kreutzer". Da non perdere. due lavori tanto semplici
quanto profondi, eseguiti da Forlenza con
intensa espressività e andamento riflessivo. Gli
altri due brani di Forlenza, Satie's faction
e Valse lunatique, sono risultati
entrambi molto validi e piacevoli, legati al
mondo di Satie, con il secondo più sviluppato
nel contrasto tra i due momenti differenti.
Ottimi lavori! Numerosi i brani di Claude
Debussy conclusivi: due Preludi dal libro
secondo, Bruyères e Feux d'artifice,
la prima serie di Image e per ultimo
L'isle joyeuse. Tutti interpretati con
grande perizia e sensibilità da Forlenza, a
dimostrazione di un'indubbia affinità con il
compositore francese. Applausi calorosi e
meritatissimi, anche dopo il bis, una preziosa
rarità: un breve brano delicato e scritto
benissimo, un Intermezzo in la maggiore
in stile brahmsiano, di Elisabeth Stockhausen
von Herzogenberg trascritto dal pianista. Il 3
marzo, sempre alle ore 17.00, concerto del duo
Sacco-Schieppati (violino e pianoforte) in un
interessante programma denominato "Qualcosa di
terribile - Tolstoj, la musica e altre invettive":
in programma anche la beethoveniana Sonata op.
47 " a Kreutzer". Da non perdere.
19 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Il Kontraste Duo a
Palazzo
Marino per "Ritratti musicali"
Palazzo Marino, in occasione
della mostra dedicata a Moroni in corso di
svolgimento alle Gallerie d'Italia, ha
organizzato alcuni Ritratti Musicali: tre
incontri in musica di tarda mattinata che oggi e
nel mese di marzo ( i prossimi incontri sono
previsti per il 3 e il 17 marzo ) riempiranno di
ottima musica la prestigiosa Sala Alessi. Questa
mattina, un concerto interamente al femminile ha
trovato successo in una sala stracolma di
pubblico: il Kontraste Duo formato dalla
clarinettista Silvia Puggioni e dalla pianista
Gledis Gjuzi ha interpretato brani di ben sette
compositrici e precisamente di Clémence de
Grandval (1828-1907), Johanna Senfter
(1879-1961), Francine Aubin (1938-2016), Ruth
Gipps (1921-1999), Krystyna Moszumańska-Nazar
(1924-2009), Lili Boulanger (1893-1918) e Marion
Bauer(1882-1955). A parte Lili Boulanger,
sorella di Nadia, entrambe conosciute e
apprezzate
 musiciste, con la seconda
celeberrima insegnante di composizione, meno
conosciuti erano gli altri nomi. L'impaginato
nella sua completezza
era
ottimo e le qualità
di scrittura musicale delle autrici -
soprattutto francesi, ma anche tedesche,
inglesi, polacche e statunitensi -di alto
livello. Il duo Puggioni-Gjuzi si è rivelato
espressivamente pregnante nel trasmettere le
articolate composizioni attraverso un'intesa
discorsiva di ottimo livello. Le stesse
interpreti hanno presentato in modo dettagliato
i lavori eseguiti, inquadrando storicamente le
compositrici in un panorama musicale che dalla
fine dell'Ottocento si spinge quasi ai nostri
giorni, con i raffinati brani ad esempio di
Francine Aubin, di Ruth Gipps o della Moszumańska-Nazar.
I Deux pièces en forme de jazz
per
clarinetto e pianoforte, della Aubin,
-un
Tempo di blues
e
un
Andante-
riassumono in modo mirabile ed elegante modalità
classiche e ritmiche jazzistiche, espresse con
abilità e disinvoltura dal duo. Di rilevante
melodicità il Preludio per clarinetto op.51
della Gipps e di grande creativita le Tre
Miniature per cl.e piano della polacca
Mouszumańska-Nazar,
brani brevi ma di grande varietà
costruttiva, ottimamente individuata dalle
interpreti. musiciste, con la seconda
celeberrima insegnante di composizione, meno
conosciuti erano gli altri nomi. L'impaginato
nella sua completezza
era
ottimo e le qualità
di scrittura musicale delle autrici -
soprattutto francesi, ma anche tedesche,
inglesi, polacche e statunitensi -di alto
livello. Il duo Puggioni-Gjuzi si è rivelato
espressivamente pregnante nel trasmettere le
articolate composizioni attraverso un'intesa
discorsiva di ottimo livello. Le stesse
interpreti hanno presentato in modo dettagliato
i lavori eseguiti, inquadrando storicamente le
compositrici in un panorama musicale che dalla
fine dell'Ottocento si spinge quasi ai nostri
giorni, con i raffinati brani ad esempio di
Francine Aubin, di Ruth Gipps o della Moszumańska-Nazar.
I Deux pièces en forme de jazz
per
clarinetto e pianoforte, della Aubin,
-un
Tempo di blues
e
un
Andante-
riassumono in modo mirabile ed elegante modalità
classiche e ritmiche jazzistiche, espresse con
abilità e disinvoltura dal duo. Di rilevante
melodicità il Preludio per clarinetto op.51
della Gipps e di grande creativita le Tre
Miniature per cl.e piano della polacca
Mouszumańska-Nazar,
brani brevi ma di grande varietà
costruttiva, ottimamente individuata dalle
interpreti. Due brevi brani della Boulanger,
D'un vieux jardin e Cortege, tratti
da Trois morceaux pour Piano, hanno
trovato una luminosa e dettagliata
interpretazione dalla Gjuzi, pianista proiettata
nel repertorio novecentesco e contemporaneo.
Efficaci anche i primi brani della Grandval,
Invocation e Air Slave, l'ultimo
della statunitense Marion Bauer - allieva di
Nadia Boulanger- con la sua Sonata per
clarinetto e pianoforte op.22 ( anche per
viola) . Intensamente profondo Ruhig,
movimento centrale della Sonata per cl.e
pianoforte op.57 di Johanna Senfler. Un
concerto applauditissimo che ha visto anche un'
eccellente esecuzione di un bis di una nota
compositrice quale la francese Germaine
Tailleferre (1892-1983) e la sua splendida
Arabesque. Applausi fragorosi alle
protagoniste. Due brevi brani della Boulanger,
D'un vieux jardin e Cortege, tratti
da Trois morceaux pour Piano, hanno
trovato una luminosa e dettagliata
interpretazione dalla Gjuzi, pianista proiettata
nel repertorio novecentesco e contemporaneo.
Efficaci anche i primi brani della Grandval,
Invocation e Air Slave, l'ultimo
della statunitense Marion Bauer - allieva di
Nadia Boulanger- con la sua Sonata per
clarinetto e pianoforte op.22 ( anche per
viola) . Intensamente profondo Ruhig,
movimento centrale della Sonata per cl.e
pianoforte op.57 di Johanna Senfler. Un
concerto applauditissimo che ha visto anche un'
eccellente esecuzione di un bis di una nota
compositrice quale la francese Germaine
Tailleferre (1892-1983) e la sua splendida
Arabesque. Applausi fragorosi alle
protagoniste.
18 febbraio
2024 Cesare
Guzzardella
L'Orchestra Sinfonica
Giovanile
di Milano diretta da Emmanuel
Tjeknavorian
Dopo
l'importante serata di giovedì sera con
l'Orchestra Sinfonica di Milano, il direttore
austriaco Emmanuel Tjeknavorian è tornato
 in
Auditorium ieri nel tardo pomeriggio per
dirigere l'Orchestra Sinfonica Giovanile di
Milano, una compagine composta da giovanissimi
strumentisti coadiuvati da alcune prime parti
(come tutor) appartenenti all'orchestra
principale. Un numerosissimo pubblico ha accolto
la giovane l'orchestra e Tjeknavorian - da
settembre 2024 direttore musicale in Auditorium-
per due brani quali la celebre Moldava di
Smetana e la Sinfonia n.8 di Antonin
Dvorak. Esecuzioni di qualità per i giovanissimi
che vogliono fare della musica la loro
professione. Applausi meritatissimi a tutti i
protagonisti. Oggi alle 16.00 la replica del
concerto di giovedì. Da non perdere! in
Auditorium ieri nel tardo pomeriggio per
dirigere l'Orchestra Sinfonica Giovanile di
Milano, una compagine composta da giovanissimi
strumentisti coadiuvati da alcune prime parti
(come tutor) appartenenti all'orchestra
principale. Un numerosissimo pubblico ha accolto
la giovane l'orchestra e Tjeknavorian - da
settembre 2024 direttore musicale in Auditorium-
per due brani quali la celebre Moldava di
Smetana e la Sinfonia n.8 di Antonin
Dvorak. Esecuzioni di qualità per i giovanissimi
che vogliono fare della musica la loro
professione. Applausi meritatissimi a tutti i
protagonisti. Oggi alle 16.00 la replica del
concerto di giovedì. Da non perdere!
18 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Emmanuel Tjeknavorian
dirige l' Orchestra
Sinfonica di Milano in
Wagner e R. Strauss
Una
serata importante quella di ieri sera in
Auditorium con l' Orchestra Sinfonica di
Milano. Il nuovo direttore musicale della
sinfonica milanese Emmanuel Tjeknavorian,
direttore d'orchestra e violinista affermato
internazionalmente, ha tenuto un concerto di
decisa qualità proponendo brani di Richard
Wagner e di Richard Strauss. Due musicisti
tedeschi legati al romanticismo e al tardo
romanticismo dove il primo, di cinquant'anni più
giovane - era nato nel 1813 a Lipsia- è
l'inventore di un nuovo modo di concepire la
 musica,
legata ad un filo conduttore che torna in tutti
i lavori, sia nelle numerose e amate opere
liriche che nei pochi brani orchestrali da lui
realizzati. Richard Strauss, nato nel 1864 a
Monaco di Baviera, parte dalla concezione
wagneriana e costruisce un sinfonismo
virtuosistico portato alle più estreme
ridondanze volumetriche, in costruzioni musicali
dove anche molti strumenti solistici
dell'orchestra primeggiano. Le sua grandezza di
compositore, pari alle sue note capacità
direttoriali, hanno permesso uno sviluppo
coloristico molto progredito per le grandi
orchestre che in quegli anni assumono dimensioni
sempre maggiori. Il viennese Tjeknavorian, nato
nel 1995, quindi non ancora trentenne, aveva
iniziato la carriera musicale come grande
virtuoso del violino a partire dal successo
ottenuto al Concorso Sibelius nel 2015. Da
alcuni anni l'interesse per la direzione
orchestrale espressa dalle sue indubbie capacità,
lo hanno portato in giro per il mondo alla guida
di orchestre importanti. L'impaginato scelto per
la serata ha visto prima di Wagner il raro
Eine Faust-Ouvertüre, WWV 59 e poi il
celebre Prelude & Liebestod da Tristan
und Isolde; musica,
legata ad un filo conduttore che torna in tutti
i lavori, sia nelle numerose e amate opere
liriche che nei pochi brani orchestrali da lui
realizzati. Richard Strauss, nato nel 1864 a
Monaco di Baviera, parte dalla concezione
wagneriana e costruisce un sinfonismo
virtuosistico portato alle più estreme
ridondanze volumetriche, in costruzioni musicali
dove anche molti strumenti solistici
dell'orchestra primeggiano. Le sua grandezza di
compositore, pari alle sue note capacità
direttoriali, hanno permesso uno sviluppo
coloristico molto progredito per le grandi
orchestre che in quegli anni assumono dimensioni
sempre maggiori. Il viennese Tjeknavorian, nato
nel 1995, quindi non ancora trentenne, aveva
iniziato la carriera musicale come grande
virtuoso del violino a partire dal successo
ottenuto al Concorso Sibelius nel 2015. Da
alcuni anni l'interesse per la direzione
orchestrale espressa dalle sue indubbie capacità,
lo hanno portato in giro per il mondo alla guida
di orchestre importanti. L'impaginato scelto per
la serata ha visto prima di Wagner il raro
Eine Faust-Ouvertüre, WWV 59 e poi il
celebre Prelude & Liebestod da Tristan
und Isolde;
 dopo
l'intervallo di Strauss prima Der
Rosenkavalier, Suite TrV 227 e poi Till
Eulenspiegels lustige Streiche (I tiri
burloni di Till Eulenspiegel) TrV 171. Le
potenzialità dell'orchestra hanno trovato
espressione nell'accurata direzione del viennese.
Tutti e quattro i lavori hanno rivelato la
chiarezza d'idee, dal punto di vista costruttivo,
del giovane direttore, che con gesto elegante
indirizza gli orchestrali in un territorio
musicale a lui molto congeniale. Dopo la più
estroversa Ouverture dal Faust,
ottimamente eseguita, i colori intimistici del
celebre Preludio da Tristan e Isolde
sono stati delineati dall'orchestra con
intensa profondità. Le caratteristiche quasi
viennesi, con i relativi movimenti di valzer,
presenti nella Suite dal Rosenkavalier
hanno ancor più delineato l'affinità di
Tjeknavorian con la musica dello Strauss tedesco.
Anche nei Tiri burloni di Till Eulenspiegel,
l'eccellenza degli impasti coloristici si sono
rivelati in toto e complessivamente le
interpretazioni straussiane sono apparse di
ancor più alta qualità. Bravissimi i singoli
strumentisti nei numerosissimi interventi
solistici: tra questi citiamo almeno l'ottimo
violino di Luca Santaniello. Un successo
meritatissimo in un Auditorium stracolmo di
pubblico. Ad assistere al concerto c'erano anche
noti compositori e direttori d'orchestra come
Riccardo Chailly, organizzatori di concerti e
numerosi giornalisti. Splandida serata. Da non
perdere la replica di domani, domenica 18
febbraio, alle ore 16.00 dopo
l'intervallo di Strauss prima Der
Rosenkavalier, Suite TrV 227 e poi Till
Eulenspiegels lustige Streiche (I tiri
burloni di Till Eulenspiegel) TrV 171. Le
potenzialità dell'orchestra hanno trovato
espressione nell'accurata direzione del viennese.
Tutti e quattro i lavori hanno rivelato la
chiarezza d'idee, dal punto di vista costruttivo,
del giovane direttore, che con gesto elegante
indirizza gli orchestrali in un territorio
musicale a lui molto congeniale. Dopo la più
estroversa Ouverture dal Faust,
ottimamente eseguita, i colori intimistici del
celebre Preludio da Tristan e Isolde
sono stati delineati dall'orchestra con
intensa profondità. Le caratteristiche quasi
viennesi, con i relativi movimenti di valzer,
presenti nella Suite dal Rosenkavalier
hanno ancor più delineato l'affinità di
Tjeknavorian con la musica dello Strauss tedesco.
Anche nei Tiri burloni di Till Eulenspiegel,
l'eccellenza degli impasti coloristici si sono
rivelati in toto e complessivamente le
interpretazioni straussiane sono apparse di
ancor più alta qualità. Bravissimi i singoli
strumentisti nei numerosissimi interventi
solistici: tra questi citiamo almeno l'ottimo
violino di Luca Santaniello. Un successo
meritatissimo in un Auditorium stracolmo di
pubblico. Ad assistere al concerto c'erano anche
noti compositori e direttori d'orchestra come
Riccardo Chailly, organizzatori di concerti e
numerosi giornalisti. Splandida serata. Da non
perdere la replica di domani, domenica 18
febbraio, alle ore 16.00
17 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Eleonora e Beatrice
Dallagnese per
"Musica con le ali"
al Museo del Teatro alla Scala
"Musica
con le ali" da
alcuni anni promuove giovani talenti attraverso
concerti ottimamente organizzati. Ieri, nel
tardo pomeriggio, ho avuto l'opportunità di
ascoltare il Duo Dallagnese nella
elegante Sala Esedra del
Museo Teatrale alla Scala. Eleonora e Beatrice
Dallagnese, sorelle di 23 anni, si sono
recentemente diplomate all'Accademia Pianistica
di Imola, importante
 istituzione
musicale che da molti anni annovera tra i
migliori insegnanti di pianoforte celebrità del
mondo interpretativo. Inserite nelle migliori
società concertistiche italiane, hanno già
effettuato numerosi concerti cameristici
soprattutto in duo a quattro mani, e quello di
ieri rappresenta un'ulteriore partecipazione
rivelatrice delle loro straordinarie qualità.
L'impaginato presentato, particolarmente
riuscito negli accostamenti dei brani, prevedeva
musiche di Ravel, Respighi e Rachmaninov, tre
musicisti tra loro contemporanei, vissuti a
cavallo tra gli ultimi tre decenni
dell'Ottocento e i primi quattro del Novecento.
Sono stati eseguiti re importanti lavori, il
primo del francese, Ma Mére l'Oye, era il
più celebre nella versione per pianoforte a
quattro mani del 1910, dalla precedente
orchestrale. L'ottimo impatto timbrico iniziale
del primo dei cinque brani che compongono la
suite- Pavane de la belle au bois dormant-
ha da subito rivelato le qualità delle due
interpreti, sostenute dalle limpide volumetrie
dello storico pianoforte Steinway & Sons
appartenuto a Franz Liszt e da alcuni anni
presente al Museo della Scala. istituzione
musicale che da molti anni annovera tra i
migliori insegnanti di pianoforte celebrità del
mondo interpretativo. Inserite nelle migliori
società concertistiche italiane, hanno già
effettuato numerosi concerti cameristici
soprattutto in duo a quattro mani, e quello di
ieri rappresenta un'ulteriore partecipazione
rivelatrice delle loro straordinarie qualità.
L'impaginato presentato, particolarmente
riuscito negli accostamenti dei brani, prevedeva
musiche di Ravel, Respighi e Rachmaninov, tre
musicisti tra loro contemporanei, vissuti a
cavallo tra gli ultimi tre decenni
dell'Ottocento e i primi quattro del Novecento.
Sono stati eseguiti re importanti lavori, il
primo del francese, Ma Mére l'Oye, era il
più celebre nella versione per pianoforte a
quattro mani del 1910, dalla precedente
orchestrale. L'ottimo impatto timbrico iniziale
del primo dei cinque brani che compongono la
suite- Pavane de la belle au bois dormant-
ha da subito rivelato le qualità delle due
interpreti, sostenute dalle limpide volumetrie
dello storico pianoforte Steinway & Sons
appartenuto a Franz Liszt e da alcuni anni
presente al Museo della Scala.
 Di
grande qualità anche il più noto Le jardin
fèerique, spesso eseguito come bis. La
perfetta sintonia delle due Dallagnese, definita
da precisione di tocco e luminosità coloristica,
ha evidenziato anche i brani successivi. Prima
un' ottima trascrizione de I pini di Roma
di Ottorino Respighi, compositore italiano
celebre per le sue qualità di orchestratore,
come nel brano in questione composto nel 1924 e
qui eseguito nell'eccellente
riduzione per pianoforte a quattro mani dello
stesso compositore. Quindi, come lavoro
conclusivo, i Six Morceaux op.11 di
Sergej Rachmaninov, opera giovanile del russo
per pianoforte a quattro mani del 1894. In
entrambi i brani il duo pianistico ha rivelato
ancora un'ottima sintonia interpretativa. Tra i
movimenti più appariscenti segnaliamo almeno
I pini di villa borghese di Respighi e lo
straordinario Valzer, quarto brano
dell'Op.11 di Rachmaninov, interpretato con
varietà timbrica e volumetrica ed evidente
espressività dalle bravissime Dallagnese.
Applausi fragorosi nella sala al completo e come
bis la celebre Danza ungherese n.1 di
Johannes Brahms. Di
grande qualità anche il più noto Le jardin
fèerique, spesso eseguito come bis. La
perfetta sintonia delle due Dallagnese, definita
da precisione di tocco e luminosità coloristica,
ha evidenziato anche i brani successivi. Prima
un' ottima trascrizione de I pini di Roma
di Ottorino Respighi, compositore italiano
celebre per le sue qualità di orchestratore,
come nel brano in questione composto nel 1924 e
qui eseguito nell'eccellente
riduzione per pianoforte a quattro mani dello
stesso compositore. Quindi, come lavoro
conclusivo, i Six Morceaux op.11 di
Sergej Rachmaninov, opera giovanile del russo
per pianoforte a quattro mani del 1894. In
entrambi i brani il duo pianistico ha rivelato
ancora un'ottima sintonia interpretativa. Tra i
movimenti più appariscenti segnaliamo almeno
I pini di villa borghese di Respighi e lo
straordinario Valzer, quarto brano
dell'Op.11 di Rachmaninov, interpretato con
varietà timbrica e volumetrica ed evidente
espressività dalle bravissime Dallagnese.
Applausi fragorosi nella sala al completo e come
bis la celebre Danza ungherese n.1 di
Johannes Brahms.
16 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Ramin Bahrami per
la "Società
dei Concerti" in
Conservatorio
Conoscevo il pianista iraniano Ramin Bahrami per
il suo Bach, musicista a lui caro che lo ha reso
noto internazionalmente. L'impaginato presentato
al concerto organizzato in Conservatorio dalla
Società dei Concerti, unitamente a due
brani del grande compositore tedesco,
prevedeva anche lavori di Mozart, Chopin,
Rachmaninov e Bartók. Un
impaginato dunque variegato che ha
 messo
in risalto un pianista diverso e personale.
Indubbiamente la Partita n.1 in si bem.
maggiore BWV 825 , eseguita a inizio
concerto,e il delizioso
Capriccio sopra la
lontananza del fratello dilettissimo BWV 992,
eseguita a conclusione del programma ufficiale,
hanno messo in rilievo le specificità di Bahrami
nell'interpretare il Sommo. La leggerezza di
tocco, in una discorsività tutta interiorizzata
e la capacità di pesare il suono su volumetrie
discrete, sono una peculiare caratteristica
dell'ottimo Bach ascoltato. Differenti le
sensazioni avute per gli altri compositori,
musicisti esternati dall' interprete con
indubbia personalizzazione creativa, ma lontani
dalle esecuzioni entrate nella storia. Il Mozart
della celebre Fantasia in re minore K 397,
anticipata - come già era avvenuto nel primo
Bach- da un paio di battute introduttive opera
del pianista, ha trovato una leggerezza forse
eccessiva nella prima parte del brano, dove
l'elemento patetico introduttivo risultava
parzialmente svuotato. La logica complessiva
dell'esecuzione ha avuto comunque una sua
coerenza se riferita alla ricercata creatività messo
in risalto un pianista diverso e personale.
Indubbiamente la Partita n.1 in si bem.
maggiore BWV 825 , eseguita a inizio
concerto,e il delizioso
Capriccio sopra la
lontananza del fratello dilettissimo BWV 992,
eseguita a conclusione del programma ufficiale,
hanno messo in rilievo le specificità di Bahrami
nell'interpretare il Sommo. La leggerezza di
tocco, in una discorsività tutta interiorizzata
e la capacità di pesare il suono su volumetrie
discrete, sono una peculiare caratteristica
dell'ottimo Bach ascoltato. Differenti le
sensazioni avute per gli altri compositori,
musicisti esternati dall' interprete con
indubbia personalizzazione creativa, ma lontani
dalle esecuzioni entrate nella storia. Il Mozart
della celebre Fantasia in re minore K 397,
anticipata - come già era avvenuto nel primo
Bach- da un paio di battute introduttive opera
del pianista, ha trovato una leggerezza forse
eccessiva nella prima parte del brano, dove
l'elemento patetico introduttivo risultava
parzialmente svuotato. La logica complessiva
dell'esecuzione ha avuto comunque una sua
coerenza se riferita alla ricercata creatività
 dell'interprete.
Le frequentate Mazurche di Chopin scelte,
cioè l'Op.30 n.2 in si minore,
l'Op.63
n.3 in do diesis minore
e l'Op.33 n.2 in
re maggiore, erano lontane dal registro
polacco dei grandi chopiniani e personalizzate
certamente con chiarezza espressiva e di
dettaglio "alla Bahrami". Di valida resa
Rachmaninov con l'Elegia in mi bem. minore
op.3 n.1, eseguita analiticamente, mettendo
bene in rilievo i piani sonori delle linee
melodiche. Con il Bela Bartók delle celebri
Sei danze
rumene per
pianoforte, abbiamo trovato un'interprete
che ha trascurato il percussivo elemento ritmico
e la precisa quadratura temporale, per una dell'interprete.
Le frequentate Mazurche di Chopin scelte,
cioè l'Op.30 n.2 in si minore,
l'Op.63
n.3 in do diesis minore
e l'Op.33 n.2 in
re maggiore, erano lontane dal registro
polacco dei grandi chopiniani e personalizzate
certamente con chiarezza espressiva e di
dettaglio "alla Bahrami". Di valida resa
Rachmaninov con l'Elegia in mi bem. minore
op.3 n.1, eseguita analiticamente, mettendo
bene in rilievo i piani sonori delle linee
melodiche. Con il Bela Bartók delle celebri
Sei danze
rumene per
pianoforte, abbiamo trovato un'interprete
che ha trascurato il percussivo elemento ritmico
e la precisa quadratura temporale, per una
 particolare "riflessione melodica" sulle sei
danze folcloristiche. Un'nterpretazione poco
bartókiana ma originale e anche questa molto
"alla Bahrami". Ricordiamo che
il pianista di
Teheran, nell'introdurre i brani ha vuluto
mettere in rilievo la triste situazione attuale
dovuta alle numerose guerre in corso ricordando
anche la violenza perpretata sulle donne in
molte parti del mondo. Una presentazione
toccante con un auspicio alla fine dei conflitti.
Applausi fragorosi dal numeroso pubblico, anche
giovanile, intervenuto in Sala Verdi. Due i bis
concessi: prima un noto
Valzer in la bem.
maggiore di Chopin, sempre
alla Bahrami,
e poi la famosa Aria iniziale delle
Goldberg di Bach interpretata con intensa
leggerezza ed espressività. Ancora applausi. particolare "riflessione melodica" sulle sei
danze folcloristiche. Un'nterpretazione poco
bartókiana ma originale e anche questa molto
"alla Bahrami". Ricordiamo che
il pianista di
Teheran, nell'introdurre i brani ha vuluto
mettere in rilievo la triste situazione attuale
dovuta alle numerose guerre in corso ricordando
anche la violenza perpretata sulle donne in
molte parti del mondo. Una presentazione
toccante con un auspicio alla fine dei conflitti.
Applausi fragorosi dal numeroso pubblico, anche
giovanile, intervenuto in Sala Verdi. Due i bis
concessi: prima un noto
Valzer in la bem.
maggiore di Chopin, sempre
alla Bahrami,
e poi la famosa Aria iniziale delle
Goldberg di Bach interpretata con intensa
leggerezza ed espressività. Ancora applausi.
15 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Luisa Sello e Bruno
Canino al Museo del Novecento
Un
programma particolarmente interessante per un
duo che da più di un decennio interpreta
soprattutto brani del Novecento e contemporanei.
Stiamo parlando della flautista Luisa Sello e
del pianista Bruno Canino, presenti nella
panoramicissima Sala Fontana del Museo del
Novecento per un concerto rappresentativo
anche di un loro recente Cd, denominato "20th-
century Middle European Flute Music". I
brani proposti, quasi
 tutti
presenti nell'incisione, rivelano il particolare
interesse degli interpreti per il repertorio
recente. Le qualità di Canino, da oltre
sessant'anni sulla scena concertistica
internazionale, sono a tutti note, unite a una
profonda curiosità intellettuale per le musiche
che spaziano dal Seicento sino ai giorni nostri.
Luisa Sello è tra le più rinomate flautiste
interessate alla musica del primo e del secondo
Novecento, come alla musica colta contemporanea.
Il programma presentava compositori poco
conosciuti, come i cechi Petr Eben (1929-2007)
ed Emil František
Burian (1904-1959),
insieme ad altri noti come l'austriaco,
naturalizzato statunitense, Ernst Heinrich
Křenek (1900-1991) e il tedesco Paul Dessau
(1894-1979). A chiudere il concerto, ecco il più
famoso Arnold
Schönberg (1874-1951), austriaco, inventore di
quella tecnica dodecafonica che cambierà il
linguaggio musicale per alcuni decenni. Brani
riferiti al mondo tonale, come la Sonatina
semplice (1957) di Eben, la Suite per
flauto e pianoforte (1954) di
Křenek
o Ztracené Serenády (1940) di Burian,
hanno anticipato la straordinaria intesa
musicale, ossia l'immediata comunicativa tra la
limpida melodicità del flauto di Luisa Sello, e
il nitore espressivo delle armonizzazioni di
Bruno Canino, un pianista che ha nella precisa
scansione temporale un altro punto di forza. tutti
presenti nell'incisione, rivelano il particolare
interesse degli interpreti per il repertorio
recente. Le qualità di Canino, da oltre
sessant'anni sulla scena concertistica
internazionale, sono a tutti note, unite a una
profonda curiosità intellettuale per le musiche
che spaziano dal Seicento sino ai giorni nostri.
Luisa Sello è tra le più rinomate flautiste
interessate alla musica del primo e del secondo
Novecento, come alla musica colta contemporanea.
Il programma presentava compositori poco
conosciuti, come i cechi Petr Eben (1929-2007)
ed Emil František
Burian (1904-1959),
insieme ad altri noti come l'austriaco,
naturalizzato statunitense, Ernst Heinrich
Křenek (1900-1991) e il tedesco Paul Dessau
(1894-1979). A chiudere il concerto, ecco il più
famoso Arnold
Schönberg (1874-1951), austriaco, inventore di
quella tecnica dodecafonica che cambierà il
linguaggio musicale per alcuni decenni. Brani
riferiti al mondo tonale, come la Sonatina
semplice (1957) di Eben, la Suite per
flauto e pianoforte (1954) di
Křenek
o Ztracené Serenády (1940) di Burian,
hanno anticipato la straordinaria intesa
musicale, ossia l'immediata comunicativa tra la
limpida melodicità del flauto di Luisa Sello, e
il nitore espressivo delle armonizzazioni di
Bruno Canino, un pianista che ha nella precisa
scansione temporale un altro punto di forza.
 Il
cambiamento di linguaggio espressivo, vicino al
mondo atonale iniziato con un intermezzo da
Guernica (1938) per solo pianoforte di
Dessau, eseguito con precisione dal Maestro, è
continuato con un brano con data compositiva più
lontana, il 1926, tratto dal Quintetto per
fiati op.26 di Schönberg, eseguito in
un'ottima trascrizione per flauto e pianoforte.
È un ampio movimento di un lavoro che nella sua
completezza dura oltre quaranta minuti: rivela
una tecnica dodecafonica restituita con lucidità
in perfezione e tempi dall'eccellente duo.
Successo meritatissimo in una Sala Fontana
stracolma di appassionati e concessione di un
bis di grande bellezza, con un brano di J.S.
Bach tra i più celebri: Siciliano, dalla
Sonata per flauto e cembalo BWV 1031.
Bravissimi! Il
cambiamento di linguaggio espressivo, vicino al
mondo atonale iniziato con un intermezzo da
Guernica (1938) per solo pianoforte di
Dessau, eseguito con precisione dal Maestro, è
continuato con un brano con data compositiva più
lontana, il 1926, tratto dal Quintetto per
fiati op.26 di Schönberg, eseguito in
un'ottima trascrizione per flauto e pianoforte.
È un ampio movimento di un lavoro che nella sua
completezza dura oltre quaranta minuti: rivela
una tecnica dodecafonica restituita con lucidità
in perfezione e tempi dall'eccellente duo.
Successo meritatissimo in una Sala Fontana
stracolma di appassionati e concessione di un
bis di grande bellezza, con un brano di J.S.
Bach tra i più celebri: Siciliano, dalla
Sonata per flauto e cembalo BWV 1031.
Bravissimi!
14 febbraio
2024 Cesare Guzzardella
Alle Serate Musicali
l'Orchestra Leonore diretta da Daniele
Giorgi e il cellista Kian Soltani
È una
compagine orchestrale formata soprattutto da
giovani strumentisti l'Orchestra Leonore,
fondata nel 2014 a Pistoia da Daniele Giorgi.
Ieri sera, per Serate Musicali,
l'impaginato era ricco di eccellente musica: due
capolavori di Dmitri
Šostakovič, la Sinfonia da camera per archi
in do minore op.110a e poi il Concerto
per violoncello in mi bem. maggiore op.107,
seguiti dalla Sinfonia n.2 in do maggiore
op.61 di Robert Schumann. In tutti i brani
l'orchestra ha raggiunto vette eccellenti;
l'accurata direzione di Giorgi
è riuscita ad
esaltare i due lavori del grande
 compositore
russo, datati rispettivamente 1960 e 1959, opere
quindi mature di
Šostakovič. La Sinfonia da camera
è in realta una
fedele e riuscita trascrizione del Quartetto
d'archi n.8 op. 110, realizzata dal
direttore Rudolf Barshai, potenziando le linee
melodiche degli strumenti. La profondità
espressiva di questa intensa composizione -
dedicata alle vittime del nazifascismo e della
guerra - è emersa in toto ed ha anticipato un
lavoro simile dal punto di vista espressivo,
quel celebre concerto, l'Op.107, eseguito
in questi sessant'anni dai massimi virtuosi del
violoncello a partire dal dedicatario Mistislav
Rostropovic. Kian Soltani, musicista nato a
Bregenz nel 1992 da genitori iraniani, ha
assolto il suo fondamentale compito solistico
ottimamente. Il virtuosismo emerso in questo
ampio lavoro si è avvalso di un violoncello
corposo - uno Stradivari "London ex
Boccherini 1694" - dalle sonorità precise,
ben delineate e particolarmente espressive in
tutti i contrasti volumetrici e dinamici
esternati da Soltani. Eccellente la sinergia con
la direzione di Giorgi e con le sezioni
orchestrali. Di qualità la lunga cadenza
solistica del terzo movimento. Rilevante il
melodioso bis solistico scelto da Soltani -
accompagnato da una sezione di due compositore
russo, datati rispettivamente 1960 e 1959, opere
quindi mature di
Šostakovič. La Sinfonia da camera
è in realta una
fedele e riuscita trascrizione del Quartetto
d'archi n.8 op. 110, realizzata dal
direttore Rudolf Barshai, potenziando le linee
melodiche degli strumenti. La profondità
espressiva di questa intensa composizione -
dedicata alle vittime del nazifascismo e della
guerra - è emersa in toto ed ha anticipato un
lavoro simile dal punto di vista espressivo,
quel celebre concerto, l'Op.107, eseguito
in questi sessant'anni dai massimi virtuosi del
violoncello a partire dal dedicatario Mistislav
Rostropovic. Kian Soltani, musicista nato a
Bregenz nel 1992 da genitori iraniani, ha
assolto il suo fondamentale compito solistico
ottimamente. Il virtuosismo emerso in questo
ampio lavoro si è avvalso di un violoncello
corposo - uno Stradivari "London ex
Boccherini 1694" - dalle sonorità precise,
ben delineate e particolarmente espressive in
tutti i contrasti volumetrici e dinamici
esternati da Soltani. Eccellente la sinergia con
la direzione di Giorgi e con le sezioni
orchestrali. Di qualità la lunga cadenza
solistica del terzo movimento. Rilevante il
melodioso bis solistico scelto da Soltani -
accompagnato da una sezione di due violoncelli e di contrabbassi- ossia il brano "Introduzione"
di
Šostakovic, dalla colonna sonora del film "Il
Tafano", del 1955. Lunghi e calorosi gli
applausi del pubblico. Dopo il breve intervallo
le qualità dell'
Orchestra Leonore e
del direttore Giorgi sono ancora emerse nella
restituzione della Sinfonia n.2 di
Schumann. Un' esecuzione trasparente, con linee
melodiche e armonie rilevate nei rispettivi
piani sonori ed esternate con precisione dalle
sezioni orchestrali. Di grande intensità l'Adagio
espressivo, terzo movimento del capolavoro
schumanniano: come bis la ripetizione del
ritmico Scherzo - Allegro vivace.
Splendido concerto! - Foto di Alberto
Panzani, Uff.Stampa Serate Musicali-.
violoncelli e di contrabbassi- ossia il brano "Introduzione"
di
Šostakovic, dalla colonna sonora del film "Il
Tafano", del 1955. Lunghi e calorosi gli
applausi del pubblico. Dopo il breve intervallo
le qualità dell'
Orchestra Leonore e
del direttore Giorgi sono ancora emerse nella
restituzione della Sinfonia n.2 di
Schumann. Un' esecuzione trasparente, con linee
melodiche e armonie rilevate nei rispettivi
piani sonori ed esternate con precisione dalle
sezioni orchestrali. Di grande intensità l'Adagio
espressivo, terzo movimento del capolavoro
schumanniano: come bis la ripetizione del
ritmico Scherzo - Allegro vivace.
Splendido concerto! - Foto di Alberto
Panzani, Uff.Stampa Serate Musicali-.
13 febbraio
2024 Cesare Guzzardella
Il Duo Alterno
per Musica Maestri! del Conservatorio
milanese
Per la
rassegna musicale del Conservatorio milanese "Musica
Maestri!" abbiamo ascoltato il Duo Alterno,
formato da due eclettici interpreti quali
Tiziana Scandaletti, soprano, e Riccardo
Piacentini, pianoforte . La formazione è
impegnata soprattutto nel repertorio del
Novecento e contemporaneo, con molti compositori
che hanno dedicato loro nuovi brani. Ieri, in
una Sala Puccini al completo, hanno proposto un
programma vario, incentrato soprattutto su brani
del primo Novecento di De Falla,
 Puccini,
Weill, Satie e su lavori di qualche decennio
dopo di Morricone e Piazzolla. Piacentini,
compositore oltre che ottimo pianista, ha
proposto anche un suo recente lavoro. Il
concerto, ben introdotto da Piacentini, era
denominato "Arie di danza", e prevedeva
brani ispirati al mondo dei valzer, del tango e
dalla musica popolare. Il duo ha proposto
inizialmente le note Siete Canciones
populares españolas di Manuel De Falla
(1876-1946), sette brevi canzoni che partendo da
alcune melodie popolari ritrovano il linguaggio
personale e raffinato del grande musicista
spagnolo. Valida l'interpretazione
dell'appariscente Scandaletti, accompagnata in
modo preciso da Piacentini. A seguire, due brani
per solo pianoforte, una rarità attribuita a
Giacomo Puccini (1858-1924), il Piccolo tango
(1910) e poi, sempre del grande compositore
lirico, il noto Valzer di Musetta da
Bohème, hanno ritrovato l'attenta lettura del
pianista. Il mondo del cabaret ha rivisto in
palcoscenico la Scandaletti con due brani di
Kurt Weill (1900-1950) tratti da Trois chansons:
Je ne t’aime pas e Youkali, Tango
Habanera. Entrambi i lavori ci rivelano la
passione per il canto Puccini,
Weill, Satie e su lavori di qualche decennio
dopo di Morricone e Piazzolla. Piacentini,
compositore oltre che ottimo pianista, ha
proposto anche un suo recente lavoro. Il
concerto, ben introdotto da Piacentini, era
denominato "Arie di danza", e prevedeva
brani ispirati al mondo dei valzer, del tango e
dalla musica popolare. Il duo ha proposto
inizialmente le note Siete Canciones
populares españolas di Manuel De Falla
(1876-1946), sette brevi canzoni che partendo da
alcune melodie popolari ritrovano il linguaggio
personale e raffinato del grande musicista
spagnolo. Valida l'interpretazione
dell'appariscente Scandaletti, accompagnata in
modo preciso da Piacentini. A seguire, due brani
per solo pianoforte, una rarità attribuita a
Giacomo Puccini (1858-1924), il Piccolo tango
(1910) e poi, sempre del grande compositore
lirico, il noto Valzer di Musetta da
Bohème, hanno ritrovato l'attenta lettura del
pianista. Il mondo del cabaret ha rivisto in
palcoscenico la Scandaletti con due brani di
Kurt Weill (1900-1950) tratti da Trois chansons:
Je ne t’aime pas e Youkali, Tango
Habanera. Entrambi i lavori ci rivelano la
passione per il canto
 popolare
del grande compositore tedesco della brechtiana
"Opera da tre soldi". Avvincente la resa
interpretativa molto teatrale del duo. Ritorno
quindi al solo pianoforte di Piacentini con Erik
Satie (1866-1925) e il suo breve ma evoluto
Le tango tratto da "Sports et
divertissements". Ennio Morricone (1928-2020)
aveva dedicato al Duo Alterno una versione del
suo Tango un po’ caricaturale, celebre
colonna sonora del film "Indagine su un
cittadino al di sopra di ogni sospetto",
rivedendo la parte vocale: poche note ben
cantate dalla Scandaletti. Con il brano di
Riccardo Piacentini (1958) denominato Eco
logico per pianoforte e foto-suoni, siamo
arrivati alla musica attuale dove il
pianista-compositore ha realizzato una parte
pianistica ottimamente scritta con una scansione
ritmico-armonica chiara e di particolare
ispirazione, inserita in un "tappeto sonoro"
pre-registrato, che crea una situazione
ambientale di suoni, voci e rumori. Una valida
performance, che ci ricorda esperienze del
periodo "concreto" post-anni '50. Il brano
conclusivo del programma ufficiale in duo
prevedeva la melodicissima e splendida Los
pájaros perdidos di Astor Piazzolla
(1921-1992), un brano interpretato con pregnante
espressività dalla voce energica della
Scandaletti e dalle armonie intense di
Piacentini. Applausi fragorosi e come bis un
raro e valido brano in inglese di Alfredo
Casella (1883-1947) ben interpretato dal Duo
Alterno. popolare
del grande compositore tedesco della brechtiana
"Opera da tre soldi". Avvincente la resa
interpretativa molto teatrale del duo. Ritorno
quindi al solo pianoforte di Piacentini con Erik
Satie (1866-1925) e il suo breve ma evoluto
Le tango tratto da "Sports et
divertissements". Ennio Morricone (1928-2020)
aveva dedicato al Duo Alterno una versione del
suo Tango un po’ caricaturale, celebre
colonna sonora del film "Indagine su un
cittadino al di sopra di ogni sospetto",
rivedendo la parte vocale: poche note ben
cantate dalla Scandaletti. Con il brano di
Riccardo Piacentini (1958) denominato Eco
logico per pianoforte e foto-suoni, siamo
arrivati alla musica attuale dove il
pianista-compositore ha realizzato una parte
pianistica ottimamente scritta con una scansione
ritmico-armonica chiara e di particolare
ispirazione, inserita in un "tappeto sonoro"
pre-registrato, che crea una situazione
ambientale di suoni, voci e rumori. Una valida
performance, che ci ricorda esperienze del
periodo "concreto" post-anni '50. Il brano
conclusivo del programma ufficiale in duo
prevedeva la melodicissima e splendida Los
pájaros perdidos di Astor Piazzolla
(1921-1992), un brano interpretato con pregnante
espressività dalla voce energica della
Scandaletti e dalle armonie intense di
Piacentini. Applausi fragorosi e come bis un
raro e valido brano in inglese di Alfredo
Casella (1883-1947) ben interpretato dal Duo
Alterno.
12 febbraio Cesare
Guzzardella
AL
VIOTTIFESTIVAL DI VERCELLI LA VIOLA DI
TIMOTHY RIDOUT
Ieri sera, 10
febbraio, al Teatro Civico di Vercelli, nuovo
appuntamento con l’ormai imperdibile
ViottiFestival. Due i motivi principali di
interesse del concerto: il programma, ricco di
autori e pezzi, italiani e no, di ascolto
piuttosto infrequente, tra ‘700 e ‘800,
contemporanei di Viotti, una cui composizione,
com’è consuetudine in questo secondo centenario
della sua morte, campeggiava al centro
dell’impaginato. Un programma, insomma,
intelligentemente studiato per ‘ricostruire’ una
parte di quel mondo musicale di cui Viotti fu
personaggio di primo piano. L’altro motivo di
interesse del concerto è stata la presenza di
uno dei maggiori violisti delle ultime
generazioni, il ventottenne inglese Timothy
Ridout, già noto al pubblico vercellese per un
concerto di gran successo della passata stagione;
è degno di nota lo strumento che Ridout suona
abitualmente, una viola molto antica, fabbricata
intorno al 1570 dal liutaio bresciano Pellegrino
di Zanetto, contraddistinta da un suono un po’
meno vellutato di quello delle viole più recenti,
ma di maggior volume ed intensità. Il concerto
ha inizio con una sinfonia di Luigi Boccherini,
la G 490 in Re maggiore, composta nel 1765,
ancora nel periodo ‘italiano’ del grande
compositore lucchese, prima del trasferimento
alla corte di Madrid, ove avrebbe trascorso il
resto della sua vita. Divisa, secondo la tipica
caratteristica della sinfonia ‘all’italiana’, in
tre tempi, col movimento lento centrale e i due
Allegri esterni, si tratta probabilmente della
 sua
prima sinfonia, composta come sinfonia d’opera e
utilizzata come tale in un paio di occasioni. Il
Re maggiore, tonalità amata dal Boccherini
sinfonista, nella cultura musicale barocca e
rococò è considerata tonalità “guerresca e
gioiosa”, secondo la definizione dello
Charpentier e i due tempi esterni hanno, specie
il primo, un piglio impetuoso, un ritmo da
marcia guerresca, appunto, cui fa da contraltare
il melodismo di sapore galante, ma con una vena
di sensibilità particolarmente intensa,
dell’Adagio grazioso. L’interpretazione di
Rimonda, alla guida della sua Camerata Ducale, è
impareggiabile nel rendere, con raffinata
eleganza, il vario gioco dei timbri e il libero
contrasto dei temi, e, soprattutto, il suadente
lirismo, di chiara origine operistica, del tempo
lento centrale. Contemporaneo di Boccherini e di
Viotti fu Alessandro Rolla (1757-1841, quasi
coetaneo di Viotti), pavese di nascita, ma
protagonista della vita musicale milanese per
quasi tutta la prima metà dell’800, in qualità
sia di direttore del Teatro alla Scala per
trent’anni, che di fatto segnarono
l’affermazione del Teatro milanese a livello
europeo, sia come direttore del Conservatorio
(pare sia stato proprio lui a bocciare il
giovane Verdi all’esame di ammissione). Nella
Storia della musica occupa un ruolo di primo
piano come padre della scuola violinistica
lombarda e soprattutto come straordinario
violista, forse il più grande in tutta Europa a
quel tempo. Di A. Rolla sono state eseguite due
composizioni: una delle 12 sinfonie, la BI 533
in Re maggiore e il Concerto per viola e
orchestra in Mi bem. maggiore BI 545, uno dei
quindici scritti da Rolla per questo strumento.
Nei tre movimenti in cui anche questa sinfonia è
divisa, senti già fermentare i primi sentori di
un nuovo spirito musicale: l’interpretazione di
Guido Rimonda fa affiorare, dal Re maggiore di
Rolla, una tensione drammatica nel ritmo e nel
contrasto tra le linee tematiche, che spezza la
limpida cornice galante presente ancora nella
sinfonia di Boccherini, per gettare le sue ombre
anche nel tempo lento centrale e portando allo
scoperto quel non so che di preromantico che si
avverte nei momenti più suggestivi della
sinfonia; non è forse un caso che la prima
esecuzione assoluta di tre sinfonie di Beethoven
in Italia sia dovuta a Rolla (che fu anche
valente direttore d’orchestra) cui dobbiamo
guardare come un esponente di quella cultura
strumentale di derivazione austriaca che si
stava, sia pur timidamente, facendo strada
nell’Italia del nord e soprattutto a Milano agli
inizi dell’800, per poi essere travolta dal
predominio schiacciante della musica operistica.
Una davvero gradita sorpresa il concerto per
viola di Rolla, decisamente una delle
composizioni più belle scritte per questo
strumento nella prima metà dell’800, “Aroldo in
Italia” a parte. Il primo tempo, Allegro, ma
aperto da un Andante sostenuto intonato ad un Mi
bem. maggiore di sapore beethoveniano, per la
sua corrusca drammaticità, si caratterizza per i
ricchi contrasti sua
prima sinfonia, composta come sinfonia d’opera e
utilizzata come tale in un paio di occasioni. Il
Re maggiore, tonalità amata dal Boccherini
sinfonista, nella cultura musicale barocca e
rococò è considerata tonalità “guerresca e
gioiosa”, secondo la definizione dello
Charpentier e i due tempi esterni hanno, specie
il primo, un piglio impetuoso, un ritmo da
marcia guerresca, appunto, cui fa da contraltare
il melodismo di sapore galante, ma con una vena
di sensibilità particolarmente intensa,
dell’Adagio grazioso. L’interpretazione di
Rimonda, alla guida della sua Camerata Ducale, è
impareggiabile nel rendere, con raffinata
eleganza, il vario gioco dei timbri e il libero
contrasto dei temi, e, soprattutto, il suadente
lirismo, di chiara origine operistica, del tempo
lento centrale. Contemporaneo di Boccherini e di
Viotti fu Alessandro Rolla (1757-1841, quasi
coetaneo di Viotti), pavese di nascita, ma
protagonista della vita musicale milanese per
quasi tutta la prima metà dell’800, in qualità
sia di direttore del Teatro alla Scala per
trent’anni, che di fatto segnarono
l’affermazione del Teatro milanese a livello
europeo, sia come direttore del Conservatorio
(pare sia stato proprio lui a bocciare il
giovane Verdi all’esame di ammissione). Nella
Storia della musica occupa un ruolo di primo
piano come padre della scuola violinistica
lombarda e soprattutto come straordinario
violista, forse il più grande in tutta Europa a
quel tempo. Di A. Rolla sono state eseguite due
composizioni: una delle 12 sinfonie, la BI 533
in Re maggiore e il Concerto per viola e
orchestra in Mi bem. maggiore BI 545, uno dei
quindici scritti da Rolla per questo strumento.
Nei tre movimenti in cui anche questa sinfonia è
divisa, senti già fermentare i primi sentori di
un nuovo spirito musicale: l’interpretazione di
Guido Rimonda fa affiorare, dal Re maggiore di
Rolla, una tensione drammatica nel ritmo e nel
contrasto tra le linee tematiche, che spezza la
limpida cornice galante presente ancora nella
sinfonia di Boccherini, per gettare le sue ombre
anche nel tempo lento centrale e portando allo
scoperto quel non so che di preromantico che si
avverte nei momenti più suggestivi della
sinfonia; non è forse un caso che la prima
esecuzione assoluta di tre sinfonie di Beethoven
in Italia sia dovuta a Rolla (che fu anche
valente direttore d’orchestra) cui dobbiamo
guardare come un esponente di quella cultura
strumentale di derivazione austriaca che si
stava, sia pur timidamente, facendo strada
nell’Italia del nord e soprattutto a Milano agli
inizi dell’800, per poi essere travolta dal
predominio schiacciante della musica operistica.
Una davvero gradita sorpresa il concerto per
viola di Rolla, decisamente una delle
composizioni più belle scritte per questo
strumento nella prima metà dell’800, “Aroldo in
Italia” a parte. Il primo tempo, Allegro, ma
aperto da un Andante sostenuto intonato ad un Mi
bem. maggiore di sapore beethoveniano, per la
sua corrusca drammaticità, si caratterizza per i
ricchi contrasti
 tematici,
che non contemplano un vero e proprio sviluppo,
ma presentano una ricca elaborazione, tra un
tema inquieto e ricco di pathos ed uno di più
aggraziata melodiosità mozartiana, con sapienti
scelte timbriche, tra cui giocano un ruolo
importante, poco prima dell’ingresso della
viola, l’oboe e il corno, a preparare il terreno
alla tinta sonora della viola. Ridout conferma
la sua fama con un’esecuzione semplicemente
perfetta: il suo virtuosismo da mattatore è
sempre posto al servizio di un arricchimento
espressivo, ora nel dialogo con l’orchestra, che
ha un ruolo tutt’altro che di puro
accompagnamento, ora negli assoli e nella stessa
cadenza. Con una cavata di incantevole
morbidezza, Ridout sfrutta con finezza tutta la
gamma delle possibilità espressive offerta dalla
viola, questo strumento ingiustamente un po’
negletto, ma capace di offrire momenti di intima
dolcezza ‘crepuscolare, che è poi il colore
dominante della composizione. Trascorrendo dal
registro acuto, a quello più grave, contraltile-
baritonale, ricorrendo con particolare
insistenza all’uso delle corde più ‘calde’ della
viola, Ridout ci regala momenti di vera poesia,
che hanno il loro apice, com’è naturale, nel
Largo centrale. Indimenticabile l’ingresso della
viola, a riprendere il dolce tema principale,
con un tono sommesso e mormorante, di lirismo
purissimo, capace davvero di toccare le corde
più profonde dell’animo dell’ascoltatore, per
poi, in un’ampia sezione in assolo, quasi una
lunga cadenza, elaborare il tema con un gioco
prodigioso di doppie corde, che ne amplia la
risonanza e ne arricchisce il pathos, specie in
acuto, ma con un gioco continuo di penombre, con
i registri più gravi, che, sostenuti dai
violoncelli, sembrano affondare la linea
melodica nell’incanto di una luce che, sul punto
di spegnersi, manda i suoi ultimi bagliori. In
generale, Ridout ottiene i suoi più alti
risultati espressivi con un legato di limpida
fluidità, screziato da un vibrato usato sempre
al momento giusto e di suggestiva delicatezza
Splendido Ridout e splendida la Camerata Ducale
e la direzione di Rimonda nell’accompagnare il
solista in questa magia musicale. Il Rondò
finale, forse il meno musicalmente interessante
dei tre movimenti del concerto, si offre a
Ridout come il palcoscenico per esibire tutta la
sua pirotecnica bravura di virtuoso, in
particolare nei couplet, ove la sua viola
trapassa veloce tutti i registri, per
raggiungere la vertigine del sovracuto, con
un’antologia di colpi d’arco violinistici, ,
resi ancora più ardui sulla viola, che rispetto
al violino, presenta dimensioni un po’ più
grandi, imponendo alla mano sinistra posizioni
più dilatate delle dita sulle corde. Come detto,
al centro del programma del concerto era
l’Andante in Fa maggiore che Viotti stesso
trasse da un proprio duetto per violini in una
versione per orchestra d’archi. E’ una
composizione del miglior Viotti, diretta dal
miglior interprete di Viotti oggi in Italia, e
forse al mondo, Guido Rimonda. Introdotta da
un’apertura di intimo e intenso lirismo, si fa
poi più mossa e contrastata, con un gioco vario
dei timbri tra le diverse sezioni degli archi,
efficacemente valorizzata da Rimonda. Si tratta
di un pezzo che, una volta di più, iscrive di
pieno diritto il compositore vercellese in
quella generazione di passaggio al Romanticismo,
in cui, superato lo stile galante e la delicata
sensiblerie rococò, la musica si avvia
all’esplorazione di nuove, più intense ricerche
espressive. Si lascia l’Italia per la Vienna di
Schubert col penultimo pezzo in concerto, ancora
una volta all’insegna della rarità, non essendo
certo tra le composizioni più eseguite del
catalogo schubertiano: si tratta dell’Ouverture
in do minore D 8, opera del periodo giovanile di
Schubert, di cui esistono anche versioni
cameristiche, per quartetto o quintetto d’archi,
ma ieri sera a Vercelli presentata nella
versione per orchestra e viola. Confessiamo
onestamente il nostro imbarazzo nel dover
ammettere che l’Ouverture D8 ascoltata ieri a
Vercelli ci è risultata irriconoscibile rispetto
a quella a noi nota, in versione orchestrale: il
brano presentato ieri era una composizione molto
breve, in cui primeggiava l’intenso lirismo
della viola, lontano dal cupo do minore ancora
beethoveniano che impronta l’Ouverture D8 di
Schubert che conosciamo, tra l’altro di durata
ben più estesa rispetto a quella eseguita ieri.
Non sappiamo francamente come spiegare la cosa…
Gran finale all’insegna della viola e del
virtuosismo di Ridout, con il Potpourri per
viola e orchestra di Johann Nepomuch Hummel
(1778-1837). Vissuto da giovane a Vienna, ove
ebbe maestri d’eccezione come Mozart ed Haydn, e
a Londra, ove studiò con Clementi, acclamato
come fanciullo prodigio, è noto soprattutto come
pianista e compositore per pianoforte. Questo
Potpourri, composto nel 1820, è ovviamente un
pezzo mirato ad esaltare le qualità
virtuosistiche del solista (fu dedicato infatti
a un grande violista del tempo, Antoine Schmiedl),
ma l’orchestra non si limita ad una pura
funzione di accompagnamento, ma anzi interviene
sovente a dialogare col solista o addiritura ad
occupare interamente la scena. Notevole anche la
presenza massiccia di citazioni da temi e motivi
di pura marca mozartiana, che peraltro è un
fatto ricorrente nella musica di Hummel. Per
quanto riguarda Ridout, da questo Potpourri
mozartiano-hummeliano esce confermata la
capacità di questo giovane, ma già grande
violista, di coniugare abilità tecnica ed
espressività, improntata ad un lirismo di grande
melodicità nelle sezioni più lente del brano e
ad un gioioso slancio vitale nelle sezioni
dall’agogica più mossa, con una grazia raffinata
nelle parti più mozartiane del Potpourri. I suoi
colpi d’arco, e il suo vibrato sempre sicuri,
frutto di un grande talento, hanno conquistato
ancora una volta il pubblico del Teatro Civico,
dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, quanto
ingiusta sia stata la considerazione, prevalsa
tra i compositori fino almeno a tutto l’’800,
della viola come ‘figlia di un dio minore’
rispetto al violino, sottovalutandone le
capacità espressive. Gli entusiastici applausi
del pubblico sono stati premiati da due bis di
Ridout: la Fantasia per sola viola n.7 di
Telemann, pezzo di intenso pathos, e la
ripetizione del Finale del concerto di Rolla.
Un’altra serata musicale, dunque, di gran
livello, quella di ieri al ViottiFestival e in
tutto degna delle celebrazioni del grande
Maestro vercellese.(Foto ufficio Stampa di Vercelli) tematici,
che non contemplano un vero e proprio sviluppo,
ma presentano una ricca elaborazione, tra un
tema inquieto e ricco di pathos ed uno di più
aggraziata melodiosità mozartiana, con sapienti
scelte timbriche, tra cui giocano un ruolo
importante, poco prima dell’ingresso della
viola, l’oboe e il corno, a preparare il terreno
alla tinta sonora della viola. Ridout conferma
la sua fama con un’esecuzione semplicemente
perfetta: il suo virtuosismo da mattatore è
sempre posto al servizio di un arricchimento
espressivo, ora nel dialogo con l’orchestra, che
ha un ruolo tutt’altro che di puro
accompagnamento, ora negli assoli e nella stessa
cadenza. Con una cavata di incantevole
morbidezza, Ridout sfrutta con finezza tutta la
gamma delle possibilità espressive offerta dalla
viola, questo strumento ingiustamente un po’
negletto, ma capace di offrire momenti di intima
dolcezza ‘crepuscolare, che è poi il colore
dominante della composizione. Trascorrendo dal
registro acuto, a quello più grave, contraltile-
baritonale, ricorrendo con particolare
insistenza all’uso delle corde più ‘calde’ della
viola, Ridout ci regala momenti di vera poesia,
che hanno il loro apice, com’è naturale, nel
Largo centrale. Indimenticabile l’ingresso della
viola, a riprendere il dolce tema principale,
con un tono sommesso e mormorante, di lirismo
purissimo, capace davvero di toccare le corde
più profonde dell’animo dell’ascoltatore, per
poi, in un’ampia sezione in assolo, quasi una
lunga cadenza, elaborare il tema con un gioco
prodigioso di doppie corde, che ne amplia la
risonanza e ne arricchisce il pathos, specie in
acuto, ma con un gioco continuo di penombre, con
i registri più gravi, che, sostenuti dai
violoncelli, sembrano affondare la linea
melodica nell’incanto di una luce che, sul punto
di spegnersi, manda i suoi ultimi bagliori. In
generale, Ridout ottiene i suoi più alti
risultati espressivi con un legato di limpida
fluidità, screziato da un vibrato usato sempre
al momento giusto e di suggestiva delicatezza
Splendido Ridout e splendida la Camerata Ducale
e la direzione di Rimonda nell’accompagnare il
solista in questa magia musicale. Il Rondò
finale, forse il meno musicalmente interessante
dei tre movimenti del concerto, si offre a
Ridout come il palcoscenico per esibire tutta la
sua pirotecnica bravura di virtuoso, in
particolare nei couplet, ove la sua viola
trapassa veloce tutti i registri, per
raggiungere la vertigine del sovracuto, con
un’antologia di colpi d’arco violinistici, ,
resi ancora più ardui sulla viola, che rispetto
al violino, presenta dimensioni un po’ più
grandi, imponendo alla mano sinistra posizioni
più dilatate delle dita sulle corde. Come detto,
al centro del programma del concerto era
l’Andante in Fa maggiore che Viotti stesso
trasse da un proprio duetto per violini in una
versione per orchestra d’archi. E’ una
composizione del miglior Viotti, diretta dal
miglior interprete di Viotti oggi in Italia, e
forse al mondo, Guido Rimonda. Introdotta da
un’apertura di intimo e intenso lirismo, si fa
poi più mossa e contrastata, con un gioco vario
dei timbri tra le diverse sezioni degli archi,
efficacemente valorizzata da Rimonda. Si tratta
di un pezzo che, una volta di più, iscrive di
pieno diritto il compositore vercellese in
quella generazione di passaggio al Romanticismo,
in cui, superato lo stile galante e la delicata
sensiblerie rococò, la musica si avvia
all’esplorazione di nuove, più intense ricerche
espressive. Si lascia l’Italia per la Vienna di
Schubert col penultimo pezzo in concerto, ancora
una volta all’insegna della rarità, non essendo
certo tra le composizioni più eseguite del
catalogo schubertiano: si tratta dell’Ouverture
in do minore D 8, opera del periodo giovanile di
Schubert, di cui esistono anche versioni
cameristiche, per quartetto o quintetto d’archi,
ma ieri sera a Vercelli presentata nella
versione per orchestra e viola. Confessiamo
onestamente il nostro imbarazzo nel dover
ammettere che l’Ouverture D8 ascoltata ieri a
Vercelli ci è risultata irriconoscibile rispetto
a quella a noi nota, in versione orchestrale: il
brano presentato ieri era una composizione molto
breve, in cui primeggiava l’intenso lirismo
della viola, lontano dal cupo do minore ancora
beethoveniano che impronta l’Ouverture D8 di
Schubert che conosciamo, tra l’altro di durata
ben più estesa rispetto a quella eseguita ieri.
Non sappiamo francamente come spiegare la cosa…
Gran finale all’insegna della viola e del
virtuosismo di Ridout, con il Potpourri per
viola e orchestra di Johann Nepomuch Hummel
(1778-1837). Vissuto da giovane a Vienna, ove
ebbe maestri d’eccezione come Mozart ed Haydn, e
a Londra, ove studiò con Clementi, acclamato
come fanciullo prodigio, è noto soprattutto come
pianista e compositore per pianoforte. Questo
Potpourri, composto nel 1820, è ovviamente un
pezzo mirato ad esaltare le qualità
virtuosistiche del solista (fu dedicato infatti
a un grande violista del tempo, Antoine Schmiedl),
ma l’orchestra non si limita ad una pura
funzione di accompagnamento, ma anzi interviene
sovente a dialogare col solista o addiritura ad
occupare interamente la scena. Notevole anche la
presenza massiccia di citazioni da temi e motivi
di pura marca mozartiana, che peraltro è un
fatto ricorrente nella musica di Hummel. Per
quanto riguarda Ridout, da questo Potpourri
mozartiano-hummeliano esce confermata la
capacità di questo giovane, ma già grande
violista, di coniugare abilità tecnica ed
espressività, improntata ad un lirismo di grande
melodicità nelle sezioni più lente del brano e
ad un gioioso slancio vitale nelle sezioni
dall’agogica più mossa, con una grazia raffinata
nelle parti più mozartiane del Potpourri. I suoi
colpi d’arco, e il suo vibrato sempre sicuri,
frutto di un grande talento, hanno conquistato
ancora una volta il pubblico del Teatro Civico,
dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, quanto
ingiusta sia stata la considerazione, prevalsa
tra i compositori fino almeno a tutto l’’800,
della viola come ‘figlia di un dio minore’
rispetto al violino, sottovalutandone le
capacità espressive. Gli entusiastici applausi
del pubblico sono stati premiati da due bis di
Ridout: la Fantasia per sola viola n.7 di
Telemann, pezzo di intenso pathos, e la
ripetizione del Finale del concerto di Rolla.
Un’altra serata musicale, dunque, di gran
livello, quella di ieri al ViottiFestival e in
tutto degna delle celebrazioni del grande
Maestro vercellese.(Foto ufficio Stampa di Vercelli)
11 febbraio 2024 Bruno Busca
Edgar Moreau
e Kolja Blacher in Auditorium per Haydn e
Čaikovskij
Il
classicismo haydniano e il romanticismo di
Čaikovskij hanno visto
ieri sera
sul palcoscenico dell'Auditorium milanese il
ventinovenne violoncellista parigino Edgar
Moreau e il direttore - anche violinista-
tedesco Kolja Blacher per due brani noti quali
il Concerto per violoncello e orchestra n.2
in Re maggiore di J.Haydn (1732-1809) e la
Sinfonia n.5 in Mi minore op.64 di P.I.
Čaikovskij (1840-1893). Più
di cento anni
separano la composizione classica del musicista
austriaco da quella del russo. I due lavori
prevedevano una formazione numericamente
 più
contenuta per il concerto violoncellistico, che
data 1783, e una compagine sinfonica ampia per
la penultima sinfonia del compositore russo,
composta nel 1888 e indicativa dello sviluppo
creativo dell'autore portato ai suoi vertici
espressivi. Lo straordinario concerto di Haydn,
nei classici tre movimenti, è stato sostenuto
con evidente chiarezza timbrica da Moreau. Il
suo violoncello, sempre in risalto con
un'intonazione voluminosa ed elegante, era
sottolineato dalle discrete timbriche
orchestrali organizzate ottimamente da Blacher
per esaltare la profonda voce dello strumento ad
arco. Moreau, attento ad ogni particolare del
brano, ha anche sottolineato con chiarezza
espressiva la lunga cadenza solistica dell'Allegro
moderato iniziale. L'eccellente intesa
d'insieme ha delineato un'interpretazione
complessiva di alta qualità, molto apprezzata
dal numeroso pubblico presente in Auditorium.
Applausi fragorosi al protagonista e di profonda
resa il bis bachiano solistico concesso dal
cellista. più
contenuta per il concerto violoncellistico, che
data 1783, e una compagine sinfonica ampia per
la penultima sinfonia del compositore russo,
composta nel 1888 e indicativa dello sviluppo
creativo dell'autore portato ai suoi vertici
espressivi. Lo straordinario concerto di Haydn,
nei classici tre movimenti, è stato sostenuto
con evidente chiarezza timbrica da Moreau. Il
suo violoncello, sempre in risalto con
un'intonazione voluminosa ed elegante, era
sottolineato dalle discrete timbriche
orchestrali organizzate ottimamente da Blacher
per esaltare la profonda voce dello strumento ad
arco. Moreau, attento ad ogni particolare del
brano, ha anche sottolineato con chiarezza
espressiva la lunga cadenza solistica dell'Allegro
moderato iniziale. L'eccellente intesa
d'insieme ha delineato un'interpretazione
complessiva di alta qualità, molto apprezzata
dal numeroso pubblico presente in Auditorium.
Applausi fragorosi al protagonista e di profonda
resa il bis bachiano solistico concesso dal
cellista.
 Dopo
l'intervallo, la celebre Quinta Sinfonia
di
Čaikovskij ha trovato una riuscita
interpretazione dell'Orchestra Sinfonica di
Milano, sempre molto disponibile e preparata con
i compositori russi. Il direttore Blacher ha
rivelato estrema sintonia con la musica di
Čaikovskij, attraverso una scelta eccellente
nelle andature che danno equilibrio ai quattro
movimenti del corposo brano. Ottime le timbriche
elargite con espressività
da ogni sezione
orchestrale, e ben rilevati l'impasto dei colori
nei riconoscibili piani sonori che trovano la
massima elargizione nell'originale Finale.
Andante maestoso, ultimo movimento del brano.
Interpretazione complessiva di evidente qualità.
Applausi sostenuti e di lunga durata a Blacher e
ai bravissimi orchestrali. Domenica alle ore
16.00 la replica. Da non perdere. Dopo
l'intervallo, la celebre Quinta Sinfonia
di
Čaikovskij ha trovato una riuscita
interpretazione dell'Orchestra Sinfonica di
Milano, sempre molto disponibile e preparata con
i compositori russi. Il direttore Blacher ha
rivelato estrema sintonia con la musica di
Čaikovskij, attraverso una scelta eccellente
nelle andature che danno equilibrio ai quattro
movimenti del corposo brano. Ottime le timbriche
elargite con espressività
da ogni sezione
orchestrale, e ben rilevati l'impasto dei colori
nei riconoscibili piani sonori che trovano la
massima elargizione nell'originale Finale.
Andante maestoso, ultimo movimento del brano.
Interpretazione complessiva di evidente qualità.
Applausi sostenuti e di lunga durata a Blacher e
ai bravissimi orchestrali. Domenica alle ore
16.00 la replica. Da non perdere.
10 febbraio
2024 Cesare Guzzardella
Successo al Teatro
alla Scala per
Alcina in forma di concerto diretta da Marc
Minkowski
È
tornata alla Scala, questa volta in forma di
concerto, Alcina di Georg Friedrich
Händel. Nel marzo del 2009 questo capolavoro del
teatro musicale settecentesco venne
rappresentato in forma scenica. Ieri nell'unica
serata in programma, la compagine barocca Les
Musiciens du Louvre diretta da Marc
Minkowski, ha riportato la splendida musica del
compositore tedesco - naturalizzato inglese- in
teatro, con un cast vocale d'eccellenza.
Ricordiamo che Alcina venne composta nel 1734-35
su libretto anonimo ispirato da L'isola di
Alcina di Antonio Falzaglia,
 tratto
dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Il
contenuto è una variante del mito di Circe,
incantatrice fatale che attrae gli uomini col
canto su di un’isola paradisiaca e, dopo averli
sedotti, li trasforma in rocce, animali o piante.
Alcina è un susseguirsi di splendide Arie col
da capo che mettono in risalto la struttura
psicologica dei protagonisti: non solo
l'incantatrice Alcina e il paladino
Ruggiero ma anche Morgana, Bradamante,
Melisso, Oronte e Oberto hanno un
ruolo di grande rilievo. Un'esecuzione in forma
di concerto era stata data al
teatro del Piermarini nell'aprile del 1985 e in
quell'occasione il ruolo della protagonista che
da il nome al capolavoro händeliano, venne
interpretato da Luciana Serra. Ieri la compagine
strumentale parigina, fondata da Marc Minkowski
nel 1982, era ben visibile sul palcoscenico
scaligero. Il direttore ha introdotto il primo
atto con un' Ouverture strumentale
anticipatrice dei numerosissimi interventi
solistici dei protagonisti, un'introduzione che
ha da subito segnato la cifra stilistica della
direzione di Minkowski: energica, grintosa e
attenta ad ogni dettaglio, con anche momenti di
pacata esternazione coloristica. L'enunciazione
delle arie è in crescendo man mano che si arriva
al terzo atto, dove la quantità di melodie
raggiunge un numero maggiore d'interventi. tratto
dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Il
contenuto è una variante del mito di Circe,
incantatrice fatale che attrae gli uomini col
canto su di un’isola paradisiaca e, dopo averli
sedotti, li trasforma in rocce, animali o piante.
Alcina è un susseguirsi di splendide Arie col
da capo che mettono in risalto la struttura
psicologica dei protagonisti: non solo
l'incantatrice Alcina e il paladino
Ruggiero ma anche Morgana, Bradamante,
Melisso, Oronte e Oberto hanno un
ruolo di grande rilievo. Un'esecuzione in forma
di concerto era stata data al
teatro del Piermarini nell'aprile del 1985 e in
quell'occasione il ruolo della protagonista che
da il nome al capolavoro händeliano, venne
interpretato da Luciana Serra. Ieri la compagine
strumentale parigina, fondata da Marc Minkowski
nel 1982, era ben visibile sul palcoscenico
scaligero. Il direttore ha introdotto il primo
atto con un' Ouverture strumentale
anticipatrice dei numerosissimi interventi
solistici dei protagonisti, un'introduzione che
ha da subito segnato la cifra stilistica della
direzione di Minkowski: energica, grintosa e
attenta ad ogni dettaglio, con anche momenti di
pacata esternazione coloristica. L'enunciazione
delle arie è in crescendo man mano che si arriva
al terzo atto, dove la quantità di melodie
raggiunge un numero maggiore d'interventi. L'eccellente sinergia tra la preziosa direzione
di Minkowski con la dettagliata restituzione
della compagine strumentale e con le voci dei
sette protagonisti, hanno portato ad una resa
complessiva di ottima qualità, con molti
frangenti d'eccellenza. Tutti validi i cantanti,
molto immedesimati anche attorialmente, a
partire dalla principale interprete, Magdalena
Kožená
in
Alcina,
un mezzosoprano di pregnante espressività che
soprattutto nelle arie più rilevanti come Ah
mio cor! Schernito sei, Ombre pallide e
Mi restano le lagrime, raggiunge livelli
interpretativi eccellenti. Di raffinata vocalità
il soprano Erin Morley in Morgana, con
l'eccellente celebre aria Tornami a
vagheggiar, finale del primo atto o
Credete al mio dolor del terzo atto. Di
rilevante spessore espressivo sia Anna
Bonitatibus in Ruggiero, che Elizabeth
DeShong in Bradamante, mezzosoprano e
contralto tra le più applaudite. Notevoli poi:
Valerio Contaldo in Oronte con voce
tenorile di particolare incisività e chiarezza
coloristica; Alex Rosen in Melisso con
voce da basso ricca di calore e il controtenore
Alois Mühlbacher, un Oberto di pregnante
e chiara resa timbrica. Di rilievo la componente
corale ed eccellenti gli interventi solistici
strumentali, in accompagnamento del canto, del
primo violino, del violoncello e dei due flauti
barocchi che di fronte al pubblico hanno
concluso il finale dell'opera. Applausi
fragorosi e continuati a tutti i protagonisti
dal numerosissimo pubblico inervenuto in Scala
per l'unica rappresentazione. Tre ore e venti
minuti di eccellente musica certamente da
ricordare a lungo.
L'eccellente sinergia tra la preziosa direzione
di Minkowski con la dettagliata restituzione
della compagine strumentale e con le voci dei
sette protagonisti, hanno portato ad una resa
complessiva di ottima qualità, con molti
frangenti d'eccellenza. Tutti validi i cantanti,
molto immedesimati anche attorialmente, a
partire dalla principale interprete, Magdalena
Kožená
in
Alcina,
un mezzosoprano di pregnante espressività che
soprattutto nelle arie più rilevanti come Ah
mio cor! Schernito sei, Ombre pallide e
Mi restano le lagrime, raggiunge livelli
interpretativi eccellenti. Di raffinata vocalità
il soprano Erin Morley in Morgana, con
l'eccellente celebre aria Tornami a
vagheggiar, finale del primo atto o
Credete al mio dolor del terzo atto. Di
rilevante spessore espressivo sia Anna
Bonitatibus in Ruggiero, che Elizabeth
DeShong in Bradamante, mezzosoprano e
contralto tra le più applaudite. Notevoli poi:
Valerio Contaldo in Oronte con voce
tenorile di particolare incisività e chiarezza
coloristica; Alex Rosen in Melisso con
voce da basso ricca di calore e il controtenore
Alois Mühlbacher, un Oberto di pregnante
e chiara resa timbrica. Di rilievo la componente
corale ed eccellenti gli interventi solistici
strumentali, in accompagnamento del canto, del
primo violino, del violoncello e dei due flauti
barocchi che di fronte al pubblico hanno
concluso il finale dell'opera. Applausi
fragorosi e continuati a tutti i protagonisti
dal numerosissimo pubblico inervenuto in Scala
per l'unica rappresentazione. Tre ore e venti
minuti di eccellente musica certamente da
ricordare a lungo.
9 febbraio
2024 Cesare Guzzardella
Stefano Montanari
e
Antonio Alessandri per "I
Pomeriggi Musicali "
Un'anteprima di qualità
quella di questa mattina con l'Orchestra
de I Pomeriggi Musicali
diretta da Stefano
Montanari. I tre brani in programma avevano come
lavoro centrale l'ancor poco eseguito
Concerto n.2 in sol minore
per pianoforte e orchestra
di Camille Saint-Saëns con
un solista d'eccellenza,
il giovanissimo
Antonio Alessandri. Ancora diciassettenne, ma
prossimo alla maggiore età, Alessandri stupisce
per virtuosismo,
 chiarezza espressiva e
raffinato senso dell'equilibrio complessivo. Nel
non facile concerto del compositore francese la
parte solistica era dominante e comunque
integrata con situazioni orchestrali importanti
restituite benissimo nell'eccellente direzione
di Montanari e con energica restituzione
espressiva
da
I
Pomeriggi. La
componente melodica pianistica, ricca di
armonizzazioni elargite con sicurezza dal
giovane interprete, ha rivelato un' eccellente
discorsività e un'ottima sottolineatura del
materiale nei diversi piani sonori. I colori,
spesso delicati, si alternavano a timbriche
grintose sia chiarezza espressiva e
raffinato senso dell'equilibrio complessivo. Nel
non facile concerto del compositore francese la
parte solistica era dominante e comunque
integrata con situazioni orchestrali importanti
restituite benissimo nell'eccellente direzione
di Montanari e con energica restituzione
espressiva
da
I
Pomeriggi. La
componente melodica pianistica, ricca di
armonizzazioni elargite con sicurezza dal
giovane interprete, ha rivelato un' eccellente
discorsività e un'ottima sottolineatura del
materiale nei diversi piani sonori. I colori,
spesso delicati, si alternavano a timbriche
grintose sia
 nell'Andantino
sostenuto iniziale
che nell'inconsueto
Allegretto scherzando
centrale, sino al
bellissimo Presto
finale. Una splendida interpretazione, salutata
dai fragorosi applausi del numeroso pubblico
presente al Dal Verme, con anche molti studenti
intervenuti da molti plessi scolastici. Il
concerto è stato anticipato dall'Ouverture
dell'opera
Idomeneo, re di Creta
di W.A. Mozart
diretta con energico spessore timbrico da
Montanari e dall'Orchestra. L'ultimo brano in
programma, la
Sinfonia n.2 in Re maggiore op.36
di Beethoven, ha trovato
un'ottima esternazione da
I Pomeriggi
grazie alla visione
complessiva chiara e dettagliata di Montanari.
Di eccellente qualità l'Adagio
molto.Allegro con brio
iniziale. Fragorosi
applausi ai protagonisti. Questa sera alle ore
20.00 la prima ufficiale e sabato, alle ore
17.00, la replica. Assolutamente da non perdere. nell'Andantino
sostenuto iniziale
che nell'inconsueto
Allegretto scherzando
centrale, sino al
bellissimo Presto
finale. Una splendida interpretazione, salutata
dai fragorosi applausi del numeroso pubblico
presente al Dal Verme, con anche molti studenti
intervenuti da molti plessi scolastici. Il
concerto è stato anticipato dall'Ouverture
dell'opera
Idomeneo, re di Creta
di W.A. Mozart
diretta con energico spessore timbrico da
Montanari e dall'Orchestra. L'ultimo brano in
programma, la
Sinfonia n.2 in Re maggiore op.36
di Beethoven, ha trovato
un'ottima esternazione da
I Pomeriggi
grazie alla visione
complessiva chiara e dettagliata di Montanari.
Di eccellente qualità l'Adagio
molto.Allegro con brio
iniziale. Fragorosi
applausi ai protagonisti. Questa sera alle ore
20.00 la prima ufficiale e sabato, alle ore
17.00, la replica. Assolutamente da non perdere.
8 febbraio
2024 Cesare Guzzardella
Concerto De'
Cavalieri
alla "Società
dei Concerti" per "Handel
vs. Vivaldi"
Il
gruppo cameristico Concerto de' Cavalieri
e il suo direttore Marcello Di Lisa sono tornati
alle serate musicali organizzate dalla "Società
dei Concerti" per un'originale impaginazione che
confrontava due colossi del barocco
settecentesco quali G.F. Händel (1685-1759) e A.
Vivaldi (1678-1741). Nella serata denominata "Handel
vs. Vivaldi" particolare l'dea di
prefigurare quattro momenti musicali dove
movimenti di noti concerti dei
 due
musicisti venivano eseguiti in alternanza,
formando una sorte di quattro ampi nuovi
concerti. Gli eccellenti strumentisti della
compagine cameristica barocca hanno trovato la
giusta dimensione volumetrica nel delineare
l'essenza dell'arte settecentesca, tra timbriche
dal sapore antico e dinamiche discrete ma ricche
di contrasti. I quattro set, usando un
termine tennistico voluto da De Lisi, erano
volti ha rappresentare una sorta di scontro due
musicisti venivano eseguiti in alternanza,
formando una sorte di quattro ampi nuovi
concerti. Gli eccellenti strumentisti della
compagine cameristica barocca hanno trovato la
giusta dimensione volumetrica nel delineare
l'essenza dell'arte settecentesca, tra timbriche
dal sapore antico e dinamiche discrete ma ricche
di contrasti. I quattro set, usando un
termine tennistico voluto da De Lisi, erano
volti ha rappresentare una sorta di scontro
 tra
i due grandi protagonisti, scontro che si è
domostrato invece un incontro tra modi affini di
concepire la musica, spesso con momenti musicali
non facilmente riconoscibili per paternità
compositiva. Tra i numerosi movimenti tratti dai
Concerto grosso op.3 e op.6 del
musicista inglese e dai Concerti per archi
o per flauto e archi del grande
veneziano, segnaliamo
almeno l'intervento della bravissima solista al
flauto dolce Maria De Martini nei concerti
vivaldiani " Il Gardellino" e "La
tempesta di mare". Una serata
particolarmente riuscita molto applaudita dal
pubblico presente in Sala Verdi. tra
i due grandi protagonisti, scontro che si è
domostrato invece un incontro tra modi affini di
concepire la musica, spesso con momenti musicali
non facilmente riconoscibili per paternità
compositiva. Tra i numerosi movimenti tratti dai
Concerto grosso op.3 e op.6 del
musicista inglese e dai Concerti per archi
o per flauto e archi del grande
veneziano, segnaliamo
almeno l'intervento della bravissima solista al
flauto dolce Maria De Martini nei concerti
vivaldiani " Il Gardellino" e "La
tempesta di mare". Una serata
particolarmente riuscita molto applaudita dal
pubblico presente in Sala Verdi.
8 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Il pianista macedone
Simon Trp česki
alle Serate Musicali del Conservatorio
E la terza volta che ascolto
il pianista macedone Simon Trpčeski, sempre alle
Serate Musicali del Conservatorio
milanese. Gi à
nei lontani 2009 e 2010 aveva inserito, nei suoi
variegati programmi, molto
Chopin e l'ottima restituzione di allora è stata
riconfermata nel concerto di ieri sera, vario,
con uno solo Chopin iniziale, quello delle
Quattro Mazurche op.24 , già ascoltate in un
concerto di allora, e ora, dopo quattordici anni,
reinterpretate ancora meglio, con una luminosità
 coloristica
più raffinata e con una modalità interpretativa
molto "polacca". La presenza di molte "variazioni"
ha caratterizzato gran parte della serata.
Prima le rarissime Variazioni su "Come un
agnello" K 460 attribuite a Mozart, ma con
il tema iniziale di Giuseppe Sarti (1729-1802),
eseguite dal pianista macedone con una calibrata
ricerca delle timbriche nelle numerose
possibilità dinamiche. Poi la virtuosistica
Suite da "Lo Schiaccianoci" di
Čaikovskij nella splendida
trascrizione di Pletnev, approciata con notevole
sicurezza. I temi dei sette movimenti estratti
dal celebre balletto del grande russo subiscono
continue variazioni, ben rilevate
dall'interprete nei differenti piani sonori.
Ottime le coloristica
più raffinata e con una modalità interpretativa
molto "polacca". La presenza di molte "variazioni"
ha caratterizzato gran parte della serata.
Prima le rarissime Variazioni su "Come un
agnello" K 460 attribuite a Mozart, ma con
il tema iniziale di Giuseppe Sarti (1729-1802),
eseguite dal pianista macedone con una calibrata
ricerca delle timbriche nelle numerose
possibilità dinamiche. Poi la virtuosistica
Suite da "Lo Schiaccianoci" di
Čaikovskij nella splendida
trascrizione di Pletnev, approciata con notevole
sicurezza. I temi dei sette movimenti estratti
dal celebre balletto del grande russo subiscono
continue variazioni, ben rilevate
dall'interprete nei differenti piani sonori.
Ottime le
 variazioni
di Beethoven: prima le rarissime Variazioni
su una Danza Russa WoO 71 su un tema
Allegretto e poi le celebri 32 Variazioni
su un Tema originale in do minore WoO 80.
Quest'ultime di grande resa espressiva nella
corretta e precisa scelta dei tempi e negli
eccellenti contrasti. L'ultimo brano in
programma, la Sonata n.7 in si bem. maggiore
op.83 di Sergej Prokof'ev
è nota
soprattutto per il terzo e ultimo movimento, un
sorprendente Precipitato eseguito con
virtuosismo eccelso da Trpčeski
nell'esternazione dei contrastati elementi
ritmici
percussivi.
Applausi calorosissimi pienamente meritati e
quattro brevi bis concessi dal pianista
visibilmente soddisfatto: prima un breve ritmico
brano folcloristico macedone, poi una
trascrizione pianistica dello Scherzo per 4
fagotti di Prokof'ev, poi l' Humoresque
del russo
Rodion Shchedrin
(1932)
e,
a conclusione,
un recente brano particolarmente melodico di un
compositore croato in stile jazz molto americano.
Ottima serata. variazioni
di Beethoven: prima le rarissime Variazioni
su una Danza Russa WoO 71 su un tema
Allegretto e poi le celebri 32 Variazioni
su un Tema originale in do minore WoO 80.
Quest'ultime di grande resa espressiva nella
corretta e precisa scelta dei tempi e negli
eccellenti contrasti. L'ultimo brano in
programma, la Sonata n.7 in si bem. maggiore
op.83 di Sergej Prokof'ev
è nota
soprattutto per il terzo e ultimo movimento, un
sorprendente Precipitato eseguito con
virtuosismo eccelso da Trpčeski
nell'esternazione dei contrastati elementi
ritmici
percussivi.
Applausi calorosissimi pienamente meritati e
quattro brevi bis concessi dal pianista
visibilmente soddisfatto: prima un breve ritmico
brano folcloristico macedone, poi una
trascrizione pianistica dello Scherzo per 4
fagotti di Prokof'ev, poi l' Humoresque
del russo
Rodion Shchedrin
(1932)
e,
a conclusione,
un recente brano particolarmente melodico di un
compositore croato in stile jazz molto americano.
Ottima serata.
6
febbraio 2024
Cesare Guzzardella
A
NOVARA PER IL FESTIVAL CANTELLI RECITAL DELLA
PIANISTA VERA CECINO
Ieri sera,
domenica 4 febbraio, all'Auditorium Olivieri del
Conservatorio di Novara, nell'ambito del
Festival Cantelli si è tenuto un recital della
diciannovenne pianista trevigiana Vera Cecino,
vincitrice del Premio Martucci 2022, che si
aggiunge ad una nutrita serie di premi in altri
concorsi italiani. Il Premio Martucci è un
concorso pianistico che si svolge a Novara con
cadenza annuale, istituito nel 2015 dalla locale
Associazione Amici della Musica e rivolto a
giovani e giovanissimi musicisti. Il programma
con cui Vera Cecino si presentava al pubblico
novarese proponeva autori tra loro assai diversi,
per epoca storica e stile compositivo:
R.Schumann, S. Rachmaninov, M.Clementi, C.
Franck. Vera Cecino ha introdotto il concerto
con un pezzo di non frequentissima esecuzione
nelle sale da concerto, l'Allegro in si minore
op.8 di R. Schumann. Composto nel 1831,
nonostante il numero d'opus, è di fatto l'opera
prima di Schumann. Si tratta di un primo tempo
di una Sonata che Schumann non continuò, pervaso
di una sovrabbondanza di idee, di slanci, di una
materia ribollente che la forma-sonata a stento
contiene
 entro
"il fren de l'arte" di dantesca memoria,
peraltro accompagnata da una condotta
contrappuntistica delle parti, Non è pezzo di
facile interpretazione, sia per questo carattere
vario e tumultuoso, sia per alcuni passaggi di
notevole difficoltà tecnica, frutto
dell'interesse particolare manifestato
dall'autore in quel suo periodo giovanile per il
virtuosismo violinistico di Paganini, applicato
al pianoforte. Ottima l'interpretazione della
giovane pianista trevigiana, che rivela subito
sicura padronanza tecnica della tastiera, piena
scioltezza nel risolvere le difficoltà esecutive
della partitura, a cominciare dai numerosi
incroci, un uso sempre appropriato del pedale di
risonanza. Il fraseggio è nitido, reso fluido
dalla limpidezza e precisione del suono e dalle
corrette scelte dinamiche, e al tempo stesso
assai energico. Lo Schumann proposto da Cecino,
è decisamente lo Schumann-Florestano, ovvero uno
Schumann tutto slancio impetuoso, che trascina
in un torrente appassionato i temi e le cellule
motiviche con cui la scrittura musicale del
pezzo è costruita, sino alla coda, singolarmente
lunga, quasi un secondo sviluppo, in cui il
fraseggiare della pianista ci fa sentire un Si
maggiore particolarmente caldo e luminoso. Pezzo
più conosciuto ed eseguito dell'Allegro di
Schumann sono le Variazioni su un tema di
Corelli op.42 di S. Rachmaninov (1931). Basate
sul tema del Finale della sonata per violino e
basso continuo n.6 op.5 di Arcangelo Corelli,
tema noto in tutta Europa sin dal XVI secolo con
la parola portoghese 'Folìa (col significato di
'idea fissa')', queste Variazioni si
caratterizzano, pur nella sempre scintillante
qualità della scrittura pianistica del grande
maestro russo, per un minor tasso di
spettacolarità, di acrobatismo virtuosistico,
rispetto alle più vulgate composizioni
pianistiche del grande pianista e compositore
russo, a favore di un più asciutto e severo
impegno formale, soprattutto orientato verso lo
studio di soluzioni armoniche abbastanza
inusuali per il 'tradizionalista' Rachamaninov.
Nell'esecuzione di queste Variazioni, la Cecino
mostra di essere in possesso di una duttilità di
registri da pianista ormai matura: un'energia di
suono appassionata e travolgente per le
Variazioni dall'agogica più veloce, ed una
delicata dolcezza e leggerezza, venata di
sottile malinconia, che si riverbera dal tema
della "Folia", nelle Variazioni dai tempi più
lenti, tra cui, bellissima, con un fraseggio di
emozionante soavità, la Variazione XVI. Una
menzione particolare merita l'interpretazione
delle Variazioni VIII e IX in cui il tocco
sensibile e raffinato della pianista porta in
primo piano, nelle scelte timbriche, quelle
risonanze misteriose (l'VIII Variazione
s'intitola appunto Adagio misterioso) che
scaturiscono dal ricorso ad accordi e armonie ai
limiti della tonalità canonica da parte di
Rachmaninov. entro
"il fren de l'arte" di dantesca memoria,
peraltro accompagnata da una condotta
contrappuntistica delle parti, Non è pezzo di
facile interpretazione, sia per questo carattere
vario e tumultuoso, sia per alcuni passaggi di
notevole difficoltà tecnica, frutto
dell'interesse particolare manifestato
dall'autore in quel suo periodo giovanile per il
virtuosismo violinistico di Paganini, applicato
al pianoforte. Ottima l'interpretazione della
giovane pianista trevigiana, che rivela subito
sicura padronanza tecnica della tastiera, piena
scioltezza nel risolvere le difficoltà esecutive
della partitura, a cominciare dai numerosi
incroci, un uso sempre appropriato del pedale di
risonanza. Il fraseggio è nitido, reso fluido
dalla limpidezza e precisione del suono e dalle
corrette scelte dinamiche, e al tempo stesso
assai energico. Lo Schumann proposto da Cecino,
è decisamente lo Schumann-Florestano, ovvero uno
Schumann tutto slancio impetuoso, che trascina
in un torrente appassionato i temi e le cellule
motiviche con cui la scrittura musicale del
pezzo è costruita, sino alla coda, singolarmente
lunga, quasi un secondo sviluppo, in cui il
fraseggiare della pianista ci fa sentire un Si
maggiore particolarmente caldo e luminoso. Pezzo
più conosciuto ed eseguito dell'Allegro di
Schumann sono le Variazioni su un tema di
Corelli op.42 di S. Rachmaninov (1931). Basate
sul tema del Finale della sonata per violino e
basso continuo n.6 op.5 di Arcangelo Corelli,
tema noto in tutta Europa sin dal XVI secolo con
la parola portoghese 'Folìa (col significato di
'idea fissa')', queste Variazioni si
caratterizzano, pur nella sempre scintillante
qualità della scrittura pianistica del grande
maestro russo, per un minor tasso di
spettacolarità, di acrobatismo virtuosistico,
rispetto alle più vulgate composizioni
pianistiche del grande pianista e compositore
russo, a favore di un più asciutto e severo
impegno formale, soprattutto orientato verso lo
studio di soluzioni armoniche abbastanza
inusuali per il 'tradizionalista' Rachamaninov.
Nell'esecuzione di queste Variazioni, la Cecino
mostra di essere in possesso di una duttilità di
registri da pianista ormai matura: un'energia di
suono appassionata e travolgente per le
Variazioni dall'agogica più veloce, ed una
delicata dolcezza e leggerezza, venata di
sottile malinconia, che si riverbera dal tema
della "Folia", nelle Variazioni dai tempi più
lenti, tra cui, bellissima, con un fraseggio di
emozionante soavità, la Variazione XVI. Una
menzione particolare merita l'interpretazione
delle Variazioni VIII e IX in cui il tocco
sensibile e raffinato della pianista porta in
primo piano, nelle scelte timbriche, quelle
risonanze misteriose (l'VIII Variazione
s'intitola appunto Adagio misterioso) che
scaturiscono dal ricorso ad accordi e armonie ai
limiti della tonalità canonica da parte di
Rachmaninov.
 La
Cecino tende in particolare a conferire
particolare rilievo ai registri più bassi della
tastiera, quando, ovviamente, previsti in
partitura, per ottenere un suono il più
possibile scuro: ci pare un'ottima scelta
interpretativa, anche perché le registrazioni a
noi giunte delle esecuzioni dello stesso
Rachmaninov testimoniano proprio un preciso
orientamento del grande pianista in questa
direzione. Tuttavia in alcuni, sporadici
passaggi, si sarebbe desiderato da parte della
Cecino un tocco più nitido. Abbiamo comunque
ascoltato una interpretazione nel complesso di
ottimo livello di un pezzo sicuramente complesso
e impegnativo Col pezzo successivo, la giovane
pianista , con un'inversione cronologica, torna
al primo '800, con una figura di un grande
incompreso, Muzio Clementi, di cui ha proposto
una delle poche sue sonate per pianoforte che
abbiano superato i confini del puro uso
didattico nei Conservatori per approdare ad una
qualche fama nelle sale da concerto: la Sonata
op.25 n.5 in fa# minore. Ora, chi, oggi, suona
in pubblico Clementi si assume un compito arduo
e, aggiungiamo, una responsabilità piuttosto
gravosa: quella di liberare questo compositore
dalla condanna inappellabile che sembra averlo
per sempre schiacciato nei bassifondi della
storia della musica, con l'esiziale accusa di
aridità', compendiata nel lapidario, sprezzante
giudizio di Mozart, secondo cui la musica di
Clementi è quella di un '"semplice mechanicus",
parola che non abbisogna di traduzione. Tale
giudizio liquidatorio è però quantomeno
opinabile, se pensiamo che due giganti del
pianoforte, quali Horowitz e Benedetti
Michelangeli, non solo introdussero alcune
sonate di Clementi nel proprio repertorio, ma
giunsero entrambi a giudicare tali composizioni
addirittura superiori alla maggior parte di
quelle di Mozart. Dunque si tratta di' saper
suonare' Clementi come si deve. Nelle note del
programma di sala, vergate dalla stessa pianista,
si parla di "una sonata particolarmente
drammatica e tesa", il che è stato pienamente
confermato, soprattutto dell'"Allegro con
espressione" iniziale, dalla memorabile
interpretazione di V. Horowitz, che giustifica
pienamente quanto sostiene Rattalino, quando
parla di "scie e strisce fiammeggianti di suono"
che solcano gli Allegro delle migliori sonate
del Maestro romano. Tuttavia, a noi non pare che
sia questa la strada scelta da Vera Cecino nella
sua interpretazione. La pianista trevigiana ha
scelto un'altra strada, opposta, ma secondo noi
altrettanto legittima, per far rivivere i
contenuti espressivi di questa partitura: la
grazia. La Cecino ha suonato il primo tempo
della sonata di Clementi con un suono bellissimo,
morbido, delicato, di una dolcezza ricca di
sfumature, cui appunto diamo il nome di Grazia.
Un Clementi interpretato dunque in una chiave
classicistica, ma non di un classicismo marmoreo
e algido, accademico; al contrario, un
classicismo che contiene già in sé i germi della
propria dissoluzione nella nuova sensibilità
romantica, una sorta di congedo estremo dal
classicismo. Un'interpretazione che si
approfondisce nel meraviglioso Lento e patetico
centrale, dove il fraseggio della Cecino disegna
ampie arcate melodiche d'incantevole tenerezza,
senza mai scadere nella retorica di un patetismo
ad effetto, ma, come dire, tenuto 'sotto pelle',
cioè come soffuso in un'esecuzione sempre
controllata e dal suono nitido e luminoso.
Semmai un che di 'tensione drammatica', in
contrasto coi primi due tempi, affiora nel
Finale Presto, di notevole difficoltà tecnica,
di cui la bravura della Cecino ha interpretato
con un suono sempre nitido e preciso quel 'ritmo
ansimante' di cui parla Rattalino. Davvero una
bellissima interpretazione, quale da tempo non
ascoltavamo di una sonata di Clementi. Infine,
il pezzo conclusivo, il Preludio, Corale e Fuga
di C. Franck. In questo caso, a nostro giudizio,
l'esecuzione di Vera Cecino, oltre a un Preludio
tecnicamente impeccabile, raggiunge i suoi
risultati migliori nella Fuga, ove il suo
splendido fraseggio non solo mette in luce quel
"rigore costruttivo" di cui la stessa interprete
parla nelle note del Programma di sala, ma
accompagna tale rigore con una timbrica e un
gioco di dinamiche che arricchisce la struttura
del pezzo con un apporto espressivo di notevole
sensibilità e finezza. Un po' fiacco ci è
sembrato invece il Corale, privo di quella 'tensione
mistica' che ne costituisce il nucleo espressivo.
A parte qualche appunto del tutto marginale, è
stato un gran bel concerto, in cui Vera Cecino
ha mostrato di avere tutti i numeri per
affermarsi come pianista di notevole spessore e
intelligenza interpretativa. In risposta agli
applausi prolungati di un pubblico entusiasta,
Vera Cecino ha eseguito due bis: dal libro I dei
Preludi di Debussy "La serenata interrotta" e un
Preludio di Nino Rota, entrambi eseguiti con
precisione sensibilità espressiva. Un concerto
da ricordare. La
Cecino tende in particolare a conferire
particolare rilievo ai registri più bassi della
tastiera, quando, ovviamente, previsti in
partitura, per ottenere un suono il più
possibile scuro: ci pare un'ottima scelta
interpretativa, anche perché le registrazioni a
noi giunte delle esecuzioni dello stesso
Rachmaninov testimoniano proprio un preciso
orientamento del grande pianista in questa
direzione. Tuttavia in alcuni, sporadici
passaggi, si sarebbe desiderato da parte della
Cecino un tocco più nitido. Abbiamo comunque
ascoltato una interpretazione nel complesso di
ottimo livello di un pezzo sicuramente complesso
e impegnativo Col pezzo successivo, la giovane
pianista , con un'inversione cronologica, torna
al primo '800, con una figura di un grande
incompreso, Muzio Clementi, di cui ha proposto
una delle poche sue sonate per pianoforte che
abbiano superato i confini del puro uso
didattico nei Conservatori per approdare ad una
qualche fama nelle sale da concerto: la Sonata
op.25 n.5 in fa# minore. Ora, chi, oggi, suona
in pubblico Clementi si assume un compito arduo
e, aggiungiamo, una responsabilità piuttosto
gravosa: quella di liberare questo compositore
dalla condanna inappellabile che sembra averlo
per sempre schiacciato nei bassifondi della
storia della musica, con l'esiziale accusa di
aridità', compendiata nel lapidario, sprezzante
giudizio di Mozart, secondo cui la musica di
Clementi è quella di un '"semplice mechanicus",
parola che non abbisogna di traduzione. Tale
giudizio liquidatorio è però quantomeno
opinabile, se pensiamo che due giganti del
pianoforte, quali Horowitz e Benedetti
Michelangeli, non solo introdussero alcune
sonate di Clementi nel proprio repertorio, ma
giunsero entrambi a giudicare tali composizioni
addirittura superiori alla maggior parte di
quelle di Mozart. Dunque si tratta di' saper
suonare' Clementi come si deve. Nelle note del
programma di sala, vergate dalla stessa pianista,
si parla di "una sonata particolarmente
drammatica e tesa", il che è stato pienamente
confermato, soprattutto dell'"Allegro con
espressione" iniziale, dalla memorabile
interpretazione di V. Horowitz, che giustifica
pienamente quanto sostiene Rattalino, quando
parla di "scie e strisce fiammeggianti di suono"
che solcano gli Allegro delle migliori sonate
del Maestro romano. Tuttavia, a noi non pare che
sia questa la strada scelta da Vera Cecino nella
sua interpretazione. La pianista trevigiana ha
scelto un'altra strada, opposta, ma secondo noi
altrettanto legittima, per far rivivere i
contenuti espressivi di questa partitura: la
grazia. La Cecino ha suonato il primo tempo
della sonata di Clementi con un suono bellissimo,
morbido, delicato, di una dolcezza ricca di
sfumature, cui appunto diamo il nome di Grazia.
Un Clementi interpretato dunque in una chiave
classicistica, ma non di un classicismo marmoreo
e algido, accademico; al contrario, un
classicismo che contiene già in sé i germi della
propria dissoluzione nella nuova sensibilità
romantica, una sorta di congedo estremo dal
classicismo. Un'interpretazione che si
approfondisce nel meraviglioso Lento e patetico
centrale, dove il fraseggio della Cecino disegna
ampie arcate melodiche d'incantevole tenerezza,
senza mai scadere nella retorica di un patetismo
ad effetto, ma, come dire, tenuto 'sotto pelle',
cioè come soffuso in un'esecuzione sempre
controllata e dal suono nitido e luminoso.
Semmai un che di 'tensione drammatica', in
contrasto coi primi due tempi, affiora nel
Finale Presto, di notevole difficoltà tecnica,
di cui la bravura della Cecino ha interpretato
con un suono sempre nitido e preciso quel 'ritmo
ansimante' di cui parla Rattalino. Davvero una
bellissima interpretazione, quale da tempo non
ascoltavamo di una sonata di Clementi. Infine,
il pezzo conclusivo, il Preludio, Corale e Fuga
di C. Franck. In questo caso, a nostro giudizio,
l'esecuzione di Vera Cecino, oltre a un Preludio
tecnicamente impeccabile, raggiunge i suoi
risultati migliori nella Fuga, ove il suo
splendido fraseggio non solo mette in luce quel
"rigore costruttivo" di cui la stessa interprete
parla nelle note del Programma di sala, ma
accompagna tale rigore con una timbrica e un
gioco di dinamiche che arricchisce la struttura
del pezzo con un apporto espressivo di notevole
sensibilità e finezza. Un po' fiacco ci è
sembrato invece il Corale, privo di quella 'tensione
mistica' che ne costituisce il nucleo espressivo.
A parte qualche appunto del tutto marginale, è
stato un gran bel concerto, in cui Vera Cecino
ha mostrato di avere tutti i numeri per
affermarsi come pianista di notevole spessore e
intelligenza interpretativa. In risposta agli
applausi prolungati di un pubblico entusiasta,
Vera Cecino ha eseguito due bis: dal libro I dei
Preludi di Debussy "La serenata interrotta" e un
Preludio di Nino Rota, entrambi eseguiti con
precisione sensibilità espressiva. Un concerto
da ricordare.
5 febbraio 2024 Bruno Busca
Il pianista Giovanni
Bertolazzi a Villa
Necchi Campiglio
Un
impaginato vario ed interessante quello proposto
ieri, nel tardo pomeriggio, dal pianista
veronese Giovanni Bertolazzi nella milanese
Villa Necchi Campiglio. Il concerto era
organizzato dalla Società del Quartetto in
collaborazione con il FAI. Virtuoso di sicura
resa espressiva, Bertolazzi è stato premiato in
importanti concorsi internazionali tra i quali
il Franz Liszt di Budapest - secondo premio e
cinque premi speciali-, il
 "Premio
Alkan per il virtuosismo pianistico" di Milano,
dove ha ottenuto la prima posizione, e ancora
molti altri. L'impaginato prevedeva come brano
introduttivo la celebre Ciaccona di
J.S.Bach nella trascrizione di Ferruccio Busoni,
dalla Partita n.2 in re minore BWV 1004.
Da questo non semplice brano, circa 15 minuti di
musica dove le arditezze del violino originario
sono sta traslate a due mani nel virtuosismo del
compositore-pianista italiano, Bertolazzi ha
rivelato subito la sua cifra interpretativa
giocata su una tecnica sicura, robusta, precisa
nel sottolineare con chiarezza ogni frangente
del brano, ricco di variazioni, inquadrate molto
bene nel complessivo dell'esecuzione. Il
Beethoven successivo con la nota Sonata n.21
in do maggiore op.53 "Waldstein" ha rivelato
ancora grinta, sicurezza e chiarezza nel
definire le frasi nei diversi piani sonori. Un
ottimo Beethoven quello ascoltato. I due ultimi
lavori, entrambi di Franz Liszt, cioè la
Parafrasi da concerto sull'opera Ernani
di Verdi e la conclusiva Rapsodia
ungherese n.12 in do diesis minore, "Premio
Alkan per il virtuosismo pianistico" di Milano,
dove ha ottenuto la prima posizione, e ancora
molti altri. L'impaginato prevedeva come brano
introduttivo la celebre Ciaccona di
J.S.Bach nella trascrizione di Ferruccio Busoni,
dalla Partita n.2 in re minore BWV 1004.
Da questo non semplice brano, circa 15 minuti di
musica dove le arditezze del violino originario
sono sta traslate a due mani nel virtuosismo del
compositore-pianista italiano, Bertolazzi ha
rivelato subito la sua cifra interpretativa
giocata su una tecnica sicura, robusta, precisa
nel sottolineare con chiarezza ogni frangente
del brano, ricco di variazioni, inquadrate molto
bene nel complessivo dell'esecuzione. Il
Beethoven successivo con la nota Sonata n.21
in do maggiore op.53 "Waldstein" ha rivelato
ancora grinta, sicurezza e chiarezza nel
definire le frasi nei diversi piani sonori. Un
ottimo Beethoven quello ascoltato. I due ultimi
lavori, entrambi di Franz Liszt, cioè la
Parafrasi da concerto sull'opera Ernani
di Verdi e la conclusiva Rapsodia
ungherese n.12 in do diesis minore,
 hanno
evidenziato il frangente più virtuosistico di
Bertolazzi, quello per il quale l'interprete ha
da alcuni anni una più intensa predilezione. La
sicurezza espositiva dei lavori e l'evidente
espressività raggiunta, anche nei momenti di più
ardua tecnica, sono indice di qualità per un
pianista di ancora giovane età che sta già
ottenendo importanti successi internazionali.
L'avvincente performace del programma
ufficiale ha avuto come coda due ottimi bis con
un Valse triste in do minore del
violinista- compositore ungherese Franz von
Vecsey, nella trascrizione di Georges Cziffra e
quindi la celebre Danza ritale del fuoco
di Manuel De Falla. Un interprete tra i migliori
della sua generazione che speriamo di
riascoltare presto. Applausi fragorosi in una
sala al completo. hanno
evidenziato il frangente più virtuosistico di
Bertolazzi, quello per il quale l'interprete ha
da alcuni anni una più intensa predilezione. La
sicurezza espositiva dei lavori e l'evidente
espressività raggiunta, anche nei momenti di più
ardua tecnica, sono indice di qualità per un
pianista di ancora giovane età che sta già
ottenendo importanti successi internazionali.
L'avvincente performace del programma
ufficiale ha avuto come coda due ottimi bis con
un Valse triste in do minore del
violinista- compositore ungherese Franz von
Vecsey, nella trascrizione di Georges Cziffra e
quindi la celebre Danza ritale del fuoco
di Manuel De Falla. Un interprete tra i migliori
della sua generazione che speriamo di
riascoltare presto. Applausi fragorosi in una
sala al completo.
4 febbraio 2024 Cesare Guzzardella
Giuseppe Albanese
diretto da Pietari Inkinen per il concerto di
Schumann
L'ottimo concerto ascoltato in anteprima al
Teatro Dal Verme per I Pomeriggi Musicali
prevedeva due capavori quali il Concerto in
la minore op.54 di Robert Schumann e la
Sinfonia n.3 in mi bem. maggiore op.55 "Eroica"
di L.v. Beethoven. Alla direzione dell'Orchestra
de I Pomeriggi c'era il finlandese Pietari
Inkinen, direttore spesso presente nel
territorio milanese.
 Protagonista
del celebre concerto di Schumann il pianista
calabrese Giuseppe
Albanese è una realtà altrettanto continua nelle
nostre sale da concerto. Il suo pianismo, in
questo virtuosistico lavoro, è stato
caratterizzato da un deciso impatto timbrico
dovuto a evidente sicurezza nel gestire ogni
frangente dei tre movimenti. L'ottima sinergia
con Inkinen e Protagonista
del celebre concerto di Schumann il pianista
calabrese Giuseppe
Albanese è una realtà altrettanto continua nelle
nostre sale da concerto. Il suo pianismo, in
questo virtuosistico lavoro, è stato
caratterizzato da un deciso impatto timbrico
dovuto a evidente sicurezza nel gestire ogni
frangente dei tre movimenti. L'ottima sinergia
con Inkinen e
 con
gli orchestrali de I Pomeriggi è stata
utile per un'interpretazione di qualità. Anche
nella non breve Cadenza dell'Allegro
iniziale Albanese ha rivelato un'eccellente
interiorizzazione del materale, restituito poi
con chiarezza e valida discorsività. Applausi
fragorosi da parte del numeroso pubblico
intervenuto alla mattinata musicale. Il gesto
preciso di Inkinen nel gestire la corposa "Eroica"
beethoveniana ha, anche in questo celebre
lavoro, portato ad un ottimo traguardo.
Un'esecuzione energica e ricca di contrasti per
i validi Pomeriggi. Il concerto ufficiale è
previsto per questa sera alle ore 20.00 con
replica per sabato alle 17.00. Da non perdere. con
gli orchestrali de I Pomeriggi è stata
utile per un'interpretazione di qualità. Anche
nella non breve Cadenza dell'Allegro
iniziale Albanese ha rivelato un'eccellente
interiorizzazione del materale, restituito poi
con chiarezza e valida discorsività. Applausi
fragorosi da parte del numeroso pubblico
intervenuto alla mattinata musicale. Il gesto
preciso di Inkinen nel gestire la corposa "Eroica"
beethoveniana ha, anche in questo celebre
lavoro, portato ad un ottimo traguardo.
Un'esecuzione energica e ricca di contrasti per
i validi Pomeriggi. Il concerto ufficiale è
previsto per questa sera alle ore 20.00 con
replica per sabato alle 17.00. Da non perdere.
1 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
Daniil Trifonov incanta
il Teatro alla Scala
Un
programma variegato e ben strutturato ha accolto
al Teatro alla Scala il pianista trentaduenne
russo Daniil Trifonov. Da alcuni anni alla
ribalta internazionale,
probabilmente il massimo pianista della sua
generazione, l'interprete, anche compositore,
mancava da Milano da alcuni anni avendo "saltato"
alcune serate importanti per motivi di salute.
Molto atteso, ha trovato
 un
pubblico al completo venuto alla Scala per
ascoltare di Jean- Philippe Rameau la
Suite
in la min. RCT 5, di Wolfgang Amadeus Mozart
la Sonata n. 12 in fa magg. K. 332,
di
Felix Mendelssohn-Bartholdy le
Variations
sérieuses in re min. op. 54
e dopo
l'intervallo, di Ludwig van Beethoven la
Sonata in si bem. magg. op. 106 "Grosse Sonate
für das Hammerklavier".
Non è facile trovare
parole che definiscano il sorprendente pianismo
di Trifonov, un fuoriclasse che uscendo da
situazioni interpretative consolidate entrate
nella storia, sa personalizzare la musica dei
grandi musicisti attraverso una mediazione
creativa unica e di grande varietà espressiva.
La caratterizzazione dei brani, scelti secondo
un ordine intelligente, ha esaltato ogni
compositore. L'interiorizzazione della
bellissima e corposa
Suite in la minore
di Rameau, sette movimenti completati con una
serie di sei variazioni legati alla
Gavotta
conclusiva, ha trovato un' esternazione dai
colori antichi, in una sintesi discorsiva unica
per dettaglio e contrasti dinamici vari nella
discreta volumetria delle timbriche.
L'enunciazione delle
sei variazioni
finali ha poi raggiunto un frangente apicale di
bellezza. La successiva
Sonata in fa maggiore
mozartiana, di evidente estroversione rispetto
il più antico Rameau, ha trovato ancora un
grandissimo Trifonov proiettato nel migliore
classicismo del genio di Salisburgo. Il
contrasto tra l'Allegro
iniziale,
eseguito con rapida andatura, il finale
rapidissimo dell'Allegro assai, un
pubblico al completo venuto alla Scala per
ascoltare di Jean- Philippe Rameau la
Suite
in la min. RCT 5, di Wolfgang Amadeus Mozart
la Sonata n. 12 in fa magg. K. 332,
di
Felix Mendelssohn-Bartholdy le
Variations
sérieuses in re min. op. 54
e dopo
l'intervallo, di Ludwig van Beethoven la
Sonata in si bem. magg. op. 106 "Grosse Sonate
für das Hammerklavier".
Non è facile trovare
parole che definiscano il sorprendente pianismo
di Trifonov, un fuoriclasse che uscendo da
situazioni interpretative consolidate entrate
nella storia, sa personalizzare la musica dei
grandi musicisti attraverso una mediazione
creativa unica e di grande varietà espressiva.
La caratterizzazione dei brani, scelti secondo
un ordine intelligente, ha esaltato ogni
compositore. L'interiorizzazione della
bellissima e corposa
Suite in la minore
di Rameau, sette movimenti completati con una
serie di sei variazioni legati alla
Gavotta
conclusiva, ha trovato un' esternazione dai
colori antichi, in una sintesi discorsiva unica
per dettaglio e contrasti dinamici vari nella
discreta volumetria delle timbriche.
L'enunciazione delle
sei variazioni
finali ha poi raggiunto un frangente apicale di
bellezza. La successiva
Sonata in fa maggiore
mozartiana, di evidente estroversione rispetto
il più antico Rameau, ha trovato ancora un
grandissimo Trifonov proiettato nel migliore
classicismo del genio di Salisburgo. Il
contrasto tra l'Allegro
iniziale,
eseguito con rapida andatura, il finale
rapidissimo dell'Allegro assai,
 con
il centrale Adagio, dall'andatura
riflessiva, con note quasi centellinate, ha
creato un gioiello di raro ascolto. Le
Variations Sérieuses op.54
mendelssohniane,
rapidissime e in crescendo nei contrasti, di una
modernità sorprendente, hanno concluso la lunga
prima parte della serata. Con la
Sonata n.29
"Hammerklavier" op.106
siamo poi entrati in
un altro territorio musicale, dove la creatività
dell'interprete,
unita al
genio del compositore,
porta alla realizzazione di un lavoro ampio e
complesso che al primo ascolto sembra rinnovare
e rendere contemporanea l'opera del grande di
Bonn. Visionaria, ricca di luce, l'op.106,
autentico capolavoro, ha trovato una resa
stupefacente nelle mani del pianista russo con
momenti di rapida escursione coloristica
alternati ad altri di infinita riflessione. Un'
esecuzione memorabile, unitamente agli altri
lavori. Tre i bis: il primo jazz, con rapide
escursioni timbriche per Johnny Green/ Art Tatum
in I cover the Waterfront, il secondo di
Scriabin e per ultimo un valzer dalle
Variazioni su Chopin
di Mompou. Memorabile! con
il centrale Adagio, dall'andatura
riflessiva, con note quasi centellinate, ha
creato un gioiello di raro ascolto. Le
Variations Sérieuses op.54
mendelssohniane,
rapidissime e in crescendo nei contrasti, di una
modernità sorprendente, hanno concluso la lunga
prima parte della serata. Con la
Sonata n.29
"Hammerklavier" op.106
siamo poi entrati in
un altro territorio musicale, dove la creatività
dell'interprete,
unita al
genio del compositore,
porta alla realizzazione di un lavoro ampio e
complesso che al primo ascolto sembra rinnovare
e rendere contemporanea l'opera del grande di
Bonn. Visionaria, ricca di luce, l'op.106,
autentico capolavoro, ha trovato una resa
stupefacente nelle mani del pianista russo con
momenti di rapida escursione coloristica
alternati ad altri di infinita riflessione. Un'
esecuzione memorabile, unitamente agli altri
lavori. Tre i bis: il primo jazz, con rapide
escursioni timbriche per Johnny Green/ Art Tatum
in I cover the Waterfront, il secondo di
Scriabin e per ultimo un valzer dalle
Variazioni su Chopin
di Mompou. Memorabile!
1 febbraio 2024 Cesare
Guzzardella
GENNAIO 2024
Avi Avital
e Omer Klein alle
Serate Musicali
È raro
ascoltare un duo formato da un mandolinista e da
un pianista. Ieri sera, chi era presente nella
Sala Verdi del Conservatorio per Serate
Musicali ha trovato l'occasione
 ghiotta
di ascoltare uno dei maggiori mandolinisti
classici, Avi Avital, insieme ad un pianista di
formazione jazz come Omar Klein. Avital ha
inciso molti dischi con musiche di Vivaldi e
Bach, vincendo anche premi discografici, e Klein
ha un ampio repertorio nel classico trio jazz
con contrabbasso e batteria. Entrambi israeliani,
hanno da alcuni anni unito le loro qualità,
passando dal folclore mediorientale e
mediterraneo al mondo classico e al jazz.
Un'unione di generi che ha portato ad
un'interessante integrazione di modi di
concepire la musica, tra precise annotazioni di
partitura e luminosa improvvisazione. Ieri sera, ghiotta
di ascoltare uno dei maggiori mandolinisti
classici, Avi Avital, insieme ad un pianista di
formazione jazz come Omar Klein. Avital ha
inciso molti dischi con musiche di Vivaldi e
Bach, vincendo anche premi discografici, e Klein
ha un ampio repertorio nel classico trio jazz
con contrabbasso e batteria. Entrambi israeliani,
hanno da alcuni anni unito le loro qualità,
passando dal folclore mediorientale e
mediterraneo al mondo classico e al jazz.
Un'unione di generi che ha portato ad
un'interessante integrazione di modi di
concepire la musica, tra precise annotazioni di
partitura e luminosa improvvisazione. Ieri sera,
 nell'originale
e applauditissimo concerto, l'intreccio tra i
generi ha rivelato le personali qualità dei due
eccellenti interpreti e, per quanto concerne
Klein, anche le sue ottime capacità compositive.
L'impaginato variegato prevedeva almeno sei
brani di pregnante vena melodica folcloristica,
nel dialogo tra ritmiche di mandolino e
pianoforte. Brani di Omer Evital -violoncellista
e compositore del trio di Klein da non
confondere con Avi- e di Omer Klein si sono
alternati, rivelandoci lo spessore artistico di
entrambi i musicisti. Zamzama, Niggun, la
profonda ballata Lonely Girl, Avi's song,
Sleepwalker e altri ancora sono stati nell'originale
e applauditissimo concerto, l'intreccio tra i
generi ha rivelato le personali qualità dei due
eccellenti interpreti e, per quanto concerne
Klein, anche le sue ottime capacità compositive.
L'impaginato variegato prevedeva almeno sei
brani di pregnante vena melodica folcloristica,
nel dialogo tra ritmiche di mandolino e
pianoforte. Brani di Omer Evital -violoncellista
e compositore del trio di Klein da non
confondere con Avi- e di Omer Klein si sono
alternati, rivelandoci lo spessore artistico di
entrambi i musicisti. Zamzama, Niggun, la
profonda ballata Lonely Girl, Avi's song,
Sleepwalker e altri ancora sono stati
 intervallati
anche da un frangente più classico, dove il
mandolinista ha interpretato i primi quattro
movimenti (non la
Ciaccona) della celebre Partita n. 2 in re
minore per violino solo di J.S.Bach, in una sua
trascrizione per mandolino solo. Al termine di
ogni movimento- Allemande, Courante,
Sarabande e Gigue- l'intervento al
pianoforte di Klein, che partiva da Bach per
trovare raffinate e delicate improvvisazioni
jazz di notevole espressività . Prima di Bach anche un ottimo Fauré con
Aprés un reve con un preciso mandolino. Un connubio
certamente riuscito che, oltre a rivelare le
qualità classiche di Avital, ha mostrato le
abilità improvvisatorie di Klein, giocate su
genuine, semplici e raffinate idee. Applausi
fragorosi al termine e tre bis, -uno dei quali
l' originale Espagna e anche l'ottimo
Yemen hanno concluso la
splendida serata. ( Foto in alto di
Alberto Panzani- Stampa Serate Musicali
) intervallati
anche da un frangente più classico, dove il
mandolinista ha interpretato i primi quattro
movimenti (non la
Ciaccona) della celebre Partita n. 2 in re
minore per violino solo di J.S.Bach, in una sua
trascrizione per mandolino solo. Al termine di
ogni movimento- Allemande, Courante,
Sarabande e Gigue- l'intervento al
pianoforte di Klein, che partiva da Bach per
trovare raffinate e delicate improvvisazioni
jazz di notevole espressività . Prima di Bach anche un ottimo Fauré con
Aprés un reve con un preciso mandolino. Un connubio
certamente riuscito che, oltre a rivelare le
qualità classiche di Avital, ha mostrato le
abilità improvvisatorie di Klein, giocate su
genuine, semplici e raffinate idee. Applausi
fragorosi al termine e tre bis, -uno dei quali
l' originale Espagna e anche l'ottimo
Yemen hanno concluso la
splendida serata. ( Foto in alto di
Alberto Panzani- Stampa Serate Musicali
)
30 gennaio
2024 Cesare
Guzzardella
Alta qualità per il pianista
Daniele Martinelli allo Spazio Teatro 89
L'ottimo concerto di ieri pomeriggio al
Teatro Spazio 89, introdotto come sempre in
modo accurato da Luca Schieppati, ha rivelato le
eccellenti qualità del giovane pianista
bergamasco Daniele Martinelli. La denominazione
azzeccata "Con fuoco" - Passioni e visioni,
dal Romanticismo al Novecento - era
 motivata
dalla presenza di noti brani di Schumann, Berg,
Scriabin e Messiaen. Partendo dal romanticismo
più evoluto della Kreisleriana op. 16
(1837-38) di Robert Schumann , si è passati a
tre lavori del Novecento eseguiti senza
soluzione di continuità, mostrando una relazione
stilistica molto vicina della Sonata op.1
(1907) dell'austriaco Alban Berg, con Vers la
flamme op.72 (1915) del russo Alexander
Scriabin e con Île de Feu I (1949) del
francese Olivier Messiaen. È la rilevante
interpretazione di Daniele Martinelli, vent'anni
compiuti proprio ieri, che ha esaltato le
qualità dei lavori da lui scelti per dare un
senso unitario allo splendido impaginato. La sua
sicurezza esecutiva, esternata con evidente
immedesimazione nella sua matura gestualità, ha
prodotto un taglio deciso nel produrre sonorità
chiare, dettagliate e ben rilevate nei piani
sonori motivata
dalla presenza di noti brani di Schumann, Berg,
Scriabin e Messiaen. Partendo dal romanticismo
più evoluto della Kreisleriana op. 16
(1837-38) di Robert Schumann , si è passati a
tre lavori del Novecento eseguiti senza
soluzione di continuità, mostrando una relazione
stilistica molto vicina della Sonata op.1
(1907) dell'austriaco Alban Berg, con Vers la
flamme op.72 (1915) del russo Alexander
Scriabin e con Île de Feu I (1949) del
francese Olivier Messiaen. È la rilevante
interpretazione di Daniele Martinelli, vent'anni
compiuti proprio ieri, che ha esaltato le
qualità dei lavori da lui scelti per dare un
senso unitario allo splendido impaginato. La sua
sicurezza esecutiva, esternata con evidente
immedesimazione nella sua matura gestualità, ha
prodotto un taglio deciso nel produrre sonorità
chiare, dettagliate e ben rilevate nei piani
sonori
 particolarmente
riconoscibili. Partendo molto bene dalle otto
Fantasie che compongono la poetica
Kreisleriana, rese con pregnante e
riflessiva discorsività, la resa estetica è
risultata ancor più di valore nella sonata
giovanile di Berg e nel visionario Scriabin di
Vers la flamme op.72, per rangiungere un
momento alto e di grande impatto timbrico nel
virtuosistico e ritmico brano Île de Feu I
di Messiaen, tratto dai suoi "Quatre Études
de rythme". Una rivelazione interpretativa di
alta qualità quella di Martinelli, molto
applaudità dal pubblico presente nell'elegante
teatro periferico milanese. Due i bis classici
concessi: prima un Allegro con spirito
dalla Sonata in Re maggiore n.9 K311 di
Mozart e quindi lo Studio Op.25 n.5 di
Chopin, entrambi di pregio. Il prossimo concerto
allo Spazio Teatro 89 sarà domenica 18
febbraio alle ore 17.00 con il pianista Pier
Francesco Forlenza. Da non perdere! particolarmente
riconoscibili. Partendo molto bene dalle otto
Fantasie che compongono la poetica
Kreisleriana, rese con pregnante e
riflessiva discorsività, la resa estetica è
risultata ancor più di valore nella sonata
giovanile di Berg e nel visionario Scriabin di
Vers la flamme op.72, per rangiungere un
momento alto e di grande impatto timbrico nel
virtuosistico e ritmico brano Île de Feu I
di Messiaen, tratto dai suoi "Quatre Études
de rythme". Una rivelazione interpretativa di
alta qualità quella di Martinelli, molto
applaudità dal pubblico presente nell'elegante
teatro periferico milanese. Due i bis classici
concessi: prima un Allegro con spirito
dalla Sonata in Re maggiore n.9 K311 di
Mozart e quindi lo Studio Op.25 n.5 di
Chopin, entrambi di pregio. Il prossimo concerto
allo Spazio Teatro 89 sarà domenica 18
febbraio alle ore 17.00 con il pianista Pier
Francesco Forlenza. Da non perdere!
29 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
Francesco Libetta al
MaMu per il
compleanno di Mozart
Il
pianista Francesco Libetta ha tenuto un concerto
al MaMu - Magazzino musica, in via Soave
a Milano per festeggiare il compleanno di "Amadè".
Wolfgang Amadeus Mozart era nato infatti il 27
gennaio 1756. Il noto spazio musicale milanese,
dove
 tra
spartiti, dischi, libri preziosi, strumenti
musicali e incontri di presentazione, è
diventato un luogo spesso affollato di concerti,
ha ieri trovato insieme al noto pianista
pugliese anche la piccola Orchestra MaMu
Ensemble, diretta per l"occasione dal
pianista-direttore Emanuele Delucchi.
L'impaginato, di straordinario interesse,
prevedeva prima una rarissima trascrizione per
pianoforte solo del Concerto in do maggiore
K. 503 nella versione di Friedrich
Kalkbrenner. Una trascrizione in senso
virtuosistico del celebre brano composto nei
classici tre movimenti che Libetta ha in modo
estemporaneo eseguito molto bene, tra
spartiti, dischi, libri preziosi, strumenti
musicali e incontri di presentazione, è
diventato un luogo spesso affollato di concerti,
ha ieri trovato insieme al noto pianista
pugliese anche la piccola Orchestra MaMu
Ensemble, diretta per l"occasione dal
pianista-direttore Emanuele Delucchi.
L'impaginato, di straordinario interesse,
prevedeva prima una rarissima trascrizione per
pianoforte solo del Concerto in do maggiore
K. 503 nella versione di Friedrich
Kalkbrenner. Una trascrizione in senso
virtuosistico del celebre brano composto nei
classici tre movimenti che Libetta ha in modo
estemporaneo eseguito molto bene,
 mettendo
in rilievo con grande capacità tutte le parti
non solo pianistiche ma anche orchestrali del
corposo lavoro. Dopo il breve intervallo il
Concerto in sol maggiore K 453 ha trovato
oltre a Libetta anche l'Orchestra MaMu. La parte
pianistica di Libetta è stata sostenuta
armonicamente con passione dagli orchestrali e
gli applausi del pubblico che gremiva per
l'occasione la sala non sono mancati. Libetta ha
voluto poi proporre due sorprendenti bis
solistici, prima con un omaggio a Verdi che
moriva il 27 gennaio 1901, con una straordinaria
interprerazione dal quintetto da Rigoletto
nella celebre trascrizione di F. Liszt e poi
ancora Mozart con il movimento centrale di una
tra le sue più celebri Sonate. Grande successo. mettendo
in rilievo con grande capacità tutte le parti
non solo pianistiche ma anche orchestrali del
corposo lavoro. Dopo il breve intervallo il
Concerto in sol maggiore K 453 ha trovato
oltre a Libetta anche l'Orchestra MaMu. La parte
pianistica di Libetta è stata sostenuta
armonicamente con passione dagli orchestrali e
gli applausi del pubblico che gremiva per
l'occasione la sala non sono mancati. Libetta ha
voluto poi proporre due sorprendenti bis
solistici, prima con un omaggio a Verdi che
moriva il 27 gennaio 1901, con una straordinaria
interprerazione dal quintetto da Rigoletto
nella celebre trascrizione di F. Liszt e poi
ancora Mozart con il movimento centrale di una
tra le sue più celebri Sonate. Grande successo.
28 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
GRANDE SERATA DI MUSICA A
VERCELLI CON IL QUARTETTO ADORNO
Il
ViottiFestival ha proposto ieri sera, sabato
27/01, al Teatro Civico di Vercelli, al suo
affezionato e numeroso pubblico, un’altra
bellissima serata di musica che ha visto
protagonista uno dei migliori quartetti d’archi
oggi in Italia, il Quartetto Adorno, nato nel
2015 e formato da quattro talentuosi giovani che
rispondono al nome di Edoardo Zosi (primo
violino), Liù Pellicciari (secondo violino),
Benedetta Bucci (viola) e Stefano Cerrato
(violoncello). Il programma con cui il Quartetto
Adorno si è presentato a Vercelli comprendeva
tre quartetti per archi di Beethoven, che
rientrano in quel progetto di esecuzione
integrale dei diciassette (comprendendo nel
calcolo la Grande Fuga op.133 come opera
autonoma) quartetti del Maestro di Bonn,
progetto che sta ormai volgendo a termine e che
gli ‘adorniani’ hanno portato in diverse sale da
concerto italiane, oltre che a Vercelli. Ad essi
si aggiungeva, come doveroso omaggio a G.B.
Viotti nel bicentenario della morte, un
quartetto del grande violinista e compositore
vercellese. Già nella disposizione degli
strumentisti, il Quartetto Adorno dimostra
originalità e ricerca di una particolare
sonorità: infatti inverte le posizioni di viola
e violoncello, spostando all’esterno la prima e
all’interno il violoncello, per consentire
maggior proiezione all’arco grave. Questa
inusuale disposizione della formazione
quartettistica funziona al meglio, naturalmente,
a condizione che si abbiano due eccellenti
violinisti e un altrettanto eccellente viola,
capaci tutti di una cavata di buon volume, com’è
certamente nel caso del Quartetto Adorno.
L’impaginato del programma intelligentemente
proponeva tre quartetti,
 appartenenti alle tre ‘epoche’,
o ‘stili’, in cui si è soliti distinguere
l’opera beethoveniana. Il primo quartetto
proposto, il n.1 in Fa maggiore op.18 (1798, ma
in realtà è il secondo della serie di sei
quartetti dell’opus 18), appartiene ancora al
c.d. ‘ primo stile’ di Beethoven, che ancora
risente di influenze settecentesche, soprattutto
di Haydn, pur con il progressivo emergere di
caratteri originali, soprattutto in direzione di
un’accentuazione dei contrasti espressivi. E
subito il Quartetto Adorno dimostra tutto il suo
valore, fornendo un’interpretazione di alto
livello di questa composizione sprizzante, salvo
il tempo lento, quell’energia che, in un suo
memorabile saggio, Quirino Principe individua
come il principio ‘cosmico’ di tutta l’opera
beethoveniana, di cui i quartetti costituiscono
il vertice assoluto. Con tecnica perfetta e
sintonia ormai pienamente collaudata tra gli
strumentisti, i quattro dell’Adorno danno voce
al carattere assertivo, dalla linea tematica
concentrata quasi esclusivamente su un’ unica
cellula motivica, dell’Allegro con brio iniziale,
in cui il suono più incisivo del violoncello
risalta a contrasto con quello più meditativo
del primo violino. Ma è nello sviluppo, dalle
dimensioni inusitate per l’epoca, che i quattro
giovani Maestri hanno dato prova della qualità
di questa compagine musicale, con una polifonia
trasparente e trascinante, sorretta da una
cavata complessiva di forte intensità espressiva:
grazie anche ad una scelta sempre efficace delle
dinamiche, ne usciva esaltato l’alternarsi di
momenti robustamente drammatici ad altri di più
distesa eleganza ancora settecentesca, in cui
spiccava il timbro brillante dei violini, in
particolare del primo, cui in questo primo
gruppo di quartetti, Beethoven conferisce ancora
un ruolo dominante. Di alta qualità artistica è
stata anche l’esecuzione dell’Adagio affettuoso
e appassionato, di cui l’Adorno ha interpretato
con una forte carica espressiva, virata su un
pathos intenso, ma senza retorica, il tema
principale in minore, mentre ha dimostrato una
cura sapiente dei dettagli timbrici nella
sezione centrale del movimento, dominata dal
primo violino e dal violoncello. appartenenti alle tre ‘epoche’,
o ‘stili’, in cui si è soliti distinguere
l’opera beethoveniana. Il primo quartetto
proposto, il n.1 in Fa maggiore op.18 (1798, ma
in realtà è il secondo della serie di sei
quartetti dell’opus 18), appartiene ancora al
c.d. ‘ primo stile’ di Beethoven, che ancora
risente di influenze settecentesche, soprattutto
di Haydn, pur con il progressivo emergere di
caratteri originali, soprattutto in direzione di
un’accentuazione dei contrasti espressivi. E
subito il Quartetto Adorno dimostra tutto il suo
valore, fornendo un’interpretazione di alto
livello di questa composizione sprizzante, salvo
il tempo lento, quell’energia che, in un suo
memorabile saggio, Quirino Principe individua
come il principio ‘cosmico’ di tutta l’opera
beethoveniana, di cui i quartetti costituiscono
il vertice assoluto. Con tecnica perfetta e
sintonia ormai pienamente collaudata tra gli
strumentisti, i quattro dell’Adorno danno voce
al carattere assertivo, dalla linea tematica
concentrata quasi esclusivamente su un’ unica
cellula motivica, dell’Allegro con brio iniziale,
in cui il suono più incisivo del violoncello
risalta a contrasto con quello più meditativo
del primo violino. Ma è nello sviluppo, dalle
dimensioni inusitate per l’epoca, che i quattro
giovani Maestri hanno dato prova della qualità
di questa compagine musicale, con una polifonia
trasparente e trascinante, sorretta da una
cavata complessiva di forte intensità espressiva:
grazie anche ad una scelta sempre efficace delle
dinamiche, ne usciva esaltato l’alternarsi di
momenti robustamente drammatici ad altri di più
distesa eleganza ancora settecentesca, in cui
spiccava il timbro brillante dei violini, in
particolare del primo, cui in questo primo
gruppo di quartetti, Beethoven conferisce ancora
un ruolo dominante. Di alta qualità artistica è
stata anche l’esecuzione dell’Adagio affettuoso
e appassionato, di cui l’Adorno ha interpretato
con una forte carica espressiva, virata su un
pathos intenso, ma senza retorica, il tema
principale in minore, mentre ha dimostrato una
cura sapiente dei dettagli timbrici nella
sezione centrale del movimento, dominata dal
primo violino e dal violoncello.
 Bravi, i
quattro giovani musicisti, anche nel dar voce a
quella vena di umorismo che impronta il terzo
movimento in Allegro (non più un Minuetto, non
ancora uno Scherzo) con il giocare incessante
tra legato e staccato, e alla vivacità ritmica
dell’Allegro finale. La maturità del Quartetto
Adorno, la qualità e la serietà della ricerca
dei valori espressivi della partitura si è
confermata pienamente nel secondo dei quartetti
della serata, noto come ‘Quartetto delle Arpe”,
il n.10 in Mi bem. Maggiore op.74 (1809) Questo
quartetto, non tra i più eseguiti tra i
diciassette beethoveniani, segna, all’interno
del ‘secondo’ stile, la ricerca di nuove strade,
da parte di Beethoven, una nuova forma del
discorso musicale. Qui l’interprete non ha più a
che fare col Beethoven ‘eroico’ e drammatico,
tipico del secondo stile, ma con un Beethoven
che tende a portare in primo piano altri
elementi della costruzione musicale, tra cui,
assolutamente centrale, il timbro, il colore
dell’impasto strumentale, di cui chi interpreta
questo magnifico pezzo è chiamato a illuminare
tutte le sfumature. A questa esigenza
l’esecuzione del Quartetto Adorno ha corrisposto
a un livello tecnico ed estetico che merita una
valutazione di eccellenza. Impossibile,
ovviamente soffermarsi su tutti i dettagli, ma
per noi momenti memorabili di questa
interpretazione rimarranno la delicatezza e
ricchezza di sfumature del Poco Adagio
introduttivo, con la paletta timbrica dei
quattro strumenti che intreccia, fonde, sfuma
l’inciso melodico dallo strano tono
interrogativo che apre questo capolavoro; la
finezza dei pizzicati, che sembrano espandersi,
fino a spegnersi nella conclusione della sezione
in Allegro del primo movimento (e cui si deve il
titolo dato al quartetto);la dolcezza
dell’Adagio, in forma di Rondò, quasi attonita
nella sospensione arcanamente suggestiva delle
pause, con la terza enunciazione del Refrain in
cui la tessitura musicale arrivava
all’ascoltatore come un miracolo di echi e
rimandi tra quattro linee sonore diverse, eppur
sfumate l’una nell’altra, come un meraviglioso
arcobaleno sonoro; e il culmine di questa
accuratissima e raffinatissima ricerca timbrica,
il Finale Allegro, in forma di Variazioni (sei)
su un dolce tema di lieder, sulle quali
s’innalza, come incantesimo sonoro, la seconda,
dove è la viola a procurare l’emozione più
vibrante con il suo sommesso mormorio in legato.
Una vera immersione in un mondo di suoni che
richiama alla mente quella frase di Kierkegaard,
tanto cara a quell’Adorno che i membri di questo
quartetto hanno consacrato a loro nume tutelare:
“Dove i raggi del sole non giungono, pur
giungono i suoni”. Il terzo e ultimo quartetto
di Beethoven in programma era il n.14, in Do#
min. op.131, in pieno ‘terzo stile’
beethoveniano (1826). Eseguire uno degli ultimi
quartetti di Beethoven, e in particolare,
diremmo, proprio questo monumentale op.131,
significa proporsi una sfida da far “tremar le
vene e i polsi”. Già la tonalità comporta, con
le sue quattro alterazioni in armatura di chiave,
più di una complicazione nell’intonazione e
nella diteggiatura, specie per gli archi ( e non
parliamo del sol# min. del sesto movimento, che
di alterazioni ne presenta ben cinque!).
Aggiungiamo gli sforzi che Beethoven chiede agli
strumentisti e in particolare al primo violino,
con salti vertiginosi dal grave all’acuto e al
sovracuto e difficoltà ritmiche d’ogni sorta: il
Presto, cioè il quinto movimento dell’op.131
era, ai tempi di Beethoven, giudicato per gran
parte ineseguibile, persino da uno dei più
validi violinisti del tempo come Schuppanzigh,
che Beethoven mandò semplicemente al diavolo.
Vero banco di prova della qualità di un
quartetto, suo ‘esame di maturità’, è stato
affrontato dal Quartetto Adorno con un piglio e
una bravura davvero ammirevoli, e con un esito
interpretativo di notevole qualità, con
intonazione pregevole e sincronismo rigoroso
negli attacchi. Indicheremo anche in questo caso
i momenti per noi più alti di questa esecuzione:
il primo movimento, nella forma della fuga,
forma amatissima dall’ultimo Beethoven, che i
quattro giovani talenti hanno interpretato con
chiarezza e nettezza apollinee, in cui
l’intreccio polifonico delle quattro linee
strumentali è parso spesso fondersi in un unico
flusso, dai timbri diversi, e soprattutto quello
che è un po’ il centro dell’intera opera, il
quarto movimento, l’Andante ma non troppo e
molto cantabile’ , un Tema con variazioni (anche
questo un genere onnipresente nel ‘terzo stile’
beethoveniano). Man mano che le variazioni
procedono, il Quartetto Adorno ne sottolinea il
carattere sempre più armonicamente e
tematicamente complesso, con una sottile cura
dei dettagli armonico- contrappuntistici e
timbrici, in cui ogni strumento sembra farsi
portatore di un mondo d’idee musicali proprie,
ora addensando il suono, ora rarefacendolo, con
un gioco vario e incantevole di dinamiche,
veramente bello a sentirsi. e l’Allegro finale,
l’enigmatica esplosione con cui si conclude
questo immenso (in tutti i significati
dell’aggettivo) quartetto, che l’Adorno ha
suonato con una intensità di suono straordinaria,
corrusca di quei sinistri bagliori, che fecero
dire allo scrittore romantico russo Alexander
Bestujev che “nel finale del quartetto 14 di
Beethoven s’acquatta l’ombra del diavolo”.
Intelligenti pauca, dice un adagio latino: a chi
capisce bastano poche parole: è stato un
quartetto op.131 tra i più esteticamente
riusciti da noi ascoltati recentemente. Davvero
complimenti a questi giovani talenti. Tra il
quartetto op.74 e quello op.131, che chiudeva la
serata, è stato inserito l’omaggio a Viotti, il
quartetto in Mi maggiore WII:6. Viotti compose
sedici quartetti, come Beethoven, sempre che non
conteggiamo la Grande Fuga come pezzo
indipendente. Quello presentato ieri sera
appartiene ad una raccolta di sei quartetti
pubblicata nel 1783 ed è in soli due movimenti,
entrambi in Allegro, il secondo in forma di
Rondò. L’interpretazione che il Quartetto Adorno
ne ha offerto colloca molto bene l’arte di
Viotti nel suo appropriato contesto, cogliendone
i caratteri peculiari: come bene dice la nota di
presentazione del programma di sala, l’essenza
dei quartetti di Viotti consiste in una garbata
conversazione tra i quattro archi in uno stile
concertante, in cui il dominio del primo violino
è nettamente limitato a vantaggio degli altri
tre archi. Questa conversazione si esprime in un
linguaggio che unisce, in originale ed efficace
sintesi, l’eleganza limpida dello stile galante
con un lirismo che, lontana eredità barocca
della scuola corelliana e della ‘musica degli
affetti’, sa attingere talora un’intensità che
presente il romanticismo, in particolare nel
primo movimento, in cui la serenità del tema
principale s’incrina in alcuni passaggi di
ombroso ripiegamento. Valida, dunque
l’interpretazione del Quartetto Adorno nel
cogliere quella limpidezza e quella vena più
pensosa ed elegiaca che scorre, per così dire,
sotto di essa, grazie ad una cura meticolosa di
dinamiche e timbri. Un concerto che ha riscosso
un grandissimo e strameritato successo e davvero
tra i più coinvolgenti della stagione, salutato
da un prolungato e fragoroso applauso del
pubblico accorso al Teatro Civico, che ha
strappato il bis ai quattro protagonisti della
serata: lo Scherzo dal quartetto di F. Schubert
‘La morte e la fanciulla’, eseguito con la
finezza e la sensibilità espressiva di cui il
Quartetto Adorno ha dato abbondante prova nel
corso di tutta la serata. Da ricordare. ( Foto
Ufficio Stampa Vercelli) Bravi, i
quattro giovani musicisti, anche nel dar voce a
quella vena di umorismo che impronta il terzo
movimento in Allegro (non più un Minuetto, non
ancora uno Scherzo) con il giocare incessante
tra legato e staccato, e alla vivacità ritmica
dell’Allegro finale. La maturità del Quartetto
Adorno, la qualità e la serietà della ricerca
dei valori espressivi della partitura si è
confermata pienamente nel secondo dei quartetti
della serata, noto come ‘Quartetto delle Arpe”,
il n.10 in Mi bem. Maggiore op.74 (1809) Questo
quartetto, non tra i più eseguiti tra i
diciassette beethoveniani, segna, all’interno
del ‘secondo’ stile, la ricerca di nuove strade,
da parte di Beethoven, una nuova forma del
discorso musicale. Qui l’interprete non ha più a
che fare col Beethoven ‘eroico’ e drammatico,
tipico del secondo stile, ma con un Beethoven
che tende a portare in primo piano altri
elementi della costruzione musicale, tra cui,
assolutamente centrale, il timbro, il colore
dell’impasto strumentale, di cui chi interpreta
questo magnifico pezzo è chiamato a illuminare
tutte le sfumature. A questa esigenza
l’esecuzione del Quartetto Adorno ha corrisposto
a un livello tecnico ed estetico che merita una
valutazione di eccellenza. Impossibile,
ovviamente soffermarsi su tutti i dettagli, ma
per noi momenti memorabili di questa
interpretazione rimarranno la delicatezza e
ricchezza di sfumature del Poco Adagio
introduttivo, con la paletta timbrica dei
quattro strumenti che intreccia, fonde, sfuma
l’inciso melodico dallo strano tono
interrogativo che apre questo capolavoro; la
finezza dei pizzicati, che sembrano espandersi,
fino a spegnersi nella conclusione della sezione
in Allegro del primo movimento (e cui si deve il
titolo dato al quartetto);la dolcezza
dell’Adagio, in forma di Rondò, quasi attonita
nella sospensione arcanamente suggestiva delle
pause, con la terza enunciazione del Refrain in
cui la tessitura musicale arrivava
all’ascoltatore come un miracolo di echi e
rimandi tra quattro linee sonore diverse, eppur
sfumate l’una nell’altra, come un meraviglioso
arcobaleno sonoro; e il culmine di questa
accuratissima e raffinatissima ricerca timbrica,
il Finale Allegro, in forma di Variazioni (sei)
su un dolce tema di lieder, sulle quali
s’innalza, come incantesimo sonoro, la seconda,
dove è la viola a procurare l’emozione più
vibrante con il suo sommesso mormorio in legato.
Una vera immersione in un mondo di suoni che
richiama alla mente quella frase di Kierkegaard,
tanto cara a quell’Adorno che i membri di questo
quartetto hanno consacrato a loro nume tutelare:
“Dove i raggi del sole non giungono, pur
giungono i suoni”. Il terzo e ultimo quartetto
di Beethoven in programma era il n.14, in Do#
min. op.131, in pieno ‘terzo stile’
beethoveniano (1826). Eseguire uno degli ultimi
quartetti di Beethoven, e in particolare,
diremmo, proprio questo monumentale op.131,
significa proporsi una sfida da far “tremar le
vene e i polsi”. Già la tonalità comporta, con
le sue quattro alterazioni in armatura di chiave,
più di una complicazione nell’intonazione e
nella diteggiatura, specie per gli archi ( e non
parliamo del sol# min. del sesto movimento, che
di alterazioni ne presenta ben cinque!).
Aggiungiamo gli sforzi che Beethoven chiede agli
strumentisti e in particolare al primo violino,
con salti vertiginosi dal grave all’acuto e al
sovracuto e difficoltà ritmiche d’ogni sorta: il
Presto, cioè il quinto movimento dell’op.131
era, ai tempi di Beethoven, giudicato per gran
parte ineseguibile, persino da uno dei più
validi violinisti del tempo come Schuppanzigh,
che Beethoven mandò semplicemente al diavolo.
Vero banco di prova della qualità di un
quartetto, suo ‘esame di maturità’, è stato
affrontato dal Quartetto Adorno con un piglio e
una bravura davvero ammirevoli, e con un esito
interpretativo di notevole qualità, con
intonazione pregevole e sincronismo rigoroso
negli attacchi. Indicheremo anche in questo caso
i momenti per noi più alti di questa esecuzione:
il primo movimento, nella forma della fuga,
forma amatissima dall’ultimo Beethoven, che i
quattro giovani talenti hanno interpretato con
chiarezza e nettezza apollinee, in cui
l’intreccio polifonico delle quattro linee
strumentali è parso spesso fondersi in un unico
flusso, dai timbri diversi, e soprattutto quello
che è un po’ il centro dell’intera opera, il
quarto movimento, l’Andante ma non troppo e
molto cantabile’ , un Tema con variazioni (anche
questo un genere onnipresente nel ‘terzo stile’
beethoveniano). Man mano che le variazioni
procedono, il Quartetto Adorno ne sottolinea il
carattere sempre più armonicamente e
tematicamente complesso, con una sottile cura
dei dettagli armonico- contrappuntistici e
timbrici, in cui ogni strumento sembra farsi
portatore di un mondo d’idee musicali proprie,
ora addensando il suono, ora rarefacendolo, con
un gioco vario e incantevole di dinamiche,
veramente bello a sentirsi. e l’Allegro finale,
l’enigmatica esplosione con cui si conclude
questo immenso (in tutti i significati
dell’aggettivo) quartetto, che l’Adorno ha
suonato con una intensità di suono straordinaria,
corrusca di quei sinistri bagliori, che fecero
dire allo scrittore romantico russo Alexander
Bestujev che “nel finale del quartetto 14 di
Beethoven s’acquatta l’ombra del diavolo”.
Intelligenti pauca, dice un adagio latino: a chi
capisce bastano poche parole: è stato un
quartetto op.131 tra i più esteticamente
riusciti da noi ascoltati recentemente. Davvero
complimenti a questi giovani talenti. Tra il
quartetto op.74 e quello op.131, che chiudeva la
serata, è stato inserito l’omaggio a Viotti, il
quartetto in Mi maggiore WII:6. Viotti compose
sedici quartetti, come Beethoven, sempre che non
conteggiamo la Grande Fuga come pezzo
indipendente. Quello presentato ieri sera
appartiene ad una raccolta di sei quartetti
pubblicata nel 1783 ed è in soli due movimenti,
entrambi in Allegro, il secondo in forma di
Rondò. L’interpretazione che il Quartetto Adorno
ne ha offerto colloca molto bene l’arte di
Viotti nel suo appropriato contesto, cogliendone
i caratteri peculiari: come bene dice la nota di
presentazione del programma di sala, l’essenza
dei quartetti di Viotti consiste in una garbata
conversazione tra i quattro archi in uno stile
concertante, in cui il dominio del primo violino
è nettamente limitato a vantaggio degli altri
tre archi. Questa conversazione si esprime in un
linguaggio che unisce, in originale ed efficace
sintesi, l’eleganza limpida dello stile galante
con un lirismo che, lontana eredità barocca
della scuola corelliana e della ‘musica degli
affetti’, sa attingere talora un’intensità che
presente il romanticismo, in particolare nel
primo movimento, in cui la serenità del tema
principale s’incrina in alcuni passaggi di
ombroso ripiegamento. Valida, dunque
l’interpretazione del Quartetto Adorno nel
cogliere quella limpidezza e quella vena più
pensosa ed elegiaca che scorre, per così dire,
sotto di essa, grazie ad una cura meticolosa di
dinamiche e timbri. Un concerto che ha riscosso
un grandissimo e strameritato successo e davvero
tra i più coinvolgenti della stagione, salutato
da un prolungato e fragoroso applauso del
pubblico accorso al Teatro Civico, che ha
strappato il bis ai quattro protagonisti della
serata: lo Scherzo dal quartetto di F. Schubert
‘La morte e la fanciulla’, eseguito con la
finezza e la sensibilità espressiva di cui il
Quartetto Adorno ha dato abbondante prova nel
corso di tutta la serata. Da ricordare. ( Foto
Ufficio Stampa Vercelli)
28 gennaio 2024 Bruno Busca
Marie-Ange Nguci
diretta da
Alexander Briger in Auditorium con l'Orchestra
Sinfonica di Milano
L'interessante concerto sinfonico ascoltato ieri
sera in Auditorium con l'Orchestra Sinfonica di
Milano prevedeva due ultimi lavori di due grandi
musicisti quali W.A.Mozart e J.Brahms. Il
classico e in apparenza "facile" Concerto in
si bem. maggiore n.27 K. 595 del grande
salisburghese, del 1791, si opponeva all'ultima
fatica sinfonica del musicista amburghese
 Brahms, un lavoro romantico evoluto che ritrova
una sintesi espressiva del musicista più maturo,
che ha terminato il genere sinfonico con la sua
Sinfonia n.4 in mi minore op.98, composta
nel 1884-85. Alla direzione della valida
Sinfonica milanese, il direttore australiano
Alexander Briger ha dato sfoggio delle sue
qualità interpretative in entrambi i lavori. Nel
delizioso concerto mozartiano, protagonista
della serata e per la prima volta da me
ascoltata, la giovane pianista franco-albanese
Marie-Ange Nguci ha rivelato doti pianistiche di
eccellente resa stilistica attraverso un tocco
sicuro, chiaro, ben delineato nei piani sonori e
certamente importante per lo svolgimento
complessivo delle sonorità orchestrali. Il
rapporto tra Brahms, un lavoro romantico evoluto che ritrova
una sintesi espressiva del musicista più maturo,
che ha terminato il genere sinfonico con la sua
Sinfonia n.4 in mi minore op.98, composta
nel 1884-85. Alla direzione della valida
Sinfonica milanese, il direttore australiano
Alexander Briger ha dato sfoggio delle sue
qualità interpretative in entrambi i lavori. Nel
delizioso concerto mozartiano, protagonista
della serata e per la prima volta da me
ascoltata, la giovane pianista franco-albanese
Marie-Ange Nguci ha rivelato doti pianistiche di
eccellente resa stilistica attraverso un tocco
sicuro, chiaro, ben delineato nei piani sonori e
certamente importante per lo svolgimento
complessivo delle sonorità orchestrali. Il
rapporto tra
 tutti e solista è stato di ottimo
equilibrio volumetrico e di corposa miscela
timbrica. L'apparente semplicità discorsiva del
concerto di Mozart abbisogna di riempire con
spessore interpretativo le semplici ed
espressive frasi musicali delineate dalla
successione di poche ma pregnanti note e la
Nguci ha dato un grande prova di alta qualità
discorsiva. Il virtuosismo più complesso della
pianista è poi emerso nei due bis concessi di
cui il primo era per la sola mano sinistra. Dopo
l'intervallo, un cambio totale di registro ha
definito la Quarta Sinfonia di Brahms per
una direzione ed una esecuzione di ottimo
livello, mediata da un'energica sintesi ben
chiarificata dalle sezioni orchestrali e dai
validi interventi solistici. Un concerto
complessivamente valido che troverà la replica
domenica alle ore 16.00. Da non perdere! tutti e solista è stato di ottimo
equilibrio volumetrico e di corposa miscela
timbrica. L'apparente semplicità discorsiva del
concerto di Mozart abbisogna di riempire con
spessore interpretativo le semplici ed
espressive frasi musicali delineate dalla
successione di poche ma pregnanti note e la
Nguci ha dato un grande prova di alta qualità
discorsiva. Il virtuosismo più complesso della
pianista è poi emerso nei due bis concessi di
cui il primo era per la sola mano sinistra. Dopo
l'intervallo, un cambio totale di registro ha
definito la Quarta Sinfonia di Brahms per
una direzione ed una esecuzione di ottimo
livello, mediata da un'energica sintesi ben
chiarificata dalle sezioni orchestrali e dai
validi interventi solistici. Un concerto
complessivamente valido che troverà la replica
domenica alle ore 16.00. Da non perdere!
26 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
La Filarmonica della
Scala diretta da Ingo Metzmacher per Luigi Nono
e Dmitrij
Šostakovič
Meritato successo al Teatro alla Scala alla
seconda replica del concerto sinfonico che
prevedeva alla direzione della Filarmonica
scaligera il tedesco Ingo Metzmacher per un
omaggio a Claudio Abbado che oltre cinquant'anni
fa, proprio alla Scala nel 1972, esegui
l'importante brano del compositore veneto Luigi
Nono “Como una ola de fuerza y luz“.
Quest'anno ricorre il centenario dalla nascita
di Nono, uno dei grandi
 esponenti
italiani delle avanguardie musicali post anni
'50 esponenti
italiani delle avanguardie musicali post anni
'50
-
insieme a Berio e Maderna-
che cambiarono i modi di concepire la musica
facendo anche uso della musica elettronica e
unendo i linguaggi registrati in laboratorio,
nello storico centro di Fonologia Musicale della
Rai,
con le esecuzioni strumentali dal vivo. Ricorre
anche il decennale
dalla morte di
Claudio Abbado. Il brano di circa trenta minuti
che ha anticipato l'esecuzione della Sinfonia
n.4 di Dmitrij Šostakovič, era per
Soprano, pianoforte, orchestra e nastro
magnetico e ha trovato la voce di Serena Sáenz
e il pianoforte di
Pierre-Laurent Aimard, uno dei massimi
interpreti del repertorio contemporaneo. Regista
del suono Paolo Zavagna. Il suggestivo impatto
del corposo lavoro di Nono ha riempito di
stratificazioni sonore il Teatro scaligero
attraverso la perfetta miscelazione della parte
registrata, quella originale di allora, alle
sonorità orchestrali dirette in modo eccellente
da Ingo Metzmacher, direttore specialista nella
musica
 del
Novecento e contemporanea. L'alternanza tra i
registri alti della limpida voce di Serena Sáenz,
sia nel canto che nella lettura del testo di
Nono tratto dal poema di Julio Huasi Luciano, e
l'incisiva componente percussiva dove anche il
pianoforte, suonato in modo impeccabile da
Aimard soprattutto nei registri gravi in modo da
fondersi con i roboanti effetti delle
percussioni, ha ricreato quell'atmosfera magica
e rivoluzionaria di quel particolare periodo
storico del quale Nono fu tra i più autorevoli
rappresentanti. Splendida esecuzione. Dopo il
breve intervallo, un'esemplare interpretazione
della Quarta Sinfonia di
Šostakovič in Do minore op.43 (1937) ha
rivelato il personalissimo linguaggio del
compositore russo. Il lungo brano in quattro
movimenti - Allegretto poco moderato,
Moderato con moto, Largo e Allegretto -
ricco di contrasti, cambiamenti di tempo,
momenti raccolti e altri di fragorose
esternazioni timbriche,
è stato espresso con
maestria dalla Filarmonica della Scala e dalla
dettagliata direzione di Metzmacher. Successo
inevitabile. del
Novecento e contemporanea. L'alternanza tra i
registri alti della limpida voce di Serena Sáenz,
sia nel canto che nella lettura del testo di
Nono tratto dal poema di Julio Huasi Luciano, e
l'incisiva componente percussiva dove anche il
pianoforte, suonato in modo impeccabile da
Aimard soprattutto nei registri gravi in modo da
fondersi con i roboanti effetti delle
percussioni, ha ricreato quell'atmosfera magica
e rivoluzionaria di quel particolare periodo
storico del quale Nono fu tra i più autorevoli
rappresentanti. Splendida esecuzione. Dopo il
breve intervallo, un'esemplare interpretazione
della Quarta Sinfonia di
Šostakovič in Do minore op.43 (1937) ha
rivelato il personalissimo linguaggio del
compositore russo. Il lungo brano in quattro
movimenti - Allegretto poco moderato,
Moderato con moto, Largo e Allegretto -
ricco di contrasti, cambiamenti di tempo,
momenti raccolti e altri di fragorose
esternazioni timbriche,
è stato espresso con
maestria dalla Filarmonica della Scala e dalla
dettagliata direzione di Metzmacher. Successo
inevitabile.
26 gennaio
2024 Cesare Guzzardella
LA LIRA DI ORFEO AL
CONSERVATORIO CANTELLI DI NOVARA
Il
Conservatorio Cantelli di Novara da anni ha
avviato una sezione di corsi strumentali
dedicata specificatamente alla musica barocca,
il cui frutto è la creazione di un Ensemble
Barocco, formato dai migliori allievi dei corsi,
nonché periodici e interessanti concerti
dedicati a particolari aspetti di questo
affascinante periodo della Storia della musica.
Quest’anno vedrà una serie di concerti
intitolata ‘La lira di Orfeo’, dedicata alla
scoperta degli strumenti della musica barocca,
il primo dei quali, dedicato al clavicembalo e
al violino barocco, si è tenuto ieri, giovedì 25
gennaio, nella Sala Tognatti del Conservatorio,
in cui l’Ensemble Barocco del Cantelli vedeva la
partecipazione degli allievi delle classi della
Professoressa Centurioni (violino) e del Maestro
Bonizzoni (clavicembalo). Va precisato che per ‘violino
barocco’ s’intende uno strumento, in uso grosso
modo tra metà’500 e primi del’700, un poco
diverso dal violino moderno: leggermente più
piccolo nelle dimensioni, con manico e tastiera
più corti, ma soprattutto con una montatura diversa,
un’anima più corta, dal suono particolarmente
chiaro e trasparente, ricco di armonici e
risonanze, di minor volume rispetto ai violini
moderni (il che lo rende più adatto ad un
accompagnamento del clavicembalo), ma piuttosto
brillante. Ad iniziare il concerto sono stati i
tre giovani violinisti Michele Alziati, Gabriele
Cervia, e Federica Rolli, accompagnati dal basso
continuo, affidato alla classica coppia
violoncello (Andrea Alziati) e clavicembalo
(Luca Canneto). Il brano presentato era di
Fabrizio Caroso (1530 ca.
–
1605), autore poco noto anche agli studiosi,
tant’è
che e ne ignorano
quasi del tutto le vicende biografiche. Si
tratta di una versione per soli strumenti di una
composizione destinata ad accompagnare una danza
con un madrigale a due voci, ‘Celeste giglio”.
Buona l’esecuzione, con il suono brillante dei
violini che, intrecciandosi al timbro più scuro
del violoncello e a quello secco e quasi
metallico del clavicembalo, ha animato con
varietà di colori il vivace ritmo di danza di
questo tipico pezzo da festa di corte. Alessio
Platinetti ha poi eseguito al cembalo la Toccata
prima, dal Primo libro di toccate (1615) di
Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Davvero
apprezzabile la bravura con cui Platinetti ha
saputo dare voce alla tipica espressività della
musica barocca, quella musica degli ‘affetti’,
che si realizza nella caratteristica varietà
toccatistica con la sua sapiente alternanza di
passi lirici e polifonici, col frequente
cambiamento di temi, dei ritmi, della scrittura,
qui imitativa e in libero contrappunto, con
rapidi passaggi. Una festa per le orecchie,
creata da un grandissimo musicista e ottimamente
eseguita da un giovane già dotato del pieno
controllo tecnico della tastiera. A Frescobaldi,
uno dei più importanti tastieristi del Barocco
musicale, seguiva nell’impaginato del concerto,
una sonata del bresciano Biagio Marini
(!587-1665), forse meno noto di Frescobaldi, ma
non meno importante storicamente, perché fu tra
gli inventori della sonata per violino: in
assoluto, fu il primo violinista a noi noto a
scrivere per il suo strumento. Il pezzo di
Marini in programma era la Sonata IV sopra due
corde dall’Opus VIII. Come Frescobaldi con la
Toccata per clavicembalo, così anche Marini
nella Sonata per violino adotta una forma
strutturalmente molto libera nell’alternanza di
movimenti lenti e veloci, senza alcuno schema
vincolante di
ma soprattutto con una montatura diversa,
un’anima più corta, dal suono particolarmente
chiaro e trasparente, ricco di armonici e
risonanze, di minor volume rispetto ai violini
moderni (il che lo rende più adatto ad un
accompagnamento del clavicembalo), ma piuttosto
brillante. Ad iniziare il concerto sono stati i
tre giovani violinisti Michele Alziati, Gabriele
Cervia, e Federica Rolli, accompagnati dal basso
continuo, affidato alla classica coppia
violoncello (Andrea Alziati) e clavicembalo
(Luca Canneto). Il brano presentato era di
Fabrizio Caroso (1530 ca.
–
1605), autore poco noto anche agli studiosi,
tant’è
che e ne ignorano
quasi del tutto le vicende biografiche. Si
tratta di una versione per soli strumenti di una
composizione destinata ad accompagnare una danza
con un madrigale a due voci, ‘Celeste giglio”.
Buona l’esecuzione, con il suono brillante dei
violini che, intrecciandosi al timbro più scuro
del violoncello e a quello secco e quasi
metallico del clavicembalo, ha animato con
varietà di colori il vivace ritmo di danza di
questo tipico pezzo da festa di corte. Alessio
Platinetti ha poi eseguito al cembalo la Toccata
prima, dal Primo libro di toccate (1615) di
Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Davvero
apprezzabile la bravura con cui Platinetti ha
saputo dare voce alla tipica espressività della
musica barocca, quella musica degli ‘affetti’,
che si realizza nella caratteristica varietà
toccatistica con la sua sapiente alternanza di
passi lirici e polifonici, col frequente
cambiamento di temi, dei ritmi, della scrittura,
qui imitativa e in libero contrappunto, con
rapidi passaggi. Una festa per le orecchie,
creata da un grandissimo musicista e ottimamente
eseguita da un giovane già dotato del pieno
controllo tecnico della tastiera. A Frescobaldi,
uno dei più importanti tastieristi del Barocco
musicale, seguiva nell’impaginato del concerto,
una sonata del bresciano Biagio Marini
(!587-1665), forse meno noto di Frescobaldi, ma
non meno importante storicamente, perché fu tra
gli inventori della sonata per violino: in
assoluto, fu il primo violinista a noi noto a
scrivere per il suo strumento. Il pezzo di
Marini in programma era la Sonata IV sopra due
corde dall’Opus VIII. Come Frescobaldi con la
Toccata per clavicembalo, così anche Marini
nella Sonata per violino adotta una forma
strutturalmente molto libera nell’alternanza di
movimenti lenti e veloci, senza alcuno schema
vincolante di
 successione,
perseguendo lo scopo di variare i movimenti a
seconda degli affetti. Il giovane violinista
Gabriele Cervia, accompagnato al basso da
Alessio Platinetti, si fa davvero ammirare per
la bravura con cui, dando smalto al suono
brillante delle sue quattro corde, interpreta in
modo convincente il ricco mondo di affetti di
questo bel pezzo, dimostrando un virtuosismo
tecnico già maturo nei passaggi più rapidi,
nelle doppie corde , nei trilli, che abbondano
nella scrittura di Marini, a potenziare la linea
espressiva delle composizioni. Dall’Italia alla
Francia con Francois Couperin (1668-1733) con
una Courante, in cui ha dato ottima prova di sé
il clavicembalista Gioele Cantalovo, nel
valorizzare le diverse soluzioni
timbrico-armoniche, secondo una tecnica di cui
Couperin fu maestro alle generazioni successive
di clavicembalisti, a cominciare dal suo più
diretto erede, Philippe Rameau (1683-!764), come
dimostra la sua Dauphine (1747), l’ultima
composizione accertata per clavicembalo di
Rameau. Pezzo isolato, non appartenente ad
alcuno dei tre libri dei Pièces de clavecin,
scritto in occasione delle nozze del Delfino di
Francia, donde il titolo, presenta un carattere
spiccatamente toccatistico, con il libero
alternarsi di sezioni lente e altre veloci, con
notevole tasso di virtuosismo tecnico nei
passaggi rapidi e densità contrappuntistica,
banco di prova, una volta di più, della piena
maturità tecnica di Cantalovo. Di nuovo Couperin
con La Piemontoise, dal IV Ordre,” Le Nations”,
qui in versione per due violini (Gabriele Cervia
e Federica Rolli), col basso continuo del
violoncello (Andrea Alziati), e del clavicembalo
(Gioele Cantalovo). Brano ‘descrittivo’, vive
tutto dei diversi timbri dei tre strumenti,
nella contrapposizione tra il brillante suono
dei violini e il sottofondo caldo e scuro del
violoncello e della vivacità ritmica che
contraddistingue gran parte del pezzo, aspetti
resi entrambi al meglio, con ottima intesa tra
le parti, dai quattro esecutori. L’Ensemble
Barocco del Cantelli affida al clavicembalista
Luca Canneto l’esecuzione della Ciaccona del
tedesco Johann Caspar Ferdinand Fischer, pezzo
che risente chiaramente dell’influenza francese,
in particolare per la ricchezza
dell’ornamentazione, unita peraltro ad una
scienza contrappuntistica tipicamente tedesca.
Chiamato a confrontarsi con queste
caratteristiche, Canneto se la cava egregiamente,
mostrando anche lui di aver già raggiunto una
valida padronanza tecnica dello strumento.
Questo concerto barocco non poteva non
concludersi con un omaggio a due protagonisti
assoluti di quella lunga stagione musicale, e
tra i grandissimi della musica di ogni tempo:
Arcangelo Corelli, e, ovviamente, J.S. Bach.
Apprezzatissimo, per la cantabilità lirica di
limpido melodismo del violino di Michele Alziati
l’Adagio dalla sonata terza dal Libro V per
violino e clavicembalo di Arcangelo Corelli, con
Matteo Cotti al cembalo. Con una scelta di
grande interesse il pezzo è stato suonato in due
versioni: la prima è quella contenuta nel
manoscritto autografo, molto asciutta e priva di
ornamentazione. Si sa che per Corelli e per
molti compositori e musicisti dell’epoca
l’ornamentazione non era obbligata, ma affidata
all’estro dell’improvvisazione e quindi la
partitura era poco più che un canovaccio. E’
stata quindi proposta una seconda versione di
questo Adagio di Corelli, da un’edizione
olandese delle sue sonate, caratterizzata dalla
presenza di ricche ornamentazioni (trilli,
acciaccature e mordenti), che si presume
riproducesse la pratica esecutiva di Corelli: ne
è risultato un brano di affascinante ‘belcantismo’
italiano, trasposto per il violino. I primi due
movimenti della Sonata per violino e
clavicembalo di J. S. Bach in Mi maggiore
Adagio/Allegro BWV 1016 sono stati eseguiti da
Gabriele Cervia al violino e Matteo Cotti al
clavicembalo. Com’è risaputo , nel gruppo di
Sonate BWV 1014-1019, il cembalo ‘obbligato’
acquista un peso strumentale che va ben oltre la
semplice funzione di basso continuo, dialogando
alla pari con il violino. Purtroppo, forse per
la stanchezza, forse per l’emozione o la
difficoltà tecnica del pezzo, l’esecuzione del
pur bravo Cervia, con qualche stecca e note ‘sporcate’
di troppo, non è stata impeccabile, mentre Cotti
al clavicembalo ha dato ottima prova di sé, sia
nell’Adagio, in cui la mano destra (la sinistra
ha un puro compito di sostegno accordale), è
chiamata, in dialogo col violino
all’elaborazione di un motivo ostinato,
piacevolmente cantabile e ornato di varie
fioriture ‘belcantistiche’, sia nell’Allegro,
che presenta un severo contrappuntismo, con un
impegnativo stile fugato, eseguito con
trasparenza e precisione: stile ‘italiano’ e
‘stile tedesco’, si uniscono esemplarmente nel
momento più alto e conclusivo della musica
barocca, il genio bachiano. Gli applausi
scroscianti del pubblico presente in Sala
Tognatti testimoniano il pieno successo di
questo concerto e il riconoscimento di una nuova
realtà che si sta affacciando sulla scena
musicale di Novara: l’Ensemble Barocco del
Cantelli. successione,
perseguendo lo scopo di variare i movimenti a
seconda degli affetti. Il giovane violinista
Gabriele Cervia, accompagnato al basso da
Alessio Platinetti, si fa davvero ammirare per
la bravura con cui, dando smalto al suono
brillante delle sue quattro corde, interpreta in
modo convincente il ricco mondo di affetti di
questo bel pezzo, dimostrando un virtuosismo
tecnico già maturo nei passaggi più rapidi,
nelle doppie corde , nei trilli, che abbondano
nella scrittura di Marini, a potenziare la linea
espressiva delle composizioni. Dall’Italia alla
Francia con Francois Couperin (1668-1733) con
una Courante, in cui ha dato ottima prova di sé
il clavicembalista Gioele Cantalovo, nel
valorizzare le diverse soluzioni
timbrico-armoniche, secondo una tecnica di cui
Couperin fu maestro alle generazioni successive
di clavicembalisti, a cominciare dal suo più
diretto erede, Philippe Rameau (1683-!764), come
dimostra la sua Dauphine (1747), l’ultima
composizione accertata per clavicembalo di
Rameau. Pezzo isolato, non appartenente ad
alcuno dei tre libri dei Pièces de clavecin,
scritto in occasione delle nozze del Delfino di
Francia, donde il titolo, presenta un carattere
spiccatamente toccatistico, con il libero
alternarsi di sezioni lente e altre veloci, con
notevole tasso di virtuosismo tecnico nei
passaggi rapidi e densità contrappuntistica,
banco di prova, una volta di più, della piena
maturità tecnica di Cantalovo. Di nuovo Couperin
con La Piemontoise, dal IV Ordre,” Le Nations”,
qui in versione per due violini (Gabriele Cervia
e Federica Rolli), col basso continuo del
violoncello (Andrea Alziati), e del clavicembalo
(Gioele Cantalovo). Brano ‘descrittivo’, vive
tutto dei diversi timbri dei tre strumenti,
nella contrapposizione tra il brillante suono
dei violini e il sottofondo caldo e scuro del
violoncello e della vivacità ritmica che
contraddistingue gran parte del pezzo, aspetti
resi entrambi al meglio, con ottima intesa tra
le parti, dai quattro esecutori. L’Ensemble
Barocco del Cantelli affida al clavicembalista
Luca Canneto l’esecuzione della Ciaccona del
tedesco Johann Caspar Ferdinand Fischer, pezzo
che risente chiaramente dell’influenza francese,
in particolare per la ricchezza
dell’ornamentazione, unita peraltro ad una
scienza contrappuntistica tipicamente tedesca.
Chiamato a confrontarsi con queste
caratteristiche, Canneto se la cava egregiamente,
mostrando anche lui di aver già raggiunto una
valida padronanza tecnica dello strumento.
Questo concerto barocco non poteva non
concludersi con un omaggio a due protagonisti
assoluti di quella lunga stagione musicale, e
tra i grandissimi della musica di ogni tempo:
Arcangelo Corelli, e, ovviamente, J.S. Bach.
Apprezzatissimo, per la cantabilità lirica di
limpido melodismo del violino di Michele Alziati
l’Adagio dalla sonata terza dal Libro V per
violino e clavicembalo di Arcangelo Corelli, con
Matteo Cotti al cembalo. Con una scelta di
grande interesse il pezzo è stato suonato in due
versioni: la prima è quella contenuta nel
manoscritto autografo, molto asciutta e priva di
ornamentazione. Si sa che per Corelli e per
molti compositori e musicisti dell’epoca
l’ornamentazione non era obbligata, ma affidata
all’estro dell’improvvisazione e quindi la
partitura era poco più che un canovaccio. E’
stata quindi proposta una seconda versione di
questo Adagio di Corelli, da un’edizione
olandese delle sue sonate, caratterizzata dalla
presenza di ricche ornamentazioni (trilli,
acciaccature e mordenti), che si presume
riproducesse la pratica esecutiva di Corelli: ne
è risultato un brano di affascinante ‘belcantismo’
italiano, trasposto per il violino. I primi due
movimenti della Sonata per violino e
clavicembalo di J. S. Bach in Mi maggiore
Adagio/Allegro BWV 1016 sono stati eseguiti da
Gabriele Cervia al violino e Matteo Cotti al
clavicembalo. Com’è risaputo , nel gruppo di
Sonate BWV 1014-1019, il cembalo ‘obbligato’
acquista un peso strumentale che va ben oltre la
semplice funzione di basso continuo, dialogando
alla pari con il violino. Purtroppo, forse per
la stanchezza, forse per l’emozione o la
difficoltà tecnica del pezzo, l’esecuzione del
pur bravo Cervia, con qualche stecca e note ‘sporcate’
di troppo, non è stata impeccabile, mentre Cotti
al clavicembalo ha dato ottima prova di sé, sia
nell’Adagio, in cui la mano destra (la sinistra
ha un puro compito di sostegno accordale), è
chiamata, in dialogo col violino
all’elaborazione di un motivo ostinato,
piacevolmente cantabile e ornato di varie
fioriture ‘belcantistiche’, sia nell’Allegro,
che presenta un severo contrappuntismo, con un
impegnativo stile fugato, eseguito con
trasparenza e precisione: stile ‘italiano’ e
‘stile tedesco’, si uniscono esemplarmente nel
momento più alto e conclusivo della musica
barocca, il genio bachiano. Gli applausi
scroscianti del pubblico presente in Sala
Tognatti testimoniano il pieno successo di
questo concerto e il riconoscimento di una nuova
realtà che si sta affacciando sulla scena
musicale di Novara: l’Ensemble Barocco del
Cantelli.
25 gennaio
2024 Bruno Busca
L' ottimo Mozart
con il
clarinetto di Dimitri Ashkenazy e la direzione
di Beatrice Venezi
Il concerto
ascoltato in anteprima questa mattina al Dal
Verme aveva come brano di maggior attesa il
Concerto per Clarinetto e Orchestra in la
maggiore K. 622 di W. A. Mozart e come
 solista di riferimento il clarinettista Dimitri
Ashkenazy. A completare il programma due lavori
ispirati dal Settecento mozartiano o da epoche
barocche più lontane quali Le Tombeau de
Couperin di Ravel e la Sinfonia n.1 in re
maggiore op. 25 "Classica" di Prokofiev.
Alla direzione dell'Orchestra dei Pomeriggi
Musicali c'era Beatrice Venezi. Di rilevante
qualità, il celebre
concerto mozartiano -una delle sue ultimissime solista di riferimento il clarinettista Dimitri
Ashkenazy. A completare il programma due lavori
ispirati dal Settecento mozartiano o da epoche
barocche più lontane quali Le Tombeau de
Couperin di Ravel e la Sinfonia n.1 in re
maggiore op. 25 "Classica" di Prokofiev.
Alla direzione dell'Orchestra dei Pomeriggi
Musicali c'era Beatrice Venezi. Di rilevante
qualità, il celebre
concerto mozartiano -una delle sue ultimissime
 composizioni ( ottobre 1791) - è stato
ottimamente sostenuto da Ashkenazi, orientato da
una direzione che, in questo capolavoro di
scrittura, si è rivelata più che all'altezza. Le
sonorità trasparenti e ben miscelate degli
orchestrali de "I Pomariggi" hanno
trovato una precisa ed espressiva risposta nel
solismo del
clarinettista. Dopo la breve pausa, i due lavori
orchestrali di Ravel e di Prokoviev composti
entrambi attorno al 1915, hanno trovato una
buona esecuzione. Il riferimento al barocco in
Ravel, con le quattro parti- Préludes,
Forlane, Menuet e Rigaudon- che
compongono il lavoro di Ravel e la classicità
del brano di Prokofiev meritavano una
definizione più netta delle timbriche e maggiori
contrasti tra i rispettivi andamenti. Un
concerto comunque complessivamente valido che
avrà la prima ufficiale questa sera alle 20.00 e
la replica sabato prossimo alle 17.00. Si
consiglia la partecipazione. composizioni ( ottobre 1791) - è stato
ottimamente sostenuto da Ashkenazi, orientato da
una direzione che, in questo capolavoro di
scrittura, si è rivelata più che all'altezza. Le
sonorità trasparenti e ben miscelate degli
orchestrali de "I Pomariggi" hanno
trovato una precisa ed espressiva risposta nel
solismo del
clarinettista. Dopo la breve pausa, i due lavori
orchestrali di Ravel e di Prokoviev composti
entrambi attorno al 1915, hanno trovato una
buona esecuzione. Il riferimento al barocco in
Ravel, con le quattro parti- Préludes,
Forlane, Menuet e Rigaudon- che
compongono il lavoro di Ravel e la classicità
del brano di Prokofiev meritavano una
definizione più netta delle timbriche e maggiori
contrasti tra i rispettivi andamenti. Un
concerto comunque complessivamente valido che
avrà la prima ufficiale questa sera alle 20.00 e
la replica sabato prossimo alle 17.00. Si
consiglia la partecipazione.
25 gennaio
2024 Cesare Guzzardella
Slancio, rigore e
passione per
Anna Tifu e Giuseppe Andaloro
Decisamente azzeccata la denominazione "Slancio,
rigore e passione" data al concerto della
violinista sarda Anna Tifu e dal pianista
siciliano Giuseppe Andaloro nella serata
organizzata dalla Società dei Concerti.
Da moltissimi anni suonano in duo e
preparano impaginati particolarmente variegati e
ricchi di virtuosismo. Nelle pagine ascoltate
ieri sera i musicisti scelti erano Grieg,
Schumann e Prokofiev per complessivi quattro
brani, almeno due dei quali molto eseguiti. La
celebre Sonata n. 3 in do minore op. 45
di E. Grieg ha introdotto il concerto
 rivelando
da subito l'alta cifra espressiva e l'intesa di
questa coppia in musica, che è andata in questi
anni via via migliorando nel corso dei numerosi
concerti sostenuti. Lo slancio, il
rigore tecnico e la passione
generata da una naturale capacità di unire
ragione e sentimento ha avuto una conferma nei
tre movimenti che compongono una sonata ricca di
elementi folcloristici, scritta dal musicista
norvegese nel 1887. Con la Fantasia in do
magg. op. 131 di Robert Schumann, composta
nel 1853 e di rarissima esecuzione, il mondo
romantico è stato ancor più delineato da
un'esecuzione apparentemente estemporanea ma che
in realtà rivela uno studio approfondito di ogni
dettaglio. Con il Prokofiev della rara Sonata
n.1 in fa minore op.80, un lavoro cupo e
tormentato, estremamente vario e sfaccettato,
composto dal grande russo tra il 1938 e il 1946,
è emersa la prorompente abilità di Andaloro di
ricreare la struttura del brano con giusta
enfasi per esternare timbriche ricche di energia
e d'impatto scultoreo. La sua è una naturale
abilità di esprimersi alla tastiera in modo
chiaro, mettendo in risalto le parti più
nascoste del difficile brano. La parte
violinistica, altrettanto importante, espressa
con precisione dalla Tifu, ha creato l'atmosfera
unitaria della sonata, caratterizzata rivelando
da subito l'alta cifra espressiva e l'intesa di
questa coppia in musica, che è andata in questi
anni via via migliorando nel corso dei numerosi
concerti sostenuti. Lo slancio, il
rigore tecnico e la passione
generata da una naturale capacità di unire
ragione e sentimento ha avuto una conferma nei
tre movimenti che compongono una sonata ricca di
elementi folcloristici, scritta dal musicista
norvegese nel 1887. Con la Fantasia in do
magg. op. 131 di Robert Schumann, composta
nel 1853 e di rarissima esecuzione, il mondo
romantico è stato ancor più delineato da
un'esecuzione apparentemente estemporanea ma che
in realtà rivela uno studio approfondito di ogni
dettaglio. Con il Prokofiev della rara Sonata
n.1 in fa minore op.80, un lavoro cupo e
tormentato, estremamente vario e sfaccettato,
composto dal grande russo tra il 1938 e il 1946,
è emersa la prorompente abilità di Andaloro di
ricreare la struttura del brano con giusta
enfasi per esternare timbriche ricche di energia
e d'impatto scultoreo. La sua è una naturale
abilità di esprimersi alla tastiera in modo
chiaro, mettendo in risalto le parti più
nascoste del difficile brano. La parte
violinistica, altrettanto importante, espressa
con precisione dalla Tifu, ha creato l'atmosfera
unitaria della sonata, caratterizzata
 dal
riconoscibile linguaggio del compositore. Un'
interpretazione di alta levatura estetica. Con
l'ultimo lavoro dell'impaginato, rimanendo in
Sergej Prokofiev, la scelta della Suite da
Romeo e Giulietta del 1937 ci ha permesso di
riascoltare i dieci celebri brevi brani di
questo capolavoro destinato al balletto, ma
particolarmente diffuso anche nella versione
orchestrale e cameristica. Il bellissimo vibrato
del voluminoso violino di Anna Tifu, espresso
con una precisa intonazione dello strumento
anche nei più impervi sopracuti e con
un'accattivante modalità di fraseggio, si è
unito alle corpose armonizzazioni e al
virtuosistico modo di melodiare di Andaloro.
Ancora una volta la resa interpretativa è
risultata altamente espressiva ed è stata
apprezzata dal pubblico presente in Sala Verdi
attraverso fragorosi applausi. Ottimo il bis
concesso con un esemplare Blues, secondo
movimento dalla Sonata n.2 (1923-27) di
Maurice Ravel, interpretato dal duo con grinta
jazzistica. dal
riconoscibile linguaggio del compositore. Un'
interpretazione di alta levatura estetica. Con
l'ultimo lavoro dell'impaginato, rimanendo in
Sergej Prokofiev, la scelta della Suite da
Romeo e Giulietta del 1937 ci ha permesso di
riascoltare i dieci celebri brevi brani di
questo capolavoro destinato al balletto, ma
particolarmente diffuso anche nella versione
orchestrale e cameristica. Il bellissimo vibrato
del voluminoso violino di Anna Tifu, espresso
con una precisa intonazione dello strumento
anche nei più impervi sopracuti e con
un'accattivante modalità di fraseggio, si è
unito alle corpose armonizzazioni e al
virtuosistico modo di melodiare di Andaloro.
Ancora una volta la resa interpretativa è
risultata altamente espressiva ed è stata
apprezzata dal pubblico presente in Sala Verdi
attraverso fragorosi applausi. Ottimo il bis
concesso con un esemplare Blues, secondo
movimento dalla Sonata n.2 (1923-27) di
Maurice Ravel, interpretato dal duo con grinta
jazzistica.
25 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
Meritato successo
alla Scala per la Médée di Cherubini
Successo per
la Médée di Luigi Cherubini alla quarta
rappresentazione scaligera. Prima dell'inizio il
sovrintendente Dominique Meyer ha annunciato la
sostituzione del soprano Marina Rebeka,
influenzata, con Claire de Monteil nel ruolo di
Médée. Per la prima volta l'opera in tre
atti del compositore italiano su libretto di
François-Benoît Hoffmann è stata eseguita
 al
Teatro alla Scala nella versione in francese.
Resa celebre nella versione italiana dalla
Callas con le direzioni di Leonard Bernstein e
di Thomas Schippers negli anni '50 e '60 del
secolo scorso, Medea trovò nel teatro milanese
la sua ultima rappresentazione nel maggio del
1962. La nuova produzione scaligera ha visto la
regia di Damiano Michieletto sulle scene moderne
e minimali di Paolo Fantin, i costumi recenti di
Carla Teti, le luci, particolarmente rilevanti,
di Alessandro Carletti e la drammaturgia di
Mattia Palma. . È un'unica scena per tutti i tre
atti - raggruppati in due parti- che mostra un
ambiente moderno della ricca borghesia in
sostituzione di quello che era il palazzo di
Crèon a Corinto. Una modernizzazione che nulla
toglie al ruolo ambiguo, tra amore e odio, della
protagonista Médée. Michieletto con la sua regia
essenziale, probabilmente ha voluto mettere a
nudo i protagonisti utilizzando al
Teatro alla Scala nella versione in francese.
Resa celebre nella versione italiana dalla
Callas con le direzioni di Leonard Bernstein e
di Thomas Schippers negli anni '50 e '60 del
secolo scorso, Medea trovò nel teatro milanese
la sua ultima rappresentazione nel maggio del
1962. La nuova produzione scaligera ha visto la
regia di Damiano Michieletto sulle scene moderne
e minimali di Paolo Fantin, i costumi recenti di
Carla Teti, le luci, particolarmente rilevanti,
di Alessandro Carletti e la drammaturgia di
Mattia Palma. . È un'unica scena per tutti i tre
atti - raggruppati in due parti- che mostra un
ambiente moderno della ricca borghesia in
sostituzione di quello che era il palazzo di
Crèon a Corinto. Una modernizzazione che nulla
toglie al ruolo ambiguo, tra amore e odio, della
protagonista Médée. Michieletto con la sua regia
essenziale, probabilmente ha voluto mettere a
nudo i protagonisti utilizzando modalità teatrali attuali, partendo dall'idea
che la triste vicenda, ispirata dalla tragedia
classica di Euripide, da quella di Seneca e poi
da quella seicentesca di Corneille, è quella che
purtroppo comunemente accade ai nostri giorni.
L'eccellente orchestrazione di Michele Gamba ha
dato unità al lavoro. Il suo approccio alla
musica di fine Settecento di Cherubini,
proiettata però verso il Romanticismo, ha
sintesi discorsiva con timbriche spesso
energiche, ricche di ritmo. Il suo approccio è
ideale per rendere attuale una partitura ricca
di idee, moderna e in sintonia con la
modernizzazione operata dal regista. Le parti
recitate sono molto ridotte rispetto la versione
originale francese andata in scena a Parigi nel
1797, e la vicenda viene anche raccontata dalle
voci registrate in francese ( voci di T.Nessi e
S. Barri ) dei bambini, figli di Médée, che
interrompendo il flusso teatrale creano momenti
di tenera riflessione soprattutto nel delineare
l'amore di questi verso la madre. Il complessivo
ottimo cast vocale ha trovato l'inaspettata voce
di Médée in Claire de Monteil, un soprano
che dal suo ingresso,
modalità teatrali attuali, partendo dall'idea
che la triste vicenda, ispirata dalla tragedia
classica di Euripide, da quella di Seneca e poi
da quella seicentesca di Corneille, è quella che
purtroppo comunemente accade ai nostri giorni.
L'eccellente orchestrazione di Michele Gamba ha
dato unità al lavoro. Il suo approccio alla
musica di fine Settecento di Cherubini,
proiettata però verso il Romanticismo, ha
sintesi discorsiva con timbriche spesso
energiche, ricche di ritmo. Il suo approccio è
ideale per rendere attuale una partitura ricca
di idee, moderna e in sintonia con la
modernizzazione operata dal regista. Le parti
recitate sono molto ridotte rispetto la versione
originale francese andata in scena a Parigi nel
1797, e la vicenda viene anche raccontata dalle
voci registrate in francese ( voci di T.Nessi e
S. Barri ) dei bambini, figli di Médée, che
interrompendo il flusso teatrale creano momenti
di tenera riflessione soprattutto nel delineare
l'amore di questi verso la madre. Il complessivo
ottimo cast vocale ha trovato l'inaspettata voce
di Médée in Claire de Monteil, un soprano
che dal suo ingresso, nella parte finale del primo atto, è andata
qualitativamente in crescendo sino ad un'ottima
resa finale sia nella vocalità, con timbrica dai
colori scuri di ottima resa espressiva , sia
attorialmente. Di grande pregnanza coloristica
la voce di Martina Russomanno, una Dircé
ben orientata in palcoscenico; valido Nahuel di
Pierro in Créon e in crescendo vocalmente
Stanislav De Barbeyrac, Jason, ottimo nel
finale del terzo atto; decisamente valida la
voce di Ambroisine Bré in Néris specie
nellaria "Ah! Nos peines seront communes".
Di qualità Greta Doveri e Mara Gaudenzi.
Eccellente, come sempre, il Coro scaligero ben
inserito in scena, preparato da Alberto Malazzi.
Bravi attorialmente i figli di Jason e
Médée nei nomi di Tobia Pintor e Giada Riontino.
Successo deciso con applausi sostenuti per tutti.
Prossime recite il 26 e il 28 gennaio.(prime
due foto di Brescia e Amisano- Archivio
della Scala)
nella parte finale del primo atto, è andata
qualitativamente in crescendo sino ad un'ottima
resa finale sia nella vocalità, con timbrica dai
colori scuri di ottima resa espressiva , sia
attorialmente. Di grande pregnanza coloristica
la voce di Martina Russomanno, una Dircé
ben orientata in palcoscenico; valido Nahuel di
Pierro in Créon e in crescendo vocalmente
Stanislav De Barbeyrac, Jason, ottimo nel
finale del terzo atto; decisamente valida la
voce di Ambroisine Bré in Néris specie
nellaria "Ah! Nos peines seront communes".
Di qualità Greta Doveri e Mara Gaudenzi.
Eccellente, come sempre, il Coro scaligero ben
inserito in scena, preparato da Alberto Malazzi.
Bravi attorialmente i figli di Jason e
Médée nei nomi di Tobia Pintor e Giada Riontino.
Successo deciso con applausi sostenuti per tutti.
Prossime recite il 26 e il 28 gennaio.(prime
due foto di Brescia e Amisano- Archivio
della Scala)
24 gennaio
2024 Cesare Guzzardella
Lucas
Debargue alle
Serate Musicali del Conservatorio
Serate
Musicali
accolgono il pianista francese trentatreenne
Lucas Debargue dal 2017. Nel 2015 otteneva un
premio (quarto posto) al prestigioso
Concorso Internazionale
Čaikovskij
di Mosca e da allora si
è imposto sulla scena
internazionale come uno dei più raffinati
pianisti della sua generazione. La sua vena
creativa -è anche un ottimo jazzista- lo pone
tra gli interpreti con autentica personalità.
Gli impaginati diversificati di questi anni
hanno trovato anche nello splendido concerto di
ieri sera in Sala Verdi una varietà nella scelta
dei compositori: Bach, Chopin,
 Beethoven
e Medtner hanno rivelato, ancora una volta, le
qualità di un interprete che esce dagli schemi
classici sin dal modo di proporre l'ordine dei
brani. Partendo dal Preludio e fuga n.7
del bachiano Clavicembalo ben temperato (
primo libro ) eseguito con una luminosità
evidente in una variegata gamma dinamica,
Debargue è passato poi alla Ballata n.3 op.47
di Chopin, con un salto storico che non
sarebbe accettabile da ogni interprete classico
del passato. I bellissimi colori donati a
Chopin, nella sua personalizzazione erano in
sintonia con il suo Bach. Tornando in dietro nel
tempo ha poi eseguito la celebre Sonata n.14
op.27 n.2 "Al chiaro di luna" di Beethoven.
Il noto Adagio sostenuto iniziale,
eseguito con pacata e profonda interiorizzazione
ha trovato in contrasto l'Allegretto
centrale e poi il rapido Presto agitato
finale espresso nei dettagli e con contrasti ben
delineati nella veloce esternazione. Il ritorno
a Chopin con la splendida Ballata n.4 op.52
ha riportato l'interprete nel territorio
precedente Beethoven
e Medtner hanno rivelato, ancora una volta, le
qualità di un interprete che esce dagli schemi
classici sin dal modo di proporre l'ordine dei
brani. Partendo dal Preludio e fuga n.7
del bachiano Clavicembalo ben temperato (
primo libro ) eseguito con una luminosità
evidente in una variegata gamma dinamica,
Debargue è passato poi alla Ballata n.3 op.47
di Chopin, con un salto storico che non
sarebbe accettabile da ogni interprete classico
del passato. I bellissimi colori donati a
Chopin, nella sua personalizzazione erano in
sintonia con il suo Bach. Tornando in dietro nel
tempo ha poi eseguito la celebre Sonata n.14
op.27 n.2 "Al chiaro di luna" di Beethoven.
Il noto Adagio sostenuto iniziale,
eseguito con pacata e profonda interiorizzazione
ha trovato in contrasto l'Allegretto
centrale e poi il rapido Presto agitato
finale espresso nei dettagli e con contrasti ben
delineati nella veloce esternazione. Il ritorno
a Chopin con la splendida Ballata n.4 op.52
ha riportato l'interprete nel territorio
precedente
 al
compositore tedesco. Decisamente valida e
personale la sua visione chopiniana, eseguita
con tocco leggero ma espressivo, nella
definizione unitaria del lavoro. Il breve
intervallo ha permesso uno stacco per un autore
molto interessante quale il russo Nicolai
Medtner con la sua Sonata n.1 in fa minore
op.5 (1901-1903). Prima delle sue 14 sonate
pianistiche, è un lavoro giovanile assai ampio,
in quattro movimenti, già personale e orientato
ad un notevole virtuosismo come nel sorprendente
Finale.Allegro risolto. Debargue ha
trovato in Medtner un compositore creativo a lui
congeniale per varietà compositiva, con continuo
cambio di tempi e di andature, per una sonata
visionaria particolarmente ispirata. Applausi
fragorosi meriratissimi da parte del pubblico
presente in Sala Verdi, con la presenza di
numerosi giovani. L'infaticabile pianista,
malgrado un serio problema alle gambe che lo ha
costretto a rimanere il più possibile seduto
davanti al pianoforte, ha proposto due
eccellenti bis con due Sonate di Domenico
Scarlatti (K 132 e K 253) tra le
meno eseguite e da lui rese stupendamente nella
varietà dei contrasti. Ancora fragorosi applausi. al
compositore tedesco. Decisamente valida e
personale la sua visione chopiniana, eseguita
con tocco leggero ma espressivo, nella
definizione unitaria del lavoro. Il breve
intervallo ha permesso uno stacco per un autore
molto interessante quale il russo Nicolai
Medtner con la sua Sonata n.1 in fa minore
op.5 (1901-1903). Prima delle sue 14 sonate
pianistiche, è un lavoro giovanile assai ampio,
in quattro movimenti, già personale e orientato
ad un notevole virtuosismo come nel sorprendente
Finale.Allegro risolto. Debargue ha
trovato in Medtner un compositore creativo a lui
congeniale per varietà compositiva, con continuo
cambio di tempi e di andature, per una sonata
visionaria particolarmente ispirata. Applausi
fragorosi meriratissimi da parte del pubblico
presente in Sala Verdi, con la presenza di
numerosi giovani. L'infaticabile pianista,
malgrado un serio problema alle gambe che lo ha
costretto a rimanere il più possibile seduto
davanti al pianoforte, ha proposto due
eccellenti bis con due Sonate di Domenico
Scarlatti (K 132 e K 253) tra le
meno eseguite e da lui rese stupendamente nella
varietà dei contrasti. Ancora fragorosi applausi.
23 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
L'eccellente Royal
Concertgebouw Orchestra diretta da Chung
alla Scala
Il
concerto straordinario di ieri sera al
Teatro alla Scala ha trovato la Royal
Concertgebouw Orchestra diretta da Myung-Whun
Chung. Una compagine, quella olandese, tra le
migliori al mondo, specie nelle grandi sinfonie
di Mahler e di Bruckner. L'impaginato prevedeva
prima il Concerto n.17 in sol maggiore K. 453
di Mozart e poi la Sinfonia n.7 in mi
maggiore di Anton Bruckner. Due compositori
austriaci diretti da un sud-coreano di Seul che
proprio oggi -22 gennaio- compie settantun'anni.
Protagonista del concerto mozartiano Emanuel Ax,
pianista statunitense settantaquatrenne nato in
ucraina. Altissimo il livello estetico dei due
lavori. Il concerto mozartiano ha avuto
 un
fuoriclasse al pianoforte. Il classicismo di Ax
in un autore come Mozart si è rivelato in tutto
il suo equilibrio, nella discreta eleganza e
nella bellezza dei colori che il brano impone.
La componente orchestrale, importante come
quella solistica, era perfettamente in sinergia
con i colori tenui e interiori del pianoforte.
Splendidi tutti e tre i movimenti e rilevante
anche il più estroverso Allegretto finale
definito, tra tonalità maggiore e minore, da una
serie di variazioni sul tema, sia solistiche che
dell'orchestra. Applausi meritatissimi ed
eccellente il bis pianistico di Ax con il
Valzer op.34 n.2 di Frederyc Chopin un
fuoriclasse al pianoforte. Il classicismo di Ax
in un autore come Mozart si è rivelato in tutto
il suo equilibrio, nella discreta eleganza e
nella bellezza dei colori che il brano impone.
La componente orchestrale, importante come
quella solistica, era perfettamente in sinergia
con i colori tenui e interiori del pianoforte.
Splendidi tutti e tre i movimenti e rilevante
anche il più estroverso Allegretto finale
definito, tra tonalità maggiore e minore, da una
serie di variazioni sul tema, sia solistiche che
dell'orchestra. Applausi meritatissimi ed
eccellente il bis pianistico di Ax con il
Valzer op.34 n.2 di Frederyc Chopin eseguito con vellutata pregnanza coloristica.
Dopo il breve intervallo la corposa Settima
Sinfonia di Bruckner è stata esaltata dalla
direzione di Chung e dai colori della splendida
orchestra. La chiarezza espressiva ascoltata in
tutti i quattro movimenti è emersa in modo
evidente. Chung riesce, con un gesto discreto ma
efficace, a implementare un rapporto volumetrico
tra le diverse sezioni orchestrali molto
equilibrato, ben miscelate le timbriche e prive
di ogni prevaricazione le sezioni di maggiore
potenza sonora. La qualità superlativa della
compagine è emersa attraverso il lavoro di
cesello dei colori, delle dinamiche nei giusti
tempi scelti dal direttore. Un successo
strepitoso in un teatro straripante di
appassionati e con moltissimi giovani. Uscite
continue in palcoscenico per il grande direttore
che ha preteso gli applausi per ogni sezione
strumentale e per le importanti parti solistiche.
Memorabile!
eseguito con vellutata pregnanza coloristica.
Dopo il breve intervallo la corposa Settima
Sinfonia di Bruckner è stata esaltata dalla
direzione di Chung e dai colori della splendida
orchestra. La chiarezza espressiva ascoltata in
tutti i quattro movimenti è emersa in modo
evidente. Chung riesce, con un gesto discreto ma
efficace, a implementare un rapporto volumetrico
tra le diverse sezioni orchestrali molto
equilibrato, ben miscelate le timbriche e prive
di ogni prevaricazione le sezioni di maggiore
potenza sonora. La qualità superlativa della
compagine è emersa attraverso il lavoro di
cesello dei colori, delle dinamiche nei giusti
tempi scelti dal direttore. Un successo
strepitoso in un teatro straripante di
appassionati e con moltissimi giovani. Uscite
continue in palcoscenico per il grande direttore
che ha preteso gli applausi per ogni sezione
strumentale e per le importanti parti solistiche.
Memorabile!
22 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
A NOVARA LA STAGIONE
LIRICA 2024
INAUGURATA DALLA BUTTERFLY
Quasi
inevitabilmente la stagione lirica 2024 del
Teatro Coccia di Novara si è aperta con un
omaggio al centenario della morte di Giacomo
Puccini, con quell’opera che, dopo il clamoroso
‘tonfo’ della prima alla Scala nel 1904, era
destinata a diventare uno dei suoi capolavori
più amati e popolari: Madame Butterfly. A titoli
pucciniani è poi destinata circa metà della
programmazione di questa stagione del Coccia.
Alla terza ed ultima rappresentazione di questa
Butterfly, abbiamo assistito ieri, domenica
21/01 (cast principale). Produzione esclusiva
del Teatro Coccia, la rappresentazione riprende,
con qualche modifica, l’allestimento del 2017,
con il medesimo regista, il novarese Renato
Bonajuto e la medesima sceneggiatrice, Laura
Marocchino. Come già nel 2017, il palcoscenico
del Coccia, privato del sipario, viene
trasformato
 in
una ‘scatola’ a pareti scorrevoli, con una sorta
di velario, sul lato rivolto alla platea, che si
abbassa o si alza, a seconda che la ‘scatola’ si
chiuda o debba restare aperta, come avviene,
ovviamente, per gran parte dello spettacolo.
Rispetto al precedente allestimento la regia ha
voluto aggiungere un giardino Zen, fatto di
pochi, essenziali elementi, un luogo di serena
meditazione e di pace, quella felicità cui Cio-cio-san,
come gran parte dei personaggi pucciniani,
agogna, senza poterla realizzare, con
inevitabile esito tragico. Ma la vera,
spettacolare novità della nuova messa in scena
di questa Butterfly 2024 sta nella decorazione e
nei costumi. Le pareti in legno e carta di riso
della scatola-casa vengono presentate, in questa
occasione, decorati da dipinti, eseguiti a mano
dalle maestranze specializzate del Coccia, con
terre particolari compattate e spalmate con
colla di coniglio (?) e raffigurano rami di
ciliegio e ideogrammi finemente stilizzati; i
costumi, cui si è dedicato quel raffinato esteta
che risponde al nome dello stilista parmigiano
Artemio Cabassi, sono una meraviglia tale, che
Cabassi si è sentito in dovere di presentarla al
pubblico prima dello spettacolo: i kimono e gli
obi ( le cinture tipiche legate ai kimono) che
indossano i personaggi “giapponesi” sono
originali, uno di essi addirittura confezionato
più di un secolo fa, fabbricati in Giappone (cui
immaginiamo debbano essere restituiti) con sete
di qualità speciale e dai colori raffinatissimi:
il kimono con cui entra in scena nel primo atto
Butterfly è bianco e rosso, sia perché il rosso,
ha spiegato Cabassi, è in Giappone il colore
degli abiti matrimoniali femminili, sia perché,
immaginiamo noi, il contrasto tra bianco e rosso
simboleggia il contrasto tra la Cio-cio-san
candida e ingenua sposa-bambina all’inizio della
vicenda, e la Cio-cio-san tragica figura
femminile che alla fine si squarcia il ventre
con un pugnale, travolta dalla disperazione e
dal crollo di tutti i suoi sogni di felicità
familiare e coniugale. Se a tutto questo
abbagliante apparato di bellezza aggiungiamo il
magico gioco di luci del sempre bravissimo
tecnico dell’illuminazione Ivan Pastrovicchio,
capace di ricreare notturni di straordinaria
suggestione, in
una ‘scatola’ a pareti scorrevoli, con una sorta
di velario, sul lato rivolto alla platea, che si
abbassa o si alza, a seconda che la ‘scatola’ si
chiuda o debba restare aperta, come avviene,
ovviamente, per gran parte dello spettacolo.
Rispetto al precedente allestimento la regia ha
voluto aggiungere un giardino Zen, fatto di
pochi, essenziali elementi, un luogo di serena
meditazione e di pace, quella felicità cui Cio-cio-san,
come gran parte dei personaggi pucciniani,
agogna, senza poterla realizzare, con
inevitabile esito tragico. Ma la vera,
spettacolare novità della nuova messa in scena
di questa Butterfly 2024 sta nella decorazione e
nei costumi. Le pareti in legno e carta di riso
della scatola-casa vengono presentate, in questa
occasione, decorati da dipinti, eseguiti a mano
dalle maestranze specializzate del Coccia, con
terre particolari compattate e spalmate con
colla di coniglio (?) e raffigurano rami di
ciliegio e ideogrammi finemente stilizzati; i
costumi, cui si è dedicato quel raffinato esteta
che risponde al nome dello stilista parmigiano
Artemio Cabassi, sono una meraviglia tale, che
Cabassi si è sentito in dovere di presentarla al
pubblico prima dello spettacolo: i kimono e gli
obi ( le cinture tipiche legate ai kimono) che
indossano i personaggi “giapponesi” sono
originali, uno di essi addirittura confezionato
più di un secolo fa, fabbricati in Giappone (cui
immaginiamo debbano essere restituiti) con sete
di qualità speciale e dai colori raffinatissimi:
il kimono con cui entra in scena nel primo atto
Butterfly è bianco e rosso, sia perché il rosso,
ha spiegato Cabassi, è in Giappone il colore
degli abiti matrimoniali femminili, sia perché,
immaginiamo noi, il contrasto tra bianco e rosso
simboleggia il contrasto tra la Cio-cio-san
candida e ingenua sposa-bambina all’inizio della
vicenda, e la Cio-cio-san tragica figura
femminile che alla fine si squarcia il ventre
con un pugnale, travolta dalla disperazione e
dal crollo di tutti i suoi sogni di felicità
familiare e coniugale. Se a tutto questo
abbagliante apparato di bellezza aggiungiamo il
magico gioco di luci del sempre bravissimo
tecnico dell’illuminazione Ivan Pastrovicchio,
capace di ricreare notturni di straordinaria
suggestione,
 possiamo
ben dire che se” l’occhio vuole la sua parte”,
ebbene, con questa Butterfly l’ha avuta a
sazietà. L’hanno avuta anche le orecchie? Qui il
discorso deve farsi necessariamente più cauto e
articolato. L’orchestra, la solida e collaudata
Filarmonica italiana era per l’occasione diretta
dallo spagnolo José Miguel Pérez Sierra, che
vanta una buona conoscenza della partitura, che
tuttavia, per dolorosi motivi personali che non
staremo qui a riferire, non eseguiva da ben
dieci anni. Di Pérez Siérra va elogiata la cura
sempre precisa del dettaglio timbrico e dinamico
di questa meraviglia pucciniana, una scelta dei
tempi perfettamente calibrata al servizio del
flusso sempre mutevole e cangiante dei
sentimenti dei vari personaggi, che il direttore
spagnolo scolpisce in musica con efficacia e
intenso coinvolgimento emotivo. Trasparenza e
duttilità, dunque, i meriti principali di questa
‘direzione spagnola’ Tuttavia abbiamo più volte
avuto l’impressione che il suono dell’orchestra
non aiutasse i cantanti, coprendo le loro voci;
poiché sappiamo per esperienza che questa
percezione può dipendere da particolari
condizioni dell’acustica ambientale, sospendiamo
il giudizio su questo aspetto della direzione di
Pérez Sierra: certo la scelta, che proprio non
abbiamo capito, di dislocare le batterie nei due
palchi del primo ordine più vicini al
palcoscenico (per intenderci, più o meno dove
nel classico teatro settecentesco sono le ‘barcacce’),
potenziando notevolmente l’effetto sonoro degli
strumenti più fragorosi dell’orchestra, non ha
giovato ai rapporti tra buca e palcoscenico.
Veniamo alle voci. Anche le poltroncine della
platea sanno che la Butterfly dipende,
musicalmente e drammaturgicamente parlando, da
lei, dal primo soprano, dalla cantante che
interpreta Cio-cio-san Butterfly. In questa
rappresentazione novarese il compito è toccato a
Francesca Sassu, giovane, ma con alle spalle una
già solida esperienza in teatri prestigiosi, tra
cui La Scala. La Sassu è un tipico soprano
lirico, dotata di uno strumento vocale morbido e
caldo, valida nei mezzi toni ma a nostro avviso,
nel ruolo di Butterfly , che ci pare debuttasse
qui a Novara ( purtroppo i libretti di sala del
Coccia ultimamente hanno cancellato la preziosa
sezione riguardante gli interpreti) ha mostrato
alcuni limiti: una certa possiamo
ben dire che se” l’occhio vuole la sua parte”,
ebbene, con questa Butterfly l’ha avuta a
sazietà. L’hanno avuta anche le orecchie? Qui il
discorso deve farsi necessariamente più cauto e
articolato. L’orchestra, la solida e collaudata
Filarmonica italiana era per l’occasione diretta
dallo spagnolo José Miguel Pérez Sierra, che
vanta una buona conoscenza della partitura, che
tuttavia, per dolorosi motivi personali che non
staremo qui a riferire, non eseguiva da ben
dieci anni. Di Pérez Siérra va elogiata la cura
sempre precisa del dettaglio timbrico e dinamico
di questa meraviglia pucciniana, una scelta dei
tempi perfettamente calibrata al servizio del
flusso sempre mutevole e cangiante dei
sentimenti dei vari personaggi, che il direttore
spagnolo scolpisce in musica con efficacia e
intenso coinvolgimento emotivo. Trasparenza e
duttilità, dunque, i meriti principali di questa
‘direzione spagnola’ Tuttavia abbiamo più volte
avuto l’impressione che il suono dell’orchestra
non aiutasse i cantanti, coprendo le loro voci;
poiché sappiamo per esperienza che questa
percezione può dipendere da particolari
condizioni dell’acustica ambientale, sospendiamo
il giudizio su questo aspetto della direzione di
Pérez Sierra: certo la scelta, che proprio non
abbiamo capito, di dislocare le batterie nei due
palchi del primo ordine più vicini al
palcoscenico (per intenderci, più o meno dove
nel classico teatro settecentesco sono le ‘barcacce’),
potenziando notevolmente l’effetto sonoro degli
strumenti più fragorosi dell’orchestra, non ha
giovato ai rapporti tra buca e palcoscenico.
Veniamo alle voci. Anche le poltroncine della
platea sanno che la Butterfly dipende,
musicalmente e drammaturgicamente parlando, da
lei, dal primo soprano, dalla cantante che
interpreta Cio-cio-san Butterfly. In questa
rappresentazione novarese il compito è toccato a
Francesca Sassu, giovane, ma con alle spalle una
già solida esperienza in teatri prestigiosi, tra
cui La Scala. La Sassu è un tipico soprano
lirico, dotata di uno strumento vocale morbido e
caldo, valida nei mezzi toni ma a nostro avviso,
nel ruolo di Butterfly , che ci pare debuttasse
qui a Novara ( purtroppo i libretti di sala del
Coccia ultimamente hanno cancellato la preziosa
sezione riguardante gli interpreti) ha mostrato
alcuni limiti: una certa
 fragilità
nei registri medio-bassi, che in parte
comprometteva la fluidità del fraseggio e
qualche forzatura di troppo negli acuti, che non
sempre le riuscivano omogenei. Dobbiamo però
dire, a suo onore, che è venuta crescendo nel
corso dell’opera, mostrando sempre maggior
sicurezza e una più che apprezzabile capacità
interpretativa nel disegnare l’evoluzione della
personalità di Butterfly e nel dare voce alla
sua tragedia, sia nel momento della lunga attesa
del ritorno dell’immeritatamente amato
Pinkerton, sia nel precipitare del dramma
finale. Abbastanza convincente la sua aria più
celebre, “Un bel dì vedremo”, al netto da un
esordio un po’ sporcato in acuto. L’altra
importante voce femminile, il mezzosoprano
Suzuki, interpretato da Anna Malavasi, ha
sfoggiato un bel timbro brunito e una vocalità
duttile e abbastanza fluida, con buon fraseggio,
reggendo bene la parte anche sotto il profilo
attoriale. Come già nella Bohème di dicembre,
anche in questa Butterfly secondo noi era
carente il primo tenore, nella fattispecie il
ventisettenne romano Valerio Borgioni.
Parafrasando Montale, “questo di lui oggi
possiamo dire”: non è, per ora almeno, un tenore
pucciniano: di casa nelle opere rossiniane e
donizettiane (immaginiamo del Donizetti
‘buffo’), è un tenore dotato di una vocalità di
buona proiezione, di timbro chiaro, capace di
salire ai registri acuti senza troppe difficoltà.
Del tenore pucciniano gli manca però la virtù
principale: la duttilità e la tensione lirica
dello strumento vocale, base imprescindibile per
la linea espressiva del canto. La voce di
Borgioni è all’esatto opposto una voce monocorde,
ignara di sfumature, diciamola tutta:
inespressiva. Forse non è un caso che la
tensione drammatica dell’opera sia cominciata a
crescere con la sua temporanea e prolungata
uscita di scena. Il suo contributo al duetto
d’amore che chiude il primo atto, uno dei
momenti clou dell’opera, è stato pressoché nullo.
Non aggiungiamo giudizi circa le sue capacità di
attore, anche perché Pinkerton, anche in
conseguenza delle modifiche apportate da Puccini
alla Butterfly nel 1906, è il personaggio meno
risolto e coerente fra tutti quelli creati dal
maestro lucchese, sospeso, senza nessuna
credibile motivazione, tra il volgare e
arrogante cinismo del I° Atto e le insulse e
poco credibili velleità di pentimento del III°;
e interpretare credibilmente un personaggio
fallito drammaturgicamente non è impresa di poco
conto, per nessuno. Per completare il quartetto
dei personaggi più presenti sulla scena della
Butterfly, Angelo Veccia è il baritono
interprete del ruolo di Sharpless. Di timbro
baritonale non di primissima qualità, ha però
un’ottima espansione e un fraseggio chiaro e
fluente, con sapienti mezze voci e fiati lunghi:
nel complesso una buona prova, la sua. Dei
personaggi più di contorno non possiamo dire
altro che hanno sbrigato secondo dovere le
rispettive parti: dal tenore Marco Miglietta (Goro
più che convincente), al basso Emil Abdullaiev
(lo zio Bonzo), al tenore Xiaosen Su (Yamadori),
al mezzosoprano Eleonora Filippone, la moglie
americana di Pinkerton, al basso Antonio Baratti,
l’ufficiale del registro. Un elogio speciale va
al simpatico e bravissimo bimbo quinquenne Romeo
Lunedei, figlio di Anna Malavasi, che è presente
dal secondo atto sul palcoscenico nel ruolo di
Dolore, il figlio di Butterfly e Pinkerton: per
nulla intimidito, si muove con assoluta
disinvoltura sulla scena e alla fine saluta con
la sua manina il pubblico con la consumata
eleganza dei cantanti adulti. Figlio d’arte?
Sicuramente valida la prova del coro Schola
Cantorum di s. Alberto Magno diretto dal Maestro
Alberto Sala, ottimo in tutti i registri vocali
e in piena sintonia con orchestra e cantanti.
Alla fine il pubblico, da tutto esaurito, ha
tributato un lungo applauso e ha richiamato più
volte interpreti e direttore sul palcoscenico.
Un altro successo del Coccia, un’altra tappa
della sua scalata alle prime posizioni, per
qualità e prestigio, fra i teatri di tradizione
in Italia. fragilità
nei registri medio-bassi, che in parte
comprometteva la fluidità del fraseggio e
qualche forzatura di troppo negli acuti, che non
sempre le riuscivano omogenei. Dobbiamo però
dire, a suo onore, che è venuta crescendo nel
corso dell’opera, mostrando sempre maggior
sicurezza e una più che apprezzabile capacità
interpretativa nel disegnare l’evoluzione della
personalità di Butterfly e nel dare voce alla
sua tragedia, sia nel momento della lunga attesa
del ritorno dell’immeritatamente amato
Pinkerton, sia nel precipitare del dramma
finale. Abbastanza convincente la sua aria più
celebre, “Un bel dì vedremo”, al netto da un
esordio un po’ sporcato in acuto. L’altra
importante voce femminile, il mezzosoprano
Suzuki, interpretato da Anna Malavasi, ha
sfoggiato un bel timbro brunito e una vocalità
duttile e abbastanza fluida, con buon fraseggio,
reggendo bene la parte anche sotto il profilo
attoriale. Come già nella Bohème di dicembre,
anche in questa Butterfly secondo noi era
carente il primo tenore, nella fattispecie il
ventisettenne romano Valerio Borgioni.
Parafrasando Montale, “questo di lui oggi
possiamo dire”: non è, per ora almeno, un tenore
pucciniano: di casa nelle opere rossiniane e
donizettiane (immaginiamo del Donizetti
‘buffo’), è un tenore dotato di una vocalità di
buona proiezione, di timbro chiaro, capace di
salire ai registri acuti senza troppe difficoltà.
Del tenore pucciniano gli manca però la virtù
principale: la duttilità e la tensione lirica
dello strumento vocale, base imprescindibile per
la linea espressiva del canto. La voce di
Borgioni è all’esatto opposto una voce monocorde,
ignara di sfumature, diciamola tutta:
inespressiva. Forse non è un caso che la
tensione drammatica dell’opera sia cominciata a
crescere con la sua temporanea e prolungata
uscita di scena. Il suo contributo al duetto
d’amore che chiude il primo atto, uno dei
momenti clou dell’opera, è stato pressoché nullo.
Non aggiungiamo giudizi circa le sue capacità di
attore, anche perché Pinkerton, anche in
conseguenza delle modifiche apportate da Puccini
alla Butterfly nel 1906, è il personaggio meno
risolto e coerente fra tutti quelli creati dal
maestro lucchese, sospeso, senza nessuna
credibile motivazione, tra il volgare e
arrogante cinismo del I° Atto e le insulse e
poco credibili velleità di pentimento del III°;
e interpretare credibilmente un personaggio
fallito drammaturgicamente non è impresa di poco
conto, per nessuno. Per completare il quartetto
dei personaggi più presenti sulla scena della
Butterfly, Angelo Veccia è il baritono
interprete del ruolo di Sharpless. Di timbro
baritonale non di primissima qualità, ha però
un’ottima espansione e un fraseggio chiaro e
fluente, con sapienti mezze voci e fiati lunghi:
nel complesso una buona prova, la sua. Dei
personaggi più di contorno non possiamo dire
altro che hanno sbrigato secondo dovere le
rispettive parti: dal tenore Marco Miglietta (Goro
più che convincente), al basso Emil Abdullaiev
(lo zio Bonzo), al tenore Xiaosen Su (Yamadori),
al mezzosoprano Eleonora Filippone, la moglie
americana di Pinkerton, al basso Antonio Baratti,
l’ufficiale del registro. Un elogio speciale va
al simpatico e bravissimo bimbo quinquenne Romeo
Lunedei, figlio di Anna Malavasi, che è presente
dal secondo atto sul palcoscenico nel ruolo di
Dolore, il figlio di Butterfly e Pinkerton: per
nulla intimidito, si muove con assoluta
disinvoltura sulla scena e alla fine saluta con
la sua manina il pubblico con la consumata
eleganza dei cantanti adulti. Figlio d’arte?
Sicuramente valida la prova del coro Schola
Cantorum di s. Alberto Magno diretto dal Maestro
Alberto Sala, ottimo in tutti i registri vocali
e in piena sintonia con orchestra e cantanti.
Alla fine il pubblico, da tutto esaurito, ha
tributato un lungo applauso e ha richiamato più
volte interpreti e direttore sul palcoscenico.
Un altro successo del Coccia, un’altra tappa
della sua scalata alle prime posizioni, per
qualità e prestigio, fra i teatri di tradizione
in Italia.
22 gennaio 2024 Bruno Busca
Evgeny Kissin incanta il
pubblico del Conservatorio milanese
Il
“Concerto per Antonio”, dedicato ad Antonio
Mormone, fondatore della "Fondazione La
Societa dei Concerti" e scopritore di
talenti, ha avuto come protagonista in Sala
Verdi il cinquantaduenne moscovita Evgeny Kissin,
celebrità del pianismo mondiale che venne
introdotto nel circuito concertistico milanese
da Mormone quando era ancora una giovane
promessa. Ieri nel tardo pomeriggio, in una Sala
al completo, il pianista ha presentato un
impaginato vario con
 quattro
autori classici quali Beethoven, Chopin Brahms e
Prokofiev. Brani celebri che Kissin ha
restituito con il suo linguaggio interpretativo
fortemente interiorizzato, giocato su una
chiarezza coloristica esemplare, con andature
moderate e riflessive atte ad evidenziare la
componente strutturale delle composizioni. Ha
iniziato dalla Sonata n.27 in mi minore op.90
di Beethoven quella in due ampi movimenti
espressi elegantemente, con suono scavato,
tornito, evidenziando la melodicità del molto
cantabile finale. Anche in Chopin, con il
Notturno in fa diesis minore op.48 n.2 e con
la più ampia Fantasia in fa minore op.49,
Kissin ha mostrato il suo modo razionale di
mediare il romanticismo del polacco. Uno Chopin
troppo perfetto, per nulla estemporaneo e in
linea con il suo approccio stilistico alla
ricerca dell'equilibrio geometrico. Dopo
l'intervallo le Quattro Ballate op.10 di
Brahms hanno rivelato un compositore che
anticipa il tempo futuro. La raffinata capacità
costruttiva di Kissin, controllata razionalmente
e indubbiamente coerente con la sua cifra
interpretativa, ha evidenziato molto bene almeno
le prime tre ballate, l'Andante in re minore,
l'Andante in re maggiore e l'Intermezzo
in si minore. In esse il senso unitario dei
brani e la geometria musicale con forte
personalizzazione è stata perfetta. La n.4, l'Andante
con moto in si maggiore, ha mostrato nella
parte centrale una forte dilatazione che ha
fatto perdere probabilmente il senso unitario
del lavoro ma che rappresenta un momento di
infinita riflessione. quattro
autori classici quali Beethoven, Chopin Brahms e
Prokofiev. Brani celebri che Kissin ha
restituito con il suo linguaggio interpretativo
fortemente interiorizzato, giocato su una
chiarezza coloristica esemplare, con andature
moderate e riflessive atte ad evidenziare la
componente strutturale delle composizioni. Ha
iniziato dalla Sonata n.27 in mi minore op.90
di Beethoven quella in due ampi movimenti
espressi elegantemente, con suono scavato,
tornito, evidenziando la melodicità del molto
cantabile finale. Anche in Chopin, con il
Notturno in fa diesis minore op.48 n.2 e con
la più ampia Fantasia in fa minore op.49,
Kissin ha mostrato il suo modo razionale di
mediare il romanticismo del polacco. Uno Chopin
troppo perfetto, per nulla estemporaneo e in
linea con il suo approccio stilistico alla
ricerca dell'equilibrio geometrico. Dopo
l'intervallo le Quattro Ballate op.10 di
Brahms hanno rivelato un compositore che
anticipa il tempo futuro. La raffinata capacità
costruttiva di Kissin, controllata razionalmente
e indubbiamente coerente con la sua cifra
interpretativa, ha evidenziato molto bene almeno
le prime tre ballate, l'Andante in re minore,
l'Andante in re maggiore e l'Intermezzo
in si minore. In esse il senso unitario dei
brani e la geometria musicale con forte
personalizzazione è stata perfetta. La n.4, l'Andante
con moto in si maggiore, ha mostrato nella
parte centrale una forte dilatazione che ha
fatto perdere probabilmente il senso unitario
del lavoro ma che rappresenta un momento di
infinita riflessione.
 Con
l'interpretazione del brano finale, la Sonata
n.2 in re minore op.14 di Segej Prokofiev,
Kissin ha rivelato la sua più autentica affinità
con il grande compositore della sua terra. Un'
esecuzione di raro spessore espressivo nei
quattro movimenti che compongono la
straordinaria sonata novecentesca, ricca di
rapporti geometrici tra gli elementi che la
costituiscono. Perfetti i tempi esecutivi, e
articolate le dinamiche dei rispettivi movimenti
per un'interpretazione complessiva esemplare. Il
fortunato pubblico presente in Conservatorio,
mediamente più giovane del solito, entusiasta,
ha espresso applausi interminabili. Tre i brevi
bis concessi partendo da Chopin con la
Mazurka op.67 n.4, passando per Prokofiev
con la Marcia da L'Amore delle tre
melarance, e concludendo con il noto
Walzer op.39 n.15 di Brahms. Standing
ovation per Kissin visibilmente soddisfatto
e autografi conclusivi nel foyer di Sala Verdi.
Straordinario! Con
l'interpretazione del brano finale, la Sonata
n.2 in re minore op.14 di Segej Prokofiev,
Kissin ha rivelato la sua più autentica affinità
con il grande compositore della sua terra. Un'
esecuzione di raro spessore espressivo nei
quattro movimenti che compongono la
straordinaria sonata novecentesca, ricca di
rapporti geometrici tra gli elementi che la
costituiscono. Perfetti i tempi esecutivi, e
articolate le dinamiche dei rispettivi movimenti
per un'interpretazione complessiva esemplare. Il
fortunato pubblico presente in Conservatorio,
mediamente più giovane del solito, entusiasta,
ha espresso applausi interminabili. Tre i brevi
bis concessi partendo da Chopin con la
Mazurka op.67 n.4, passando per Prokofiev
con la Marcia da L'Amore delle tre
melarance, e concludendo con il noto
Walzer op.39 n.15 di Brahms. Standing
ovation per Kissin visibilmente soddisfatto
e autografi conclusivi nel foyer di Sala Verdi.
Straordinario!
21 gennaio
2024 Cesare
Guzzardella
Seconda edizione del
Premio di
Composizione "Costruttori di Armonie" al
Conservatorio milanese
Ieri
sera in Sala Puccini si è svolta al
Conservatorio milanese la finale del Concorso
Internazionale di Composizione "Costruttori di
Armonie", organizzato da Serate Musicali
con il sostegno della famiglia Lodigiani. La
serata è stata presentata
 da
Luca Schieppati, organizzatore musicale e
pianista. Il Concorso è dedicato a Giuseppe
Lodigiani (1918-2004), ingegnere ed importante
costruttore, con grande passioni per le arti e
soprattutto per la musica, ed è sostenuto dalla
famiglia. Siamo giunti alla seconda edizione
dedicata quest'anno al violino. Una
giuria presieduta da Fulvio Luciani, violinista,
dai compositori Carlo Galante e Giorgio Colombo da
Luca Schieppati, organizzatore musicale e
pianista. Il Concorso è dedicato a Giuseppe
Lodigiani (1918-2004), ingegnere ed importante
costruttore, con grande passioni per le arti e
soprattutto per la musica, ed è sostenuto dalla
famiglia. Siamo giunti alla seconda edizione
dedicata quest'anno al violino. Una
giuria presieduta da Fulvio Luciani, violinista,
dai compositori Carlo Galante e Giorgio Colombo
 Taccani
e dai violinisti Maria Ronchini e Piercarlo
Sacco, hanno valutato i quattro brani finalisti:
di Giorgio Dalla Villa "Mit innigster
Empfindung" per violino e pianoforte;
dell'iraniano Sina Jafarikia "Apan Napat"
per violino solo; del sud-coreano Jee Seo "On
Fever II" per violino solo; del giapponese
Hisataka Nishimori "Souten no Raika" (
Lightning in the Azure) per violino e
pianoforte. I brani sono stati eseguiti con
efficace espressività dal violinista Francesco
Melis e dalla pianista Eunmi Taccani
e dai violinisti Maria Ronchini e Piercarlo
Sacco, hanno valutato i quattro brani finalisti:
di Giorgio Dalla Villa "Mit innigster
Empfindung" per violino e pianoforte;
dell'iraniano Sina Jafarikia "Apan Napat"
per violino solo; del sud-coreano Jee Seo "On
Fever II" per violino solo; del giapponese
Hisataka Nishimori "Souten no Raika" (
Lightning in the Azure) per violino e
pianoforte. I brani sono stati eseguiti con
efficace espressività dal violinista Francesco
Melis e dalla pianista Eunmi
 Park.
Presentati da Luca Schieppati con dovizia di
dettaglio, i lavori erano tutti di rilievo
compositivo, differenti per stile e resa
estetica, ed hanno messo in risalto le ottime
qualità costruttive dei compositori, ben
sottolineate dalle accurate interpretazioni del
violinista e della pianista . Al termine delle
esecuzioni, alla presenza in sala di molti
appassionati, la giuria ha attribuito il Primo
Premio al sud-coreano Jee Seo per la sua ritmica
On Fever II, brano di breve durata ma di
efficace sintesi espressiva. Secondo premio ex-equo Park.
Presentati da Luca Schieppati con dovizia di
dettaglio, i lavori erano tutti di rilievo
compositivo, differenti per stile e resa
estetica, ed hanno messo in risalto le ottime
qualità costruttive dei compositori, ben
sottolineate dalle accurate interpretazioni del
violinista e della pianista . Al termine delle
esecuzioni, alla presenza in sala di molti
appassionati, la giuria ha attribuito il Primo
Premio al sud-coreano Jee Seo per la sua ritmica
On Fever II, brano di breve durata ma di
efficace sintesi espressiva. Secondo premio ex-equo
 assegnato
all'italiano Giorgio Dalla Villa e al giapponese
Hisataka Nishimori, per due lavori di ottima
fattura e di limpida resa costruttiva.
Segnaliamo anche il premio del pubblico
assegnato al giapponese Hisataka Nishimori per
Souten no Raika. Dalla Villa e Nishimori,
presenti in sala, insieme agli interpreti, la
giuria, Laca Schieppati e la famiglia Lodigiani,
sono saliti in palcoscenico per gli applausi
finali. Il prossimo anno "Costruttori di Armonie"
sarà dedicato al pianoforte. Una iniziativa
importante, in collaborazione con il
Conservatorio milanese "G.Verdi", che ha lo
scopo di promuovere la musica contemporanea e i
nuovi modi d'interpretarla. assegnato
all'italiano Giorgio Dalla Villa e al giapponese
Hisataka Nishimori, per due lavori di ottima
fattura e di limpida resa costruttiva.
Segnaliamo anche il premio del pubblico
assegnato al giapponese Hisataka Nishimori per
Souten no Raika. Dalla Villa e Nishimori,
presenti in sala, insieme agli interpreti, la
giuria, Laca Schieppati e la famiglia Lodigiani,
sono saliti in palcoscenico per gli applausi
finali. Il prossimo anno "Costruttori di Armonie"
sarà dedicato al pianoforte. Una iniziativa
importante, in collaborazione con il
Conservatorio milanese "G.Verdi", che ha lo
scopo di promuovere la musica contemporanea e i
nuovi modi d'interpretarla.
20 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
La Missa Brevis
di Benjamin Britten e non solo al Museo
del Novecento milanese
Un pomeriggio particolarmente
interessante quello organizzato nella Sala
Fontana del Museo del Noivecento milanese
dalla Rete Culturale Cantosospeso, in
collaborazione con la Rede Cultural Luther
King con la partecipazione del Coro
Didone formato da Sira Milani - Soprano,
Woojin Kim - Soprano, Giulia Taccagni
–
Contralto, Davide Rocca - Baritono
e in aggiunta Gledis Gjuzi
–
pianoforte, Andrea Grossi -
contrabbasso e pianoforte , tutti diretti da
Tais Conte Renzetti. Il
programma assai vario denominato
 "CANTI
DI PACE IN TEMPI DI GUERRA" aveva come polo
centrale la Missa Brevis di
Benjamin Britten, brano liturgico adattato per
l'occasione agli spazi luminosi della
panoramica Sala Fontana.
Non solo Britten però, anche una serie di brani
cameristici di György Kurtág, di Andrea Grossi,
di Shervin Hajipour, di Maurice Ravel, di Richie
Beirach, di Gilberto Mendes e un Canto
Tradizionale Índios Kanamari del Brasile. Tutti
i brani sono stati eseguiti all'interno di un
percorso preciso ottimamente costruito che ha
visto alternarsi lavori cameristici a brani
corali. L'eccellente interpretazione della
Missa Brevis "CANTI
DI PACE IN TEMPI DI GUERRA" aveva come polo
centrale la Missa Brevis di
Benjamin Britten, brano liturgico adattato per
l'occasione agli spazi luminosi della
panoramica Sala Fontana.
Non solo Britten però, anche una serie di brani
cameristici di György Kurtág, di Andrea Grossi,
di Shervin Hajipour, di Maurice Ravel, di Richie
Beirach, di Gilberto Mendes e un Canto
Tradizionale Índios Kanamari del Brasile. Tutti
i brani sono stati eseguiti all'interno di un
percorso preciso ottimamente costruito che ha
visto alternarsi lavori cameristici a brani
corali. L'eccellente interpretazione della
Missa Brevis dell'inglese Benjamin Britten trascritta per
voci, coro, pianoforte e contrabbasso
dall'originale per voci, coro e organo, è stata
diretta molto bene da Tais Conte Renzetti con la
precisa esternazione del Coro Didone, la
partecipazione del baritono Davide Rocca, voce
pregnante ed incisiva, e le armonizzazioni della
pianista Gledis Zjusi e del contrabbassista
Andrea Grossi. Tra gli altri brani segnaliamo
almeno l'espressivo brano Baraje di
Shervin Hajipour con l'intensa voce del
contralto Giulia Taccagni sostenuta dal
contrabbasso di Andrea Grossi. Di rilievo
Wahanararai, canto tradizionale Indios
Kanamari del Brasile inserito benissimo in un
contesto ambientale con suoni di uccelli ed
dell'inglese Benjamin Britten trascritta per
voci, coro, pianoforte e contrabbasso
dall'originale per voci, coro e organo, è stata
diretta molto bene da Tais Conte Renzetti con la
precisa esternazione del Coro Didone, la
partecipazione del baritono Davide Rocca, voce
pregnante ed incisiva, e le armonizzazioni della
pianista Gledis Zjusi e del contrabbassista
Andrea Grossi. Tra gli altri brani segnaliamo
almeno l'espressivo brano Baraje di
Shervin Hajipour con l'intensa voce del
contralto Giulia Taccagni sostenuta dal
contrabbasso di Andrea Grossi. Di rilievo
Wahanararai, canto tradizionale Indios
Kanamari del Brasile inserito benissimo in un
contesto ambientale con suoni di uccelli ed
 effetti
naturali; d'intensa incisività Kaddish di
Maurice Ravel con la voce baritonale di Rocca e
con la Zjusi al pianoforte; particolarmente
espressivo il brano jazz Elm di Richie
Beirach nella versione per pianoforte e
contrabbasso con la Zjusi e Grossi. Di
ispirazione anche gestuale l'iniziale brano per
pianoforte a quattro mano di Andrea Grossi,
valido nella sua semplicità. Un pomeriggio di
qualità introdotto da Paola Bonara del Coro
Polifonico Cantosospeso e terminato con la
reinterpretazione del bellissimo Vila Socó
Meu Amor di Gilberto Mendes. Successo e
fragorosi applausi nella Sala Fontana colma di
pubblico. effetti
naturali; d'intensa incisività Kaddish di
Maurice Ravel con la voce baritonale di Rocca e
con la Zjusi al pianoforte; particolarmente
espressivo il brano jazz Elm di Richie
Beirach nella versione per pianoforte e
contrabbasso con la Zjusi e Grossi. Di
ispirazione anche gestuale l'iniziale brano per
pianoforte a quattro mano di Andrea Grossi,
valido nella sua semplicità. Un pomeriggio di
qualità introdotto da Paola Bonara del Coro
Polifonico Cantosospeso e terminato con la
reinterpretazione del bellissimo Vila Socó
Meu Amor di Gilberto Mendes. Successo e
fragorosi applausi nella Sala Fontana colma di
pubblico.
20 gennaio 2024
CesareGuzzardella
Julian Rachlin
e Sarah McElravy al
Dal Verme con I Pomeriggi Musicali
Un
programma tutto mozartiano ha accolto l'Orchestra
I Pomeriggi Musicali e il
direttore-violinista Julian Rachlin. Da molti
anni Rachlin ottiene meritati successi nelle
sale da concerto internazionali. A Milano torna
spesso e questa mattina, nell'anteprima del Dal
Verme un folto pubblico con anche
 centinaia
di studenti provenienti dalle scuole secondarie
milanesi, ha avuto l'opportunità di ascoltare la
Sinfonia dalle Nozze di Figaro, la
Sinfonia Concertante per violino, viola e
Orchestra K 364 e la Sinfonia n.40 in sol
minore K 550, quella che inizia con il
celebre Molto allegro che tutti conoscono.
Rachlin, solo direttore nei brani laterali, ha
trovato l'appoggio solistico al suo violino
dalla violista Sarah McElravy nella stupenda
Sinfonia Concertante. L'impatto musicale del
primo noto lavoro iniziale, ottimamente diretto
da Rachlin, ha visto un seguito ancora più
efficace nella K centinaia
di studenti provenienti dalle scuole secondarie
milanesi, ha avuto l'opportunità di ascoltare la
Sinfonia dalle Nozze di Figaro, la
Sinfonia Concertante per violino, viola e
Orchestra K 364 e la Sinfonia n.40 in sol
minore K 550, quella che inizia con il
celebre Molto allegro che tutti conoscono.
Rachlin, solo direttore nei brani laterali, ha
trovato l'appoggio solistico al suo violino
dalla violista Sarah McElravy nella stupenda
Sinfonia Concertante. L'impatto musicale del
primo noto lavoro iniziale, ottimamente diretto
da Rachlin, ha visto un seguito ancora più
efficace nella K 364, grazie al riuscito dialogo tra i due
protagonisti, l'ottimo violino di Rachlin e la
pregnante e voluminosa viola della McElravy,
un'interprete raffinata, precisa che anche nelle
bellissime cadenze del concerto ha
restituito con discorsività leggera e grintosa,
insieme al compagno, la genialità mozartiana. Un
concerto in corpose tre parti -Allegro
maestoso, Andante e Presto - che è
piaciuto moltissimo al pubblico presente in sala
e che ha entusiasmato gli stessi solisti
visibilmente soddisfatti. Dapo il breve
intervallo, valida l'esecuzione della K 550,
con ancora una notevole resa dei bravissimi
orchestrali de I Pomeriggi. Questa sera
alle 20.00 la prima ufficiale e sabato alle
17.00 la replica. Da non perdere.
364, grazie al riuscito dialogo tra i due
protagonisti, l'ottimo violino di Rachlin e la
pregnante e voluminosa viola della McElravy,
un'interprete raffinata, precisa che anche nelle
bellissime cadenze del concerto ha
restituito con discorsività leggera e grintosa,
insieme al compagno, la genialità mozartiana. Un
concerto in corpose tre parti -Allegro
maestoso, Andante e Presto - che è
piaciuto moltissimo al pubblico presente in sala
e che ha entusiasmato gli stessi solisti
visibilmente soddisfatti. Dapo il breve
intervallo, valida l'esecuzione della K 550,
con ancora una notevole resa dei bravissimi
orchestrali de I Pomeriggi. Questa sera
alle 20.00 la prima ufficiale e sabato alle
17.00 la replica. Da non perdere.
18 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
Un doppio concerto
per la Fondazione la
Società dei Concerti in Conservatorio
Nella giornata di ieri la
Società dei Concerti ha organizzato un
doppio appuntamento musicale in Sala Verdi: nel
pomeriggio per la "Serie Zaffiro" la pianista
Costanza Principe e il Quartetto Goldberg hanno
proposto un tutto Schumann; alla sera, per la "Serie
Rubino", un duo statunitense formato dal
violinista Randall Goosby e dal pianista Zhu
Wang hanno interpretato un programma tra Europa
e America con musicisti di raro ascolto come S.
Coleridge-Taylor,
 W.Grant
Still e F.Price e con autori noti quali A. Dvo W.Grant
Still e F.Price e con autori noti quali A. Dvo řák
e R.Strauss. L'ottima pianista Costanza Principe
ha un debole per Robert Schumann e una profonda
immedesimazione quando lo esegue. La Sonata
n. 3 op. 14, detta anche “Concerto senza
orchestra” (versione 1836) ha introdotto il
pomeriggio musicale. Alta valenza espressiva per
la Principe che ha rivelato idee interpretative
molto chiare sul compositore tedesco. Tra i
brani più complessi da eseguire per il complesso
intreccio melodico e armonico, questa sonata e
forse tra i brani meno frequentati. Un
capolavoro che ha visto un' interiorizzazione
completa della giovane pianista ed una
restituzione chiara e dettagliata,
 con
una limpidezza strutturale assai rara nella sua
sintesi discorsiva ben delineata. La giovane
interprete ha trovato poi, nell'altrettanto
stupendo Quintetto per pianoforte e archi in
mi bem. maggiore op. 44, il quartetto
d'archi Goldberg come compagni. Un gruppo
cameristico certamente di alta qualità, in
perfetta sinergia con la parte pianistica.
L'ottimo equilibrio tra i violini di Jingzhi
Zhang e Giacomo Lucato, la viola di Matilde
Simionato e il violoncello di Martino Simionato,
con le valide armonizzazioni della pianista, ha
portato ad una resa estetica equilibrata tra le
parti e soprattutto di grande espressività in
ogni movimento. Applausi calorosissimi agli
interpreti dal numeroso pubblico intervenuto in
Sala Verdi. Il concerto della sera ha
rappresentato una doppia novità: poco conosciuti
erano gli eccellenti interpreti e altrettanto
poco conosciuti molti dei compositori inseriti
nel diversificato e originale impaginato. La
componente "americana" ascoltata, con influenze
di spirituals e blues, l'abbiamo ritrovata in
ben quattro compositori. con
una limpidezza strutturale assai rara nella sua
sintesi discorsiva ben delineata. La giovane
interprete ha trovato poi, nell'altrettanto
stupendo Quintetto per pianoforte e archi in
mi bem. maggiore op. 44, il quartetto
d'archi Goldberg come compagni. Un gruppo
cameristico certamente di alta qualità, in
perfetta sinergia con la parte pianistica.
L'ottimo equilibrio tra i violini di Jingzhi
Zhang e Giacomo Lucato, la viola di Matilde
Simionato e il violoncello di Martino Simionato,
con le valide armonizzazioni della pianista, ha
portato ad una resa estetica equilibrata tra le
parti e soprattutto di grande espressività in
ogni movimento. Applausi calorosissimi agli
interpreti dal numeroso pubblico intervenuto in
Sala Verdi. Il concerto della sera ha
rappresentato una doppia novità: poco conosciuti
erano gli eccellenti interpreti e altrettanto
poco conosciuti molti dei compositori inseriti
nel diversificato e originale impaginato. La
componente "americana" ascoltata, con influenze
di spirituals e blues, l'abbiamo ritrovata in
ben quattro compositori.
 L'inglese
Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) duranti i
suoi soggiorni negli Stati Uniti assimilò quel
mondo musicale producendo brani melodicissimi
come la bellissima Suite per violino e
pianoforte n.3; lo statunitense W.Grant
Still (1895-1978) con la sua Suite per
violino e pianoforte ha riportato il mondo
africano e le influenze jazz nel suo lavoro
costituito di tre parti: African dancer,
Mother and Child e Gamin; la
compositrice statunitense Florence Price
(1887-1853), di origine africana, nelle sue due
Fantasie per violino e pianoforte, la
n.1 in sol minore e la n.2 in fa diesis
minore, ha trovato un modo più complesso e
virtuosistico di esprimersi facendo una sintesi
originale tra idiomi romantici europei e ritmi
indo-americani; il ceco Antonin Dvořák
è debitore della musica statunitense per via
della sua lunga permanenza oltre oceano e per
certi colori di quel mondo ibrido tra Europa ed L'inglese
Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) duranti i
suoi soggiorni negli Stati Uniti assimilò quel
mondo musicale producendo brani melodicissimi
come la bellissima Suite per violino e
pianoforte n.3; lo statunitense W.Grant
Still (1895-1978) con la sua Suite per
violino e pianoforte ha riportato il mondo
africano e le influenze jazz nel suo lavoro
costituito di tre parti: African dancer,
Mother and Child e Gamin; la
compositrice statunitense Florence Price
(1887-1853), di origine africana, nelle sue due
Fantasie per violino e pianoforte, la
n.1 in sol minore e la n.2 in fa diesis
minore, ha trovato un modo più complesso e
virtuosistico di esprimersi facendo una sintesi
originale tra idiomi romantici europei e ritmi
indo-americani; il ceco Antonin Dvořák
è debitore della musica statunitense per via
della sua lunga permanenza oltre oceano e per
certi colori di quel mondo ibrido tra Europa ed
 Africa
individuabili nella deliziosa Sonatina per
violino e pianoforte op.100. Gli eccellenti
interpreti Randoll Goosby e Zhu Wang hanno
rivelato una chiarezza espressiva di raro
ascolto in tutti i lavori, nei quali
l'equilibrio tra il melodicissimo violino con un
vibrato di pregio, e la luminosa parte
pianistica ha portato ad un' interpretazione
analitica, precisa in ogni dettaglio e molto
espressiva. Le escursioni dinamiche, con
volumetrie centellinate in minimi cambiamenti,
hanno rivelato poi la statura interpretativa del
duo. L'ultimo brano d'impaginato con la
Sonata in mi bemolle maggiore op.18 del
tedesco Richard Strauss (1864-1949) ci ha
portato in un clima tardo romantico ben diverso
con influssi wagneriani. Africa
individuabili nella deliziosa Sonatina per
violino e pianoforte op.100. Gli eccellenti
interpreti Randoll Goosby e Zhu Wang hanno
rivelato una chiarezza espressiva di raro
ascolto in tutti i lavori, nei quali
l'equilibrio tra il melodicissimo violino con un
vibrato di pregio, e la luminosa parte
pianistica ha portato ad un' interpretazione
analitica, precisa in ogni dettaglio e molto
espressiva. Le escursioni dinamiche, con
volumetrie centellinate in minimi cambiamenti,
hanno rivelato poi la statura interpretativa del
duo. L'ultimo brano d'impaginato con la
Sonata in mi bemolle maggiore op.18 del
tedesco Richard Strauss (1864-1949) ci ha
portato in un clima tardo romantico ben diverso
con influssi wagneriani. Una sonata costruita benissimo dal grande
compositore, restituita con indubbia bravura dal
duo, con la parte pianistica dominante per
armonizzazione e virtuosismo. Bravissimi!
Pubblico entusiasta e calorosi applausi al
termine. Due i bis concessi: prima il melodico
Cantabile di Niccolò Paganini e poi
Estrellita del messicano Manuel Ponce nella
celebre trascrizione di Jascha Heifetz. Entrambi
ottimi. Ricordiamo il "Concerto per Antonio"
di sabato 20 gennaio alle ore 18.00 con il
grande pianista Evgeny Kissin che eseguirà
musiche di Beethoven, Chopin. Brahms e
Prokofiev. Da non perdere.
Una sonata costruita benissimo dal grande
compositore, restituita con indubbia bravura dal
duo, con la parte pianistica dominante per
armonizzazione e virtuosismo. Bravissimi!
Pubblico entusiasta e calorosi applausi al
termine. Due i bis concessi: prima il melodico
Cantabile di Niccolò Paganini e poi
Estrellita del messicano Manuel Ponce nella
celebre trascrizione di Jascha Heifetz. Entrambi
ottimi. Ricordiamo il "Concerto per Antonio"
di sabato 20 gennaio alle ore 18.00 con il
grande pianista Evgeny Kissin che eseguirà
musiche di Beethoven, Chopin. Brahms e
Prokofiev. Da non perdere.
18 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
Gabriella Costa
e Andrea
Bacchetti alle Serate Musicali tra
Francia e America
L'interessante impaginato preparato dal soprano
Gabriella Costa e dal pianista Andrea Bacchetti
per il concerto di ieri sera, organizzato da
Serate Musicali, ruotava intorno a due grandi
città come Parigi e New York e aveva come
riferimento la nota
 compositrice,
pianista, direttrice d'orchestra e soprattutto
didatta parigina Nadia Boulanger. Molti dei
compositori in programma conobbero, ebbero come
riferimento o come insegnante la grande donna
della musica. Debussy, Faurè, Ravel, sul
versante francese e Bernstein, Gershwin, Barber
e Copland su quello americano conobbero la
Boulanger. Sono stati eseguiti brani
anche della compositrice e della sorella
minore Lili, morta giovanissima all'età di 25
anni. Bacchetti, pianista genovese noto
soprattutto per il suo ottimo Bach, è anche un
interprete versatile, aperto alla musica
contemporanea, alla "leggera" e anche al jazz.
Nel programna compositrice,
pianista, direttrice d'orchestra e soprattutto
didatta parigina Nadia Boulanger. Molti dei
compositori in programma conobbero, ebbero come
riferimento o come insegnante la grande donna
della musica. Debussy, Faurè, Ravel, sul
versante francese e Bernstein, Gershwin, Barber
e Copland su quello americano conobbero la
Boulanger. Sono stati eseguiti brani
anche della compositrice e della sorella
minore Lili, morta giovanissima all'età di 25
anni. Bacchetti, pianista genovese noto
soprattutto per il suo ottimo Bach, è anche un
interprete versatile, aperto alla musica
contemporanea, alla "leggera" e anche al jazz.
Nel programna
 ha
introdotto la parte cameristica con due brani di
Claude Debussy, tratti da Children' Corner-
Jimbo's Lullaby e The Little Shepherd-
e nella parte centrale della serata è stato
eseguito prima un Preludio di Lili
Boulanger e poi tre brani, il primo del celebre
pianista jazz Oscar Peterson, il secondo Ol'
man river di Jerome Kern e quindi
Pulcinelle di Heitor Villa-Lobos.Ottime le
interpretazioni pianistiche, curate nel
dettaglio ed esternate con tocco morbido ed
elegante. Ma è nella voce di Gabriella Costa,
ottimamente armonizzata da Bacchetti, che il
concerto ha preso la piega più importante.
Clair de lune e Chanson d'amour di
Gabriel Fauré seguite da Cinque melodie
popolari greche di Maurice Ravel ci hanno
portato nella leggerezza e dolcezza francese ben
evidenziate dal timbro penetrante, preciso e
luminoso della Costa. A seguire tre brani di
Nadia Boulanger - Cantique, ha
introdotto la parte cameristica con due brani di
Claude Debussy, tratti da Children' Corner-
Jimbo's Lullaby e The Little Shepherd-
e nella parte centrale della serata è stato
eseguito prima un Preludio di Lili
Boulanger e poi tre brani, il primo del celebre
pianista jazz Oscar Peterson, il secondo Ol'
man river di Jerome Kern e quindi
Pulcinelle di Heitor Villa-Lobos.Ottime le
interpretazioni pianistiche, curate nel
dettaglio ed esternate con tocco morbido ed
elegante. Ma è nella voce di Gabriella Costa,
ottimamente armonizzata da Bacchetti, che il
concerto ha preso la piega più importante.
Clair de lune e Chanson d'amour di
Gabriel Fauré seguite da Cinque melodie
popolari greche di Maurice Ravel ci hanno
portato nella leggerezza e dolcezza francese ben
evidenziate dal timbro penetrante, preciso e
luminoso della Costa. A seguire tre brani di
Nadia Boulanger - Cantique,
 Chanson
ed Élégie- ci hanno fatto scoprire le
qualità di un donna compositrice di grande
valore. Due brani fuori programma di Aaron
Copland, esattamente Long time ago e
Zion's Walls hanno anticipato Somewhere
e Maria di Leonard Bernstein tratte dal
celebre West Side Story; quindi The
man I love e Summertime, due
capolavori di George Gershwin e, a conclusione,
tre rarità , ma certamente validi brani di
Samuel Barber tra cui il Nocturne- Op.13 n.4.
Anche sul versante americano la voce spontanea e
precisa in tutti i registri di Gabriella Costa
si è rivelata ottima e un Bacchetti più sciolto
ha implementato la bellezza delle melodie con il
suo tocco ricco di dettagli. Due i bis concessi,
prima ancora Ol' Man River cantato
benissimo dalla Costa e poi un estemporaneo I
got rhithm di Gershwin ha concluso l'ottima
serata. Applausi calorosi meritatissimi. Chanson
ed Élégie- ci hanno fatto scoprire le
qualità di un donna compositrice di grande
valore. Due brani fuori programma di Aaron
Copland, esattamente Long time ago e
Zion's Walls hanno anticipato Somewhere
e Maria di Leonard Bernstein tratte dal
celebre West Side Story; quindi The
man I love e Summertime, due
capolavori di George Gershwin e, a conclusione,
tre rarità , ma certamente validi brani di
Samuel Barber tra cui il Nocturne- Op.13 n.4.
Anche sul versante americano la voce spontanea e
precisa in tutti i registri di Gabriella Costa
si è rivelata ottima e un Bacchetti più sciolto
ha implementato la bellezza delle melodie con il
suo tocco ricco di dettagli. Due i bis concessi,
prima ancora Ol' Man River cantato
benissimo dalla Costa e poi un estemporaneo I
got rhithm di Gershwin ha concluso l'ottima
serata. Applausi calorosi meritatissimi.
16 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
Ispirazioni
floreali per l'Inari
Duo allo Spazio Teatro 89
"Le ispirazioni floreali",
nella musica del bellissimo concerto che ha
preso il titolo - "Ci vuole un fiore" -
dalla celebre canzone di Sergio Endrigo sulle
parole di Gianni Rodari, sono state ben
evidenziate nell'impaginato studiato dal soprano
Barbara Massaro e dalla pianista Elena
Chiavegato. Allo Spazio Teatro 89 di via
Fratelli Zoia, Luca Schieppati, ottimo pianista
e instancabile organizzatore della rassegna
 musicale,
in collaborazione anche con Serate Musicali,
ha sapientemente introdotto l'originale e ben
studiato programma. Si alternava la musica di
undici compositori che hanno dedicato pagine
liederistiche, utilizzando testi di letterati
illustri come Goethe, Heine, Hugo - solo per
citarne i più noti- che riguardavano tematiche
floreali. Iniziando da Alessandro Scarlatti con
l'aria Violette, dall'opera Pirro e
Demetrio - l'unico brano estratto da un'opera,
gli altri erano tutti cameristici- si è svolto
un percorso che dalla fine del '600 ha
attraversato oltre due secoli di storia della
musica, con Mozart, Schubert, Mendelssohn,
Schumann e R.Strauss, per arrivare ad un gruppo
di francesi come Debussy, Ravel, Poulenc, Fauré,
Chabrier e nel bis, con l'unica donna presente
come compositrice, la parigina Lili Boulanger.
Nei diciassette titoli presentati i fiori erano
protagonisti - rose, papaveri, fiordalisi, lillà,
violette - e ben in sintonia con i caratteri
dolci, sentimentali e gentili delle piacevoli
melodie. La voce di soprano dell'ottima Barbara
Massaro, diplomata col massimo dei voti al
Conservatorio "G.Verdi" di Milano non solo in
canto ma anche in viola, ha trovato come
complemento il pianismo delicato e preciso di
un' altra musicale,
in collaborazione anche con Serate Musicali,
ha sapientemente introdotto l'originale e ben
studiato programma. Si alternava la musica di
undici compositori che hanno dedicato pagine
liederistiche, utilizzando testi di letterati
illustri come Goethe, Heine, Hugo - solo per
citarne i più noti- che riguardavano tematiche
floreali. Iniziando da Alessandro Scarlatti con
l'aria Violette, dall'opera Pirro e
Demetrio - l'unico brano estratto da un'opera,
gli altri erano tutti cameristici- si è svolto
un percorso che dalla fine del '600 ha
attraversato oltre due secoli di storia della
musica, con Mozart, Schubert, Mendelssohn,
Schumann e R.Strauss, per arrivare ad un gruppo
di francesi come Debussy, Ravel, Poulenc, Fauré,
Chabrier e nel bis, con l'unica donna presente
come compositrice, la parigina Lili Boulanger.
Nei diciassette titoli presentati i fiori erano
protagonisti - rose, papaveri, fiordalisi, lillà,
violette - e ben in sintonia con i caratteri
dolci, sentimentali e gentili delle piacevoli
melodie. La voce di soprano dell'ottima Barbara
Massaro, diplomata col massimo dei voti al
Conservatorio "G.Verdi" di Milano non solo in
canto ma anche in viola, ha trovato come
complemento il pianismo delicato e preciso di
un' altra
 eccellente
diplomata al prestigioso Conservatorio, Elena
Chiavegato, di madre giapponese e padre italiano.
Le due interpreti si sono presentate in
palcoscenico con due originali abiti disegnati
dallo stilista Emilio Bonadio, uno verde a
motivi floreali per la pianista e l'altro rosa,
a forma di corolla, per la cantante. Tra i brani
eseguiti, tutti di ottima resa interpretativa,
ricordiamo Il linguaggio dei fiori di
F.Schubert, La mia rosa di Robert
Schumann, I Fiordalisi e la Rosa
dell'acqua di Richard Strauss, Dei fiori
di Claude Debussy, Manto di fiori di
Maurice Ravel, Fiori di Francis Poulenc,
La farfalle e il fiore di Francis
Poulenc, Tutti i fiori di Emmanuel
Chabrier e il bis con Les lilas qui avaient
fleuri di Lili Boulanger. Un concerto che
per la bravura delle interpreti e l'originalità
della scelta musicale dovrebbe essere portato in
molte sale e diventare un "must" in una
programmazione primaverile! Il prossimo incontro
allo Spazio Teatro 89 sarà con il pianista
Daniele Martinelli per Schumann, Scriabin, Berg
e Messiaen. Da non perdere. eccellente
diplomata al prestigioso Conservatorio, Elena
Chiavegato, di madre giapponese e padre italiano.
Le due interpreti si sono presentate in
palcoscenico con due originali abiti disegnati
dallo stilista Emilio Bonadio, uno verde a
motivi floreali per la pianista e l'altro rosa,
a forma di corolla, per la cantante. Tra i brani
eseguiti, tutti di ottima resa interpretativa,
ricordiamo Il linguaggio dei fiori di
F.Schubert, La mia rosa di Robert
Schumann, I Fiordalisi e la Rosa
dell'acqua di Richard Strauss, Dei fiori
di Claude Debussy, Manto di fiori di
Maurice Ravel, Fiori di Francis Poulenc,
La farfalle e il fiore di Francis
Poulenc, Tutti i fiori di Emmanuel
Chabrier e il bis con Les lilas qui avaient
fleuri di Lili Boulanger. Un concerto che
per la bravura delle interpreti e l'originalità
della scelta musicale dovrebbe essere portato in
molte sale e diventare un "must" in una
programmazione primaverile! Il prossimo incontro
allo Spazio Teatro 89 sarà con il pianista
Daniele Martinelli per Schumann, Scriabin, Berg
e Messiaen. Da non perdere.
15 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
John Axelrod dirige la
Sinfonica di Milano in
Čaikovskij
e Stravinskij
Un
programma interamente russo ha visto il ritorno
in Auditorium del direttore texano John Axelrod.
Prima
la
Suite Lo Schiaccianoci di Čaikovskij, poi
L'oiseau de feu di Stravinskij, due
lavori legati al mondo del balletto che hanno
acquistato nel tempo autonomia
espressiva nel repertorio sinfonico di tutti i
direttori d'orchestra. La Suite op.71
del primo russo
è del 1892 ed è
suddivisa in nove parti con sei danze, una
 marcia, un celebre Valzer
dei fiori oltre all'Ouverture introduttiva. Brani
celebri che facilmente si ricordano al primo
ascolto. Altrettanto celebre L'oiseau de feu
del secondo russo; è del 1909, in diciannove
momenti perfettamente collegati per un unicum
discorsivo; ha trovato la prima esecuzione nel
1910 a Parigi. Lavoro già evoluto del primo
Novecento, rappresenta un momento di splendore
per Stravinskij per il superamento del
linguaggio del passato e l'inizio di una
personale forma espressiva. Segna poi la
fondamentale collaborazione del compositore con
l'impresario Sergej Diaghilev per i famosi
Balletti Russi. Axelrod, bacchetta molto
conosciuta dal pubblico per le numerose
collaborazioni con l'Orchestra Sinfonica di
Milano, risalenti anche al periodo de "LaVerdi",
ha mostrato di essere marcia, un celebre Valzer
dei fiori oltre all'Ouverture introduttiva. Brani
celebri che facilmente si ricordano al primo
ascolto. Altrettanto celebre L'oiseau de feu
del secondo russo; è del 1909, in diciannove
momenti perfettamente collegati per un unicum
discorsivo; ha trovato la prima esecuzione nel
1910 a Parigi. Lavoro già evoluto del primo
Novecento, rappresenta un momento di splendore
per Stravinskij per il superamento del
linguaggio del passato e l'inizio di una
personale forma espressiva. Segna poi la
fondamentale collaborazione del compositore con
l'impresario Sergej Diaghilev per i famosi
Balletti Russi. Axelrod, bacchetta molto
conosciuta dal pubblico per le numerose
collaborazioni con l'Orchestra Sinfonica di
Milano, risalenti anche al periodo de "LaVerdi",
ha mostrato di essere
 tra i migliori direttori
di questa compagine orchestrale, una formazione
che conosce molto bene e con la quale trova una
sintonia speciale. Eccellenti prima i delicati e
trasparenti brani de Lo Schiaccianoci e
di ottima qualità
L'oiseau de feu,
ampio lavoro ricco di contrasti timbrici e
dinamici, in crescendo anche per la qualità
innovativa della musica. Un esempio di grande
orchestrazione che richiede una visione unitaria
perfettamente ritrovata da Axelrod. Un successo
annunciato con un riscontro nel volto del
direttore, negli orchestrali e nell'entusiasmo
del numeroso pubblico presente. Applausi
fragorosi e ripetuti. Questa sera alle ore 20.00
si replica. Da non perdere. tra i migliori direttori
di questa compagine orchestrale, una formazione
che conosce molto bene e con la quale trova una
sintonia speciale. Eccellenti prima i delicati e
trasparenti brani de Lo Schiaccianoci e
di ottima qualità
L'oiseau de feu,
ampio lavoro ricco di contrasti timbrici e
dinamici, in crescendo anche per la qualità
innovativa della musica. Un esempio di grande
orchestrazione che richiede una visione unitaria
perfettamente ritrovata da Axelrod. Un successo
annunciato con un riscontro nel volto del
direttore, negli orchestrali e nell'entusiasmo
del numeroso pubblico presente. Applausi
fragorosi e ripetuti. Questa sera alle ore 20.00
si replica. Da non perdere.
12 gennaio
2024 Cesare Guzzardella
Guido Rimonda
e la Camerata Ducale omaggiano Giovanni Battista
Viotti a 200 anni dalla sua scomparsa
Era il 1992 quando a Vercelli
venne alla luce la Camerata Ducale,
formazione cameristica nata per valorizzare
l'opera del vercellese più illustre, quel
Giovanni Battista Viotti (1755-1824), violinista
e compositore, che nacque a dire il vero a pochi
chilometri dalla città piemontese, nel piccolo
paese di Fontanetto Po. Artefice della nota
compagine orchestrale era, ed è ancora il
direttore e il principale violinista, Guido
Rimonda. A duecento anni dalla morte del grande
 virtuoso e compositore piemontese, Rimonda ha
voluto rendergli omaggio nella bellissima serata
organizzata nel Conservatorio milanese dalla
Fondazione la Società dei Concerti. Tutte
composizioni di Viotti quelle in programma,
brani di un musicista conosciuto da tutti gli
intenditori e gli appassionati di musica
violinistica , ma che meriterebbe una maggiore
diffusione nelle sale da concerto italiane. La
sterminata produzione compositiva di Viotti,
soprattutto dedicata al violino e all'orchestra,
ha trovato ieri sera un'eccellente sintesi
attraverso una scelta di alcuni lavori quali il
Rondò dal Concerto n.25 in la minore,
Meditazione in preghiera, Tema e variazioni in
do maggiore e il conclusivo completo
Concerto n.24 in si minore per violino e
orchestra. Il noto interprete
cinquantacinquenne di Saluzzo, ha introdotto
verbalmente, come d'abitudine, ogni brano
dell'impaginato, inserdolo nel contesto più
ampio della vita del compositore, un grande
innovatore, anticipatore del romanticismo virtuoso e compositore piemontese, Rimonda ha
voluto rendergli omaggio nella bellissima serata
organizzata nel Conservatorio milanese dalla
Fondazione la Società dei Concerti. Tutte
composizioni di Viotti quelle in programma,
brani di un musicista conosciuto da tutti gli
intenditori e gli appassionati di musica
violinistica , ma che meriterebbe una maggiore
diffusione nelle sale da concerto italiane. La
sterminata produzione compositiva di Viotti,
soprattutto dedicata al violino e all'orchestra,
ha trovato ieri sera un'eccellente sintesi
attraverso una scelta di alcuni lavori quali il
Rondò dal Concerto n.25 in la minore,
Meditazione in preghiera, Tema e variazioni in
do maggiore e il conclusivo completo
Concerto n.24 in si minore per violino e
orchestra. Il noto interprete
cinquantacinquenne di Saluzzo, ha introdotto
verbalmente, come d'abitudine, ogni brano
dell'impaginato, inserdolo nel contesto più
ampio della vita del compositore, un grande
innovatore, anticipatore del romanticismo
 musicale ed anche inventore dell'archetto
moderno. Come da anni accade, ad inizio concerto
Rimonda entra con il suo eccellente violino
Stradivari dal fondo di Sala Verdi introducendo
in solitaria le note del violino, raggiungendo
il palcoscenico e la sua orchestra per
completare l'introduzione al primo brano in
programma. La corposità timbrica del suo
splendido strumento ad arco e la precisa
restituzione sonora hanno da subito rivelato
l'alta cifra interpretativa del virtuoso che è
approdato poi al Rondò dal Concerto n.25 in
la minore. L'eccellenza melodica di Viotti,
tutta italiana nello stile, si è potenziata in
bellezza nella nota Meditazione in preghiera,
un brano di profonda espressività nelle discrete
e interiorizzate note della semplice melodia.
Ottimo l'equilibrio con la compagine strumentale,
formata da strumentisti prevalentemente giovani.
Il brano successivo, il Tema con variazioni
in do maggiore del 1781, non è altro che il
celebre tema della Marsigliese, divenuto
successivamente l'inno francese, che nella
originaria versione italiana trova alcune
splendide variazioni anticipatrici, nella
componente virtuosistica, musicale ed anche inventore dell'archetto
moderno. Come da anni accade, ad inizio concerto
Rimonda entra con il suo eccellente violino
Stradivari dal fondo di Sala Verdi introducendo
in solitaria le note del violino, raggiungendo
il palcoscenico e la sua orchestra per
completare l'introduzione al primo brano in
programma. La corposità timbrica del suo
splendido strumento ad arco e la precisa
restituzione sonora hanno da subito rivelato
l'alta cifra interpretativa del virtuoso che è
approdato poi al Rondò dal Concerto n.25 in
la minore. L'eccellenza melodica di Viotti,
tutta italiana nello stile, si è potenziata in
bellezza nella nota Meditazione in preghiera,
un brano di profonda espressività nelle discrete
e interiorizzate note della semplice melodia.
Ottimo l'equilibrio con la compagine strumentale,
formata da strumentisti prevalentemente giovani.
Il brano successivo, il Tema con variazioni
in do maggiore del 1781, non è altro che il
celebre tema della Marsigliese, divenuto
successivamente l'inno francese, che nella
originaria versione italiana trova alcune
splendide variazioni anticipatrici, nella
componente virtuosistica,
 delle più note
variazioni paganiniane. Ricordiamo che il
celebre virtuoso genovese è nato però quasi
trent'anni dopo il meno noto piemontese. Dopo il
breve intervallo, il brano più corposo, il
Concerto n.24 in si minore, ha rivelato
ancora la grandezza del grande musicista e la
sua profondità artistica. L'eccellente
restituzione interpretativa di Rimonda e della
Camerata Ducale nel delineare gli splendidi tre
movimenti e cioè il Maestoso iniziale, l'Andante
sostenuto centrale e il conclusivo
Allegretto che compngono il concerto, hanno
ancora esaltato il genio musicale di Giovanni
Battista Viotti. Applausi sostenuti e prolungati
dal pubblico presente in Sala Verdi al termine
del programma ufficiale e come bis il penetrante
Andante dal Concerto n.13. Ancora
prolungati e fragorosi applausi a tutti i
protagonisti. delle più note
variazioni paganiniane. Ricordiamo che il
celebre virtuoso genovese è nato però quasi
trent'anni dopo il meno noto piemontese. Dopo il
breve intervallo, il brano più corposo, il
Concerto n.24 in si minore, ha rivelato
ancora la grandezza del grande musicista e la
sua profondità artistica. L'eccellente
restituzione interpretativa di Rimonda e della
Camerata Ducale nel delineare gli splendidi tre
movimenti e cioè il Maestoso iniziale, l'Andante
sostenuto centrale e il conclusivo
Allegretto che compngono il concerto, hanno
ancora esaltato il genio musicale di Giovanni
Battista Viotti. Applausi sostenuti e prolungati
dal pubblico presente in Sala Verdi al termine
del programma ufficiale e come bis il penetrante
Andante dal Concerto n.13. Ancora
prolungati e fragorosi applausi a tutti i
protagonisti.
11 gennaio 2024 Cesare
Guzzardella
Enrico Pieranunzi diretto da
Michele Corcella tra jazz e classica alle
Serate Musicali
Un concerto diverso dal
consueto quello ascoltato ieri sera alle
Serate Musicali del Conservatorio milanese.
Enrico Pieranunzi, affermato pianista e
compositore jazz, ha portato in Sala Verdi la
musica di John Lewis (1920-2001), celebre
pianista e compositore jazz statunitense, noto
 anche
per la sua storica formazione, quel Modern
Jazz Quartet che tra gli anni '50 e gli anni
'90 del secolo scorso cercò una fusione tra il
mondo della musica classica e l'improvvisazione
tipica del jazz ottenendo validi risultati. Il
quartetto americano non fu l'unico a valorizzare
l'importante fusione tra stilemi differenti:
personalità altrattanto importanti quali, ad
esempio, David Brubeck o Gil Evans operarono in
modo analogo. Pieranunzi, in trio con Luca
Bulgarelli al contrabbasso e Mauro Beggio alla
batteria, è stato supportato in modalità "classica"
dall'Orchestra Filarmonica Italiana
diretta da Michele Corcella, autore di tutti gli
arrangiamenti dei brani eseguiti e ideatore,
insieme al pianista jazz, di un progetto
musicale denominato Blues & Bach: the music
of John Lewis. anche
per la sua storica formazione, quel Modern
Jazz Quartet che tra gli anni '50 e gli anni
'90 del secolo scorso cercò una fusione tra il
mondo della musica classica e l'improvvisazione
tipica del jazz ottenendo validi risultati. Il
quartetto americano non fu l'unico a valorizzare
l'importante fusione tra stilemi differenti:
personalità altrattanto importanti quali, ad
esempio, David Brubeck o Gil Evans operarono in
modo analogo. Pieranunzi, in trio con Luca
Bulgarelli al contrabbasso e Mauro Beggio alla
batteria, è stato supportato in modalità "classica"
dall'Orchestra Filarmonica Italiana
diretta da Michele Corcella, autore di tutti gli
arrangiamenti dei brani eseguiti e ideatore,
insieme al pianista jazz, di un progetto
musicale denominato Blues & Bach: the music
of John Lewis.
 Tra i brani eseguiti di John
Lewis segnaliamo Vendome,
Sketting in Central Park,
Spanish Steps, Milano, Concorde,
Jasmine Tree e Django, celebre
brano di Lewis dedicato al chitarrista gitano
belga-francese Django Reinhardt. Eseguito poi come bis un
eccellente Autumn in New York di Vernon
Duke (1903-1969) con un momento di "a solo" del
batterista Mauro Beggio di particolare efficacia
ritmica. Tutti i brani hanno trovato un ottimo
dosaggio di timbriche tra la componente
jazzistica del trio, con parti improvvisate,
cadenze pianistiche e individualità dell'ottimo
contrabbasso di Bulgarelli o del batterista
Beggio, e le componenti dettagliate scritte in
partitura da Corcella per i dieci strumentisti
dell'Orchestra che tra il quintetto d'archi e i
cinque strumenti a fiato hanno dato prova di
grande resa stilistica. L'alternanza tra le
parti ben delineate in trio e l'orchestra
cameristica Tra i brani eseguiti di John
Lewis segnaliamo Vendome,
Sketting in Central Park,
Spanish Steps, Milano, Concorde,
Jasmine Tree e Django, celebre
brano di Lewis dedicato al chitarrista gitano
belga-francese Django Reinhardt. Eseguito poi come bis un
eccellente Autumn in New York di Vernon
Duke (1903-1969) con un momento di "a solo" del
batterista Mauro Beggio di particolare efficacia
ritmica. Tutti i brani hanno trovato un ottimo
dosaggio di timbriche tra la componente
jazzistica del trio, con parti improvvisate,
cadenze pianistiche e individualità dell'ottimo
contrabbasso di Bulgarelli o del batterista
Beggio, e le componenti dettagliate scritte in
partitura da Corcella per i dieci strumentisti
dell'Orchestra che tra il quintetto d'archi e i
cinque strumenti a fiato hanno dato prova di
grande resa stilistica. L'alternanza tra le
parti ben delineate in trio e l'orchestra
cameristica
 o la resa corale d'insieme, ha
portato ad una valida realizzazione musicale
complessiva che ci ha fatto rivivere il clima
musicale di quei decenni nei quali ritmo e
improvvisazione jazz hanno sposato la precisa
declinazione melodica della parte scritta in
partitura. Ottimo il delicato pianismo di
Pieranunzi, ricco di raffinatezze
melodico-ritmiche. Il musicista ha anche
introdotto in modo ironico, come è suo solito
fare, ogni brano in programma. Meritato successo
e applausi fragorosi del pubblico presente in
Sala Verdi a tutti i protagonisti. Lunedì 15
gennaio, sempre per Serate Musicali, sarà
presente il soprano Gabriella Costa e il
pianista Andrea Bacchetti in un programma
diversificato ed interessante. Da non perdere. o la resa corale d'insieme, ha
portato ad una valida realizzazione musicale
complessiva che ci ha fatto rivivere il clima
musicale di quei decenni nei quali ritmo e
improvvisazione jazz hanno sposato la precisa
declinazione melodica della parte scritta in
partitura. Ottimo il delicato pianismo di
Pieranunzi, ricco di raffinatezze
melodico-ritmiche. Il musicista ha anche
introdotto in modo ironico, come è suo solito
fare, ogni brano in programma. Meritato successo
e applausi fragorosi del pubblico presente in
Sala Verdi a tutti i protagonisti. Lunedì 15
gennaio, sempre per Serate Musicali, sarà
presente il soprano Gabriella Costa e il
pianista Andrea Bacchetti in un programma
diversificato ed interessante. Da non perdere.
(FOTO DI ALBERTO
PANZANI-UFF.STAMPA SERATE MUSICALI)
9 gennaio 2024 Cesare Guzzardella
DICEMBRE 2023
-
L'Anima Latina con
Mariangela
D'Abbraccio al Teatro Parenti
Una
serata particolarmente riuscita quella
dell'attrice e chanteuse napoletana
Mariangela D'Abbraccio, arrivata al Teatro
Parenti accompagnata dal valido pianista
Massimiliano Gagliardi per lo spettacolo "Anima
Latina". Il lavoro è ottimamente costruito
dalla regia di Francesco Tavassi, che mette in
risalto il talento della protagonista, in grado
di passare dalla recitazione al canto in modo
unitario e coinvolgente. Una sorta di
pastiche che unisce, senza soluzione di
continuità, numerosi brani provenienti
soprattutto dal mondo latino, napoletano e del
Sud America - in particolare Argentina e Brasile
- ma con incursioni anche più a nord, grazie ad
 autentici
piccoli capolavori della cosiddetta scuola di
Genova, di Tenco ("Vedrai, vedrai") , De
Andrè ("Amore che vieni, amore che vai"),
Endrigo ("Canzone per te"), o di quella
romana di Bruno Martino ("Estate") e
pugliese di Domenico Modugno. Non solo brani
cantati, quindi, ma anche poesie ed
extrapolazioni di testi teatrali ben recitati,
spesso ad introduzione delle canzoni. Borges,
Pessoa, Neruda, Lorca o Eduardo, si sono
intrecciati con il tango argentino di Piazzolla,
con i testi di Vinicius De Moraes, con canzoni
classiche napoletane di Salvatore Di Giacomo e
di Libero Bovio, ma anche con Pino Daniele e con
i testi di numerosi cantautori letti
poeticamente e cantati in modo personale e
convincente. autentici
piccoli capolavori della cosiddetta scuola di
Genova, di Tenco ("Vedrai, vedrai") , De
Andrè ("Amore che vieni, amore che vai"),
Endrigo ("Canzone per te"), o di quella
romana di Bruno Martino ("Estate") e
pugliese di Domenico Modugno. Non solo brani
cantati, quindi, ma anche poesie ed
extrapolazioni di testi teatrali ben recitati,
spesso ad introduzione delle canzoni. Borges,
Pessoa, Neruda, Lorca o Eduardo, si sono
intrecciati con il tango argentino di Piazzolla,
con i testi di Vinicius De Moraes, con canzoni
classiche napoletane di Salvatore Di Giacomo e
di Libero Bovio, ma anche con Pino Daniele e con
i testi di numerosi cantautori letti
poeticamente e cantati in modo personale e
convincente.
 Ottimi
gli arrangiamenti pianistici, che hanno unito la
recita e il canto: il M. tro Gagliardi è stato
preciso e attento alle inflessioni verbali e
vocali della D'Abbraccio, rivelando una
musicalità autentica, dal carattere
improvvisatorio, e adeguato alle apparentemente
spontanee incursioni della protagonista, ricche
di coordinate gestualità e fisicità, studiate
alla perfezione. Uno spettacolo che alla prima
rappresentazione di ieri sera al Teatro Parenti,
in Sala A, non troppo grande e per questo
adattissima al lavoro proposto, ha trovato un
successo davvero meritato. Due i bis, tra i
quali lo splendido " Dicitencello vuje".
Numerosi e calorosi gli applausi del pubblico,
presente al completo. Lo spettacolo verrà
replicato fino al 7 gennaio, con una recita
speciale per il 31 dicembre, che si concluderà
con un brindisi per festeggiare l'arrivo del
2024. Assolutamente da non perdere. Ottimi
gli arrangiamenti pianistici, che hanno unito la
recita e il canto: il M. tro Gagliardi è stato
preciso e attento alle inflessioni verbali e
vocali della D'Abbraccio, rivelando una
musicalità autentica, dal carattere
improvvisatorio, e adeguato alle apparentemente
spontanee incursioni della protagonista, ricche
di coordinate gestualità e fisicità, studiate
alla perfezione. Uno spettacolo che alla prima
rappresentazione di ieri sera al Teatro Parenti,
in Sala A, non troppo grande e per questo
adattissima al lavoro proposto, ha trovato un
successo davvero meritato. Due i bis, tra i
quali lo splendido " Dicitencello vuje".
Numerosi e calorosi gli applausi del pubblico,
presente al completo. Lo spettacolo verrà
replicato fino al 7 gennaio, con una recita
speciale per il 31 dicembre, che si concluderà
con un brindisi per festeggiare l'arrivo del
2024. Assolutamente da non perdere.
29 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
Il Quartetto Indaco
e Emilio Aversano ai concerti di Serate
Musicali
Avevamo
ascoltato il Quartetto Indaco nell'ottobre di
quest'anno allo Spazio Teatro89 di Milano in
Beethoven ( op.74 )e in Schubert ( D 810- La
morte e la fanciulla) rimanendo sorpresi delle
ottime qualità
 interpretative
di Aleonora Matsuno e di Ida Di Vita ai violini,
di Jamiang Santi alla viola e di Cosimo Carovani
al violoncello. Ieri sera i quattro recenti
vincitori del prestigioso Osaka International
Competition, hanno bissato il successo in
Sala Verdi, al concerto organizzato da Serate
Musicali, nel Conservatorio milanese dove i
quattro hanno anche studiato. Proponendo prima
il Quartetto d'archi n.15 in sol maggiore D
887 di Schubert, hanno poi continuato
allargando la formazione a quintetto interpretative
di Aleonora Matsuno e di Ida Di Vita ai violini,
di Jamiang Santi alla viola e di Cosimo Carovani
al violoncello. Ieri sera i quattro recenti
vincitori del prestigioso Osaka International
Competition, hanno bissato il successo in
Sala Verdi, al concerto organizzato da Serate
Musicali, nel Conservatorio milanese dove i
quattro hanno anche studiato. Proponendo prima
il Quartetto d'archi n.15 in sol maggiore D
887 di Schubert, hanno poi continuato
allargando la formazione a quintetto
 con
pianoforte, con il noto Quintetto n.2 in la
maggiore op.81 di Antonin Dvorač.
Al pianoforte
l'affermato Emilio Aversano ha sostenuto in modo
disinvolto il suo importante ruolo. Come già
evidenziato lo
scorso ottobre, la formazione esprime un
equilibrio delle timbriche giocato su una unione
esemplare degli intenti musicali che permette
una fusione melodico-armonica di alto livello.
L'eccellente ultimo quartetto del viennese, il D
887, ha trovato quindi ancora degni interpreti.
Il più folclorico quintetto del musicista ceco,
l'op.81, era ricco di richiami alla tradizione
popolare e particolarmente vario nei marcati
contrasti dei rispettivi movimenti, con un
secondo movimento, Dumka- con
pianoforte, con il noto Quintetto n.2 in la
maggiore op.81 di Antonin Dvorač.
Al pianoforte
l'affermato Emilio Aversano ha sostenuto in modo
disinvolto il suo importante ruolo. Come già
evidenziato lo
scorso ottobre, la formazione esprime un
equilibrio delle timbriche giocato su una unione
esemplare degli intenti musicali che permette
una fusione melodico-armonica di alto livello.
L'eccellente ultimo quartetto del viennese, il D
887, ha trovato quindi ancora degni interpreti.
Il più folclorico quintetto del musicista ceco,
l'op.81, era ricco di richiami alla tradizione
popolare e particolarmente vario nei marcati
contrasti dei rispettivi movimenti, con un
secondo movimento, Dumka-
 Andante
con moto, di straordinaria intensità
melodica. Valida l'integrazione del pianoforte
con i colori omogenei dei quattro strumentisti
ad arco. L'ottima resa espressiva e la
perfezione formale e sostanziale dei cinque
interpreti ha determinato un evidente
apprezzamento del pubblico presente in Sala
Verdi. Come bis hanno concesso la ripetizione
dello Scherzo-Furiant del quintetto,
brano di particolare estroversione che ha
decretato il successo del gruppo cameristico
nella splendida serata musicale. Applausi
calorosi. (foto di Alberto Panzani
- Uff. stampa Serate Musicali) Andante
con moto, di straordinaria intensità
melodica. Valida l'integrazione del pianoforte
con i colori omogenei dei quattro strumentisti
ad arco. L'ottima resa espressiva e la
perfezione formale e sostanziale dei cinque
interpreti ha determinato un evidente
apprezzamento del pubblico presente in Sala
Verdi. Come bis hanno concesso la ripetizione
dello Scherzo-Furiant del quintetto,
brano di particolare estroversione che ha
decretato il successo del gruppo cameristico
nella splendida serata musicale. Applausi
calorosi. (foto di Alberto Panzani
- Uff. stampa Serate Musicali)
22 dicembre
2023 Cesare Guzzardella
I Solisti Aquilani alla
Società dei Concerti
Un
concerto vario e ricco di ottima musica ha
concluso in Conservatorio l'anno concertistico
2023 della Società dei Concerti per la
pausa natalizia e la ripresa stagionale di
gennaio. I Solisti Aquilani e il loro
violino di spalla Daniele Orlando
hanno eseguito le celebri "Le quattro
stagioni" di Antonio Vivaldi, anticipate
però dal bellissimo timbro dell'arpa di Valerio
Lisci impegnato, con la
 formazione
cameristica, in due lavori: il primo di Claude
Debussy con la rara
Danse sacrée et Danse
profane per arpa e orchestra d'archi; il
secondo con il Concerto in si bem. maggiore
n.6 HWV 294 per arpa e archi. Due brani
diversi, ma riuniti da una musicalità
straordinaria nelle mani di Lisci, un arpista
che nelle discrete volumetrie dell'antico
strumento riesce a dare spessore coloristico con
una gamma infinita di dinamiche. Dai suoni quasi
impercettibili e quelli più decisi, inseriti
nell'ottimo contesto cameristico dominato dagli
archi e con la presenza del clavicembalo in
Händel. Le straordinarie danze di Debussy hanno
nell'arpa lo strumento più adatto a rapprentarle,
ma è proprio il genere del grande francese che
ben si addice ai colori vellutati, morbidi e
nascosti dell'arpa. Sonorità spesso lontane ma
individuate con maestria dell'eccelente
interprete. Ottimi entrambi i brani e di impatto
virtuosistico il bis concesso con un valida
trascrizione per arpa dal brano pianistico
Le
rossignol di Franz Liszt. Dopo il breve
intervallo i sedici strumentisti impegnati in
Vivaldi- quindici archi più il cembalo- hanno
regalato un'interpretazione delle Quattro
Stagioni certamente particolare e personalizzata.
La rilevanza data formazione
cameristica, in due lavori: il primo di Claude
Debussy con la rara
Danse sacrée et Danse
profane per arpa e orchestra d'archi; il
secondo con il Concerto in si bem. maggiore
n.6 HWV 294 per arpa e archi. Due brani
diversi, ma riuniti da una musicalità
straordinaria nelle mani di Lisci, un arpista
che nelle discrete volumetrie dell'antico
strumento riesce a dare spessore coloristico con
una gamma infinita di dinamiche. Dai suoni quasi
impercettibili e quelli più decisi, inseriti
nell'ottimo contesto cameristico dominato dagli
archi e con la presenza del clavicembalo in
Händel. Le straordinarie danze di Debussy hanno
nell'arpa lo strumento più adatto a rapprentarle,
ma è proprio il genere del grande francese che
ben si addice ai colori vellutati, morbidi e
nascosti dell'arpa. Sonorità spesso lontane ma
individuate con maestria dell'eccelente
interprete. Ottimi entrambi i brani e di impatto
virtuosistico il bis concesso con un valida
trascrizione per arpa dal brano pianistico
Le
rossignol di Franz Liszt. Dopo il breve
intervallo i sedici strumentisti impegnati in
Vivaldi- quindici archi più il cembalo- hanno
regalato un'interpretazione delle Quattro
Stagioni certamente particolare e personalizzata.
La rilevanza data
 all'ottimo
violino di Daniele Orlando, spesso in primo
piano, e l'orchestrazione reinventata trovando
nuovi elementi di contrasto tra i
tutti e
il solista, hanno determinato una nuova
modalità interpretativa con elementi timbrici a
volte trasgressivi, ma coerenti con ad un'idea
precisa di esecuzione che nulla ha tolto al
genio vivaldiano. Un lavoro particolarmente
valido che ha visto frangenti sonori definiti da
"colori antichi" contrastanti con altri molto "moderni",
per un'unità espressiva di alta resa estetica.
La Stagione concertistica riprenderà il 10
gennaio con la Camerata Ducale di Guido Rimonda.
Ma anticipiamo il concerto straordinario che il
grande pianista Evgeny Kissin terra il 20
gennaio per ricordare Antonio Mormone,
presidente della Società dei Concerti e
scopritore del talentuoso pianista russo. Da non
perdere! all'ottimo
violino di Daniele Orlando, spesso in primo
piano, e l'orchestrazione reinventata trovando
nuovi elementi di contrasto tra i
tutti e
il solista, hanno determinato una nuova
modalità interpretativa con elementi timbrici a
volte trasgressivi, ma coerenti con ad un'idea
precisa di esecuzione che nulla ha tolto al
genio vivaldiano. Un lavoro particolarmente
valido che ha visto frangenti sonori definiti da
"colori antichi" contrastanti con altri molto "moderni",
per un'unità espressiva di alta resa estetica.
La Stagione concertistica riprenderà il 10
gennaio con la Camerata Ducale di Guido Rimonda.
Ma anticipiamo il concerto straordinario che il
grande pianista Evgeny Kissin terra il 20
gennaio per ricordare Antonio Mormone,
presidente della Società dei Concerti e
scopritore del talentuoso pianista russo. Da non
perdere!
21 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
I trii di Brahms per
Lonquich, Kelemen e
Altstaedt alle Serate
Musicali del Conservatorio
A metà
novembre ai concerti di Serate Musicali
il pianista Alexander Lonquich aveva portato in
Conservatorio, sul palcoscenico di Sala Verdi,
due ottime strumentiste per i trii con violino e
violoncello di Robert Schumann, tre
interpretazioni di ottima qualità. Ieri sera,
sempre in un concerto organizzato da Serate
Musicali, il noto interprete ha avuto due
compagni, nei nomi di
 Barnabás
Kelemen, al violino e di Nicholas Altstaedt, al
violoncello per i trii di Johannes Brahms. Sono
tre lavori musicalmente particolarmente densi,
dove gli intrecci melodici, armonici e i
dialoghi tra i tre strumenti avvengono con una
tensione emotiva tipica dello sviluppo che la
musica romantica ha avuto a partire dal secondo
Ottocento. Il Trio per pianoforte ed archi in
si magg. op.8 (versione n.2) ebbe la prima
stesura nel 1850 ma fu modificato in meglio alla
fine degli anni '80, quando il compositore
amburghese aveva scritto da poco il Trio n.2
in do maggiore op.87 - del 1882- e Il
Trio n.3 in do minore op. 101, del 1887. Le
tre non facili composizioni, che meritano
numerosi ascolti per definirne le particolarità,
hanno trovato nei tre protagonisti interpreti
d'eccezione. La parte pianistica di Lonquich,
armonicamente più complessa e struttura portante
del tutto, ha trovato Barnabás
Kelemen, al violino e di Nicholas Altstaedt, al
violoncello per i trii di Johannes Brahms. Sono
tre lavori musicalmente particolarmente densi,
dove gli intrecci melodici, armonici e i
dialoghi tra i tre strumenti avvengono con una
tensione emotiva tipica dello sviluppo che la
musica romantica ha avuto a partire dal secondo
Ottocento. Il Trio per pianoforte ed archi in
si magg. op.8 (versione n.2) ebbe la prima
stesura nel 1850 ma fu modificato in meglio alla
fine degli anni '80, quando il compositore
amburghese aveva scritto da poco il Trio n.2
in do maggiore op.87 - del 1882- e Il
Trio n.3 in do minore op. 101, del 1887. Le
tre non facili composizioni, che meritano
numerosi ascolti per definirne le particolarità,
hanno trovato nei tre protagonisti interpreti
d'eccezione. La parte pianistica di Lonquich,
armonicamente più complessa e struttura portante
del tutto, ha trovato
 ottimi
interpreti in Kelemen e in Altstaedt. La
perfetta coesione degli intrecci tematici ha
definito un'eccellente sinergia nel restituire
in modo particolareggiato i tre capolavori,
partendo dall'op.87 e dall'op.101 e concludendo,
dopo il breve intervallo, con la più corposa e
probabilmente più celebre Op.8. Come anche nel
concerto di metà novembre, anche in Brahms,
compositore certamente debitore prima di
Beethoven e poi di Robert Schumann, sono apparsi
pregnanti d'espressività tutti i movimenti, con
andamenti di profonda resa anche nei momenti più
riflessivi dei rispettivi trii.
Un'interpretazione complessiva molto piaciuta al
pubblico presente in Sala Verdi, che al termine
del programma ha tributato fragorosi applausi.
Nel bis la ripetizione di uno dei movimenti più
profondi dell'op.87: l'Andante con moto,
reso ancora splendidamente. Applausi fragorosi
ai protagonisti. ottimi
interpreti in Kelemen e in Altstaedt. La
perfetta coesione degli intrecci tematici ha
definito un'eccellente sinergia nel restituire
in modo particolareggiato i tre capolavori,
partendo dall'op.87 e dall'op.101 e concludendo,
dopo il breve intervallo, con la più corposa e
probabilmente più celebre Op.8. Come anche nel
concerto di metà novembre, anche in Brahms,
compositore certamente debitore prima di
Beethoven e poi di Robert Schumann, sono apparsi
pregnanti d'espressività tutti i movimenti, con
andamenti di profonda resa anche nei momenti più
riflessivi dei rispettivi trii.
Un'interpretazione complessiva molto piaciuta al
pubblico presente in Sala Verdi, che al termine
del programma ha tributato fragorosi applausi.
Nel bis la ripetizione di uno dei movimenti più
profondi dell'op.87: l'Andante con moto,
reso ancora splendidamente. Applausi fragorosi
ai protagonisti.
19 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
Un pomeriggio di serate
rossiniane allo Spazio-Teatro 89
"Un
pomeriggio di Serate" quello visto
ieri allo Spazio Teatro 89 con le
Soirées musicales di Gioacchino Rossini
proposte dal soprano Manuela Bisceglie, dal
mezzosoprano Külli Tomingas e dal pianista Luca
Schieppati. Composte tra il 1830 e il 1835 dal
musicista pesarese, quando aveva già smesso di
produrre opere liriche per dedicarsi nel periodo
parigino alla sola musica da camera,
 le
Soirées musicales sono otto Ariette
e quattro Duetti concepiti da Rossini per
lo studio del canto, ma divenuti poi celebri per
la deliziosa e varia resa qualitativa. La
popolarità della Tarantella rossoniana è
indiscussa, ma anche le Canzonette, la
Barcarola, la Tirolese e i
Notturni dei duetti, trovano diffuse
esecuzioni. Raramente vengono eseguite tutte
insieme. Quella di oggi è stata quindi una
rarità d'ascolto di straordinario interesse.
L'alternanza delle ottime voci ascoltate e
l'unione dei due timbri nei duetti hanno
rivelato le qualità espressive della materana
Bisceglie e le
Soirées musicales sono otto Ariette
e quattro Duetti concepiti da Rossini per
lo studio del canto, ma divenuti poi celebri per
la deliziosa e varia resa qualitativa. La
popolarità della Tarantella rossoniana è
indiscussa, ma anche le Canzonette, la
Barcarola, la Tirolese e i
Notturni dei duetti, trovano diffuse
esecuzioni. Raramente vengono eseguite tutte
insieme. Quella di oggi è stata quindi una
rarità d'ascolto di straordinario interesse.
L'alternanza delle ottime voci ascoltate e
l'unione dei due timbri nei duetti hanno
rivelato le qualità espressive della materana
Bisceglie e
 della
estone Tomingas, coadiuvate con chiarezza
coloristica dalle note pianistiche di Luca
Schieppati, interprete e anche organizzatore e
presentatore del pomeriggio musicale. Essendo
presenti solo voci femminili e mancando quelle
maschili in due brani, Li marinari e
La serenata, Schieppati ha eseguito il primo
brano al pianoforte nella trascrizione solistica
di Franz Liszt, ed è stata sostituita la voce
tenorile mancante con quella da mezzosoprano della
Tomingas per una resa di La serenata
comunque ottima. Le valenti interpreti, in
perfetto accordo nei duetti hanno rivelato anche
indubbie qualità nel porsi in scena e al termine
delle deliziose Soirées musicales è stato
concesso un altrettanto valido bis a due voci
con il celebre Prenderò quel brunettino
dal Così fan tutte di W.A.Mozart. Un
pomeriggio domenicale di eccellente qualità. (
Foto di Alberto Panzani - Serate Musicali) della
estone Tomingas, coadiuvate con chiarezza
coloristica dalle note pianistiche di Luca
Schieppati, interprete e anche organizzatore e
presentatore del pomeriggio musicale. Essendo
presenti solo voci femminili e mancando quelle
maschili in due brani, Li marinari e
La serenata, Schieppati ha eseguito il primo
brano al pianoforte nella trascrizione solistica
di Franz Liszt, ed è stata sostituita la voce
tenorile mancante con quella da mezzosoprano della
Tomingas per una resa di La serenata
comunque ottima. Le valenti interpreti, in
perfetto accordo nei duetti hanno rivelato anche
indubbie qualità nel porsi in scena e al termine
delle deliziose Soirées musicales è stato
concesso un altrettanto valido bis a due voci
con il celebre Prenderò quel brunettino
dal Così fan tutte di W.A.Mozart. Un
pomeriggio domenicale di eccellente qualità. (
Foto di Alberto Panzani - Serate Musicali)
17 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
LA BOHEME
CHIUDE LA
STAGIONE LIRICA DEL TEATRO COCCIA DI NOVARA
Ieri sera, domenica 17
dicembre, si è chiusa a Novara, al Teatro Coccia,
la stagione lirica, che, da un paio d’anni,
coincide coll’anno solare. A chiudere la
stagione è stata la Bohème di Puccini, che
rappresenta anche un’anticipazione
dell’imminente anno pucciniano, il 2024,
centenario della morte del grande Maestro
lucchese: già a gennaio, all’inizio della nuova
stagione, il Coccia comincerà le celebrazioni
con la Butterfly. Questa Bohème è una
coproduzione del Teatro Coccia e del Teatro del
Giglio di Lucca, di cui viene ripreso, con
alcune modifiche, uno storico allestimento. La
regia di questa Bohème è affidata a Marco
Gandini, allievo di Zeffirelli, che rifiuta
risolutamente un’interpretazione in chiave ‘veristica’
del capolavoro pucciniano, individuando come
tema di fondo, drammaturgico e musicale, “la
reminiscenza” (è una parola dello stesso Gandini),
il ricordo. Secondo tale interpretazione la
morte di Mimì segna (come quella della Silvia
leopardiana, ci verrebbe da commentare), la fine
della giovinezza, con l’approdo dei personaggi
alla consapevolezza della morte e dunque
l’intera vicenda viene presentata in una
dimensione mnemonica, come il ricordo di
un’illusione di felicità, di sogni, dissoltisi per sempre. Questa
interpretazione registica viene tradotta in due
modi nella scenografia curata dal bravo Italo
Grassi: anzitutto, essendo lo spazio del dramma
lo spazio del ricordo della giovinezza finita
per sempre e fissatasi sempre eguale a se stessa
nella memoria, la scena, ridotta all’essenziale,
rimane sostanzialmente invariata nei suoi
elementi portanti, appena adattati e mutati il
minimo necessario alle diverse situazioni dei
quattro quadri. Una scenografia che negli ultimi
due quadri si va facendo sempre più spoglia, a
simboleggiare il progressivo avanzare della
consapevolezza della morte nella coscienza dei
personaggi: se la scena della Barriera d’Enfer
ha un che di cimiteriale, la scena del quarto
quadro, che torna al punto in cui tutto è
cominciato, la squallida soffitta di Rodolfo e
Marcello, rispetto al primo quadro è uno spazio
quasi completamente vuoto, lo spazio, davvero,
in cui tutto finisce, una sorta di tomba. La
seconda caratteristica di questa scenografia è
il fatto che i diversi ambienti, compreso quello
più ‘festoso’ del Quartiere Latino nel secondo
quadro, si staccano da un fondo di tenebroso
buio, quasi che l’intera vicenda si svolgesse
nel buio della notte. Si tratta di un buio
anch’esso chiaramente simbolico della morte e
del nulla cui l’effimera vita dell’uomo, coi
suoi vani sogni di felicità, è condannata.
Dunque una regia e una scenografia in cui il
dettaglio realistico non manca (come la neve
alla Barriera d’Enfer), tuttavia non ha alcun
sapore di quotidianità realistica, ma proietta
la vicenda su un piano simbolico, quasi onirico.
La regia di Gandini si fa apprezzare molto anche
per la gestione del movimento dei cantanti e del
coro sul palcoscenico, sempre efficace: per
citare un solo esempio, molto bello l’episodio
del terzo quadro, il breve duetto tra Rodolfo e
Marcello in cui è evocata la morte ormai
imminente di Mimì, mentre questa è lontana,
appoggiata al muro, e ascolta quanto dicono i
due uomini; Mimì, a questo punto, è già morta,
la morte è entrata nella coscienza dei giovani,
che cessano per questo di essere tali; è il vero
punto di svolta del dramma. Se a tutto questo
aggiungiamo i bei costumi di Laura Biagiotti
avremo il risultato di una rappresentazione
registico-scenografica di notevole bellezza e
intelligenza.
di sogni, dissoltisi per sempre. Questa
interpretazione registica viene tradotta in due
modi nella scenografia curata dal bravo Italo
Grassi: anzitutto, essendo lo spazio del dramma
lo spazio del ricordo della giovinezza finita
per sempre e fissatasi sempre eguale a se stessa
nella memoria, la scena, ridotta all’essenziale,
rimane sostanzialmente invariata nei suoi
elementi portanti, appena adattati e mutati il
minimo necessario alle diverse situazioni dei
quattro quadri. Una scenografia che negli ultimi
due quadri si va facendo sempre più spoglia, a
simboleggiare il progressivo avanzare della
consapevolezza della morte nella coscienza dei
personaggi: se la scena della Barriera d’Enfer
ha un che di cimiteriale, la scena del quarto
quadro, che torna al punto in cui tutto è
cominciato, la squallida soffitta di Rodolfo e
Marcello, rispetto al primo quadro è uno spazio
quasi completamente vuoto, lo spazio, davvero,
in cui tutto finisce, una sorta di tomba. La
seconda caratteristica di questa scenografia è
il fatto che i diversi ambienti, compreso quello
più ‘festoso’ del Quartiere Latino nel secondo
quadro, si staccano da un fondo di tenebroso
buio, quasi che l’intera vicenda si svolgesse
nel buio della notte. Si tratta di un buio
anch’esso chiaramente simbolico della morte e
del nulla cui l’effimera vita dell’uomo, coi
suoi vani sogni di felicità, è condannata.
Dunque una regia e una scenografia in cui il
dettaglio realistico non manca (come la neve
alla Barriera d’Enfer), tuttavia non ha alcun
sapore di quotidianità realistica, ma proietta
la vicenda su un piano simbolico, quasi onirico.
La regia di Gandini si fa apprezzare molto anche
per la gestione del movimento dei cantanti e del
coro sul palcoscenico, sempre efficace: per
citare un solo esempio, molto bello l’episodio
del terzo quadro, il breve duetto tra Rodolfo e
Marcello in cui è evocata la morte ormai
imminente di Mimì, mentre questa è lontana,
appoggiata al muro, e ascolta quanto dicono i
due uomini; Mimì, a questo punto, è già morta,
la morte è entrata nella coscienza dei giovani,
che cessano per questo di essere tali; è il vero
punto di svolta del dramma. Se a tutto questo
aggiungiamo i bei costumi di Laura Biagiotti
avremo il risultato di una rappresentazione
registico-scenografica di notevole bellezza e
intelligenza.
 Un
altro autentico punto di forza di questa Bohème
è la direzione orchestrale. Il Maestro José Luis
Gomez, venezuelano d’origine, ma ormai
naturalizzato spagnolo, alla guida
dell’Orchestra Filarmonica Italiana, ha la
Bohème nel suo repertorio e ieri ha dimostrato
una conoscenza perfetta della partitura. La
direzione di Gomez si è distinta per la grande
cura dei giusti colori espressivi per ogni scena,
per un melodismo molto raffinato e sensibile, ma
mai sentimentaleggiante, sempre aderente alla
situazione drammaturgica. Brilla, la direzione
di Gomez, anche per l’attenzione davvero
ammirevole al palcoscenico, non solo nel
rapporto coi solisti, ma anche relativamente
alle parti corali, complesse soprattutto nel
Quadro del Quartiere Latino, ove Gomez,
coadiuvato dal Direttore del Coro Massimo
Fiocchi Malaspina, ha gestito benissimo entrambi
i cori, l’As.Li.Co. e le Voci Bianche del Teatro
Sociale di Como, nonché la Banda Filarmonica di
Oleggio, dando vita ad un insieme vocale
veramente suggestivo. Buono anche il livello
complessivo dei cantanti. Su tutti ha
primeggiato la Mimì del soprano Valentina
Mastrangelo, che a Novara ha debuttato la parte.
Ha una voce vellutata, armonica, e con un bel
legato: non ha ancora raggiunto la perfezione
nella morbidezza del suono e qualche acuto è
ancora un po’ troppo forzato, ma si fa
facilmente ‘perdonare’ grazie all’intensa
espressività del fraseggio, che si manifesta
subito nella sua prima aria “Mi chiamano Mimì”
molto delicata e in “Donde lieta uscì” del
Quadro terzo, dove la Mastrangelo dà a nostro
avviso il meglio di sé quanto a fraseggio e
linea espressiva del canto. Di livello
decisamente alto anche la recitazione di questo
soprano, che ormai è ben più di una promessa.
Dobbiamo invece confessare che non ci ha per
nulla entusiasmato il Rodolfo del tenore
messicano Mario Rojas. Possiede voce ben
timbrata, calda e vellutata, ma di limitata
proiezione e talora in difficoltà negli acuti:
il suo “Che gelida manina” non è stato
precisamente tra quelli indimenticabili,
denunciando un altro limite di questo cantante
che senz’altro deve ancora maturare: la
debolezza della linea espressiva del canto. La
sua interpretazione ci è Un
altro autentico punto di forza di questa Bohème
è la direzione orchestrale. Il Maestro José Luis
Gomez, venezuelano d’origine, ma ormai
naturalizzato spagnolo, alla guida
dell’Orchestra Filarmonica Italiana, ha la
Bohème nel suo repertorio e ieri ha dimostrato
una conoscenza perfetta della partitura. La
direzione di Gomez si è distinta per la grande
cura dei giusti colori espressivi per ogni scena,
per un melodismo molto raffinato e sensibile, ma
mai sentimentaleggiante, sempre aderente alla
situazione drammaturgica. Brilla, la direzione
di Gomez, anche per l’attenzione davvero
ammirevole al palcoscenico, non solo nel
rapporto coi solisti, ma anche relativamente
alle parti corali, complesse soprattutto nel
Quadro del Quartiere Latino, ove Gomez,
coadiuvato dal Direttore del Coro Massimo
Fiocchi Malaspina, ha gestito benissimo entrambi
i cori, l’As.Li.Co. e le Voci Bianche del Teatro
Sociale di Como, nonché la Banda Filarmonica di
Oleggio, dando vita ad un insieme vocale
veramente suggestivo. Buono anche il livello
complessivo dei cantanti. Su tutti ha
primeggiato la Mimì del soprano Valentina
Mastrangelo, che a Novara ha debuttato la parte.
Ha una voce vellutata, armonica, e con un bel
legato: non ha ancora raggiunto la perfezione
nella morbidezza del suono e qualche acuto è
ancora un po’ troppo forzato, ma si fa
facilmente ‘perdonare’ grazie all’intensa
espressività del fraseggio, che si manifesta
subito nella sua prima aria “Mi chiamano Mimì”
molto delicata e in “Donde lieta uscì” del
Quadro terzo, dove la Mastrangelo dà a nostro
avviso il meglio di sé quanto a fraseggio e
linea espressiva del canto. Di livello
decisamente alto anche la recitazione di questo
soprano, che ormai è ben più di una promessa.
Dobbiamo invece confessare che non ci ha per
nulla entusiasmato il Rodolfo del tenore
messicano Mario Rojas. Possiede voce ben
timbrata, calda e vellutata, ma di limitata
proiezione e talora in difficoltà negli acuti:
il suo “Che gelida manina” non è stato
precisamente tra quelli indimenticabili,
denunciando un altro limite di questo cantante
che senz’altro deve ancora maturare: la
debolezza della linea espressiva del canto. La
sua interpretazione ci è
 parsa
piuttosto scialba anche sul piano drammaturgico,
persino nella scena finale della morte di Mimì,
salvo l’urlo straziante che getta quando prende
consapevolezza di quanto è avvenuto. Ci
permettiamo di far nostra un’intelligente
osservazione di un nostro competente vicino di
posto: questo Rojas è più adatto, per il momento,
a parti come quella di un Nemorino, che non a
ruoli pucciniani ( e non parliamo di quelli
verdiani). Un buon giudizio merita invece
l’altro soprano della Bohème, la giovane
Eleonora Boaretto, anche lei al debutto nel
ruolo di Musetta, ruolo non facile, sia dal
punto di vista musicale, sia da quello
drammaturgico, perché si tratta di un
personaggio complesso, che evolve da una
carattere frivolo e di superficiale edonismo,
alla carica di dolente umanità con cui partecipa
alla tragedia di Mimì. Potremmo dire che la
Boarello ha saputo, su entrambi i piani,
dominare molto bene la parte, con una vocalità
di buona proiezione, un bel vibrato, calibrato
secondo necessità espressive, validi centri
della tessitura e un acuto che, pur avendo
ancora bisogno di qualche miglioramento, è già
apprezzabile. Abbiamo ritrovato volentieri, sul
palcoscenico del Coccia Simone Alberghini, che
avevamo ammirato circa un anno fa nel bellissimo
“Le convenienze e inconvenienze teatrali” di
Donizetti, nella parte per lui più consueta di
basso. Qui, nel ruolo di baritono, (Marcello)
raggiunge comunque risultati sempre di alto
livello, con una tessitura parsa
piuttosto scialba anche sul piano drammaturgico,
persino nella scena finale della morte di Mimì,
salvo l’urlo straziante che getta quando prende
consapevolezza di quanto è avvenuto. Ci
permettiamo di far nostra un’intelligente
osservazione di un nostro competente vicino di
posto: questo Rojas è più adatto, per il momento,
a parti come quella di un Nemorino, che non a
ruoli pucciniani ( e non parliamo di quelli
verdiani). Un buon giudizio merita invece
l’altro soprano della Bohème, la giovane
Eleonora Boaretto, anche lei al debutto nel
ruolo di Musetta, ruolo non facile, sia dal
punto di vista musicale, sia da quello
drammaturgico, perché si tratta di un
personaggio complesso, che evolve da una
carattere frivolo e di superficiale edonismo,
alla carica di dolente umanità con cui partecipa
alla tragedia di Mimì. Potremmo dire che la
Boarello ha saputo, su entrambi i piani,
dominare molto bene la parte, con una vocalità
di buona proiezione, un bel vibrato, calibrato
secondo necessità espressive, validi centri
della tessitura e un acuto che, pur avendo
ancora bisogno di qualche miglioramento, è già
apprezzabile. Abbiamo ritrovato volentieri, sul
palcoscenico del Coccia Simone Alberghini, che
avevamo ammirato circa un anno fa nel bellissimo
“Le convenienze e inconvenienze teatrali” di
Donizetti, nella parte per lui più consueta di
basso. Qui, nel ruolo di baritono, (Marcello)
raggiunge comunque risultati sempre di alto
livello, con una tessitura
 vocale
densa e di eccellente proiezione, di musicalità
precisa e sicura, unite ad una bravura scenica
che ha pochi termini di paragone in questo
momento in Italia. Hanno assolto appieno al loro
compito le parti di fianco: validi sia il
Colline di Abramo Ròsalen, basso, vecchia
conoscenza del pubblico novarese, che strappa un
meritato applauso colla sua unica aria “Vecchia
zimarra”, sia lo Schaunard del baritono Italo
Proferisce. Impeccabile vocalmente e comicamente
efficace il basso Matteo Mollica, nel duplice
ruolo di Benoit e di Alcindoro, così come ben
eseguita è stata la breve parte di Perpignol dal
tenore Zheng Hui, allievo della AMO, l’Accademia
dei Mestieri dell’Opera, aperta da qualche anno
presso il Coccia, come scuola di perfezionamento
per giovani che intendano dedicarsi a tutti i
mestieri legati al teatro d’Opera, dai cantanti
ai registi ai tecnici. Un’ altra bella
rappresentazione d’Opera al Coccia, che possiamo
ormai considerare un teatro lirico di qualità.
Il pubblico ha giustamente applaudito a lungo
cantanti, direttore, orchestra e regista,
dimostrando il suo gradimento. Una sola
osservazione: questo pubblico impari però a
moderare il proprio entusiasmo e a non
applaudire prima che la musica sia davvero
finita: coprire con gli applausi gli accordi
finali della Bohème, è un vero delitto di lesa
musica! vocale
densa e di eccellente proiezione, di musicalità
precisa e sicura, unite ad una bravura scenica
che ha pochi termini di paragone in questo
momento in Italia. Hanno assolto appieno al loro
compito le parti di fianco: validi sia il
Colline di Abramo Ròsalen, basso, vecchia
conoscenza del pubblico novarese, che strappa un
meritato applauso colla sua unica aria “Vecchia
zimarra”, sia lo Schaunard del baritono Italo
Proferisce. Impeccabile vocalmente e comicamente
efficace il basso Matteo Mollica, nel duplice
ruolo di Benoit e di Alcindoro, così come ben
eseguita è stata la breve parte di Perpignol dal
tenore Zheng Hui, allievo della AMO, l’Accademia
dei Mestieri dell’Opera, aperta da qualche anno
presso il Coccia, come scuola di perfezionamento
per giovani che intendano dedicarsi a tutti i
mestieri legati al teatro d’Opera, dai cantanti
ai registi ai tecnici. Un’ altra bella
rappresentazione d’Opera al Coccia, che possiamo
ormai considerare un teatro lirico di qualità.
Il pubblico ha giustamente applaudito a lungo
cantanti, direttore, orchestra e regista,
dimostrando il suo gradimento. Una sola
osservazione: questo pubblico impari però a
moderare il proprio entusiasmo e a non
applaudire prima che la musica sia davvero
finita: coprire con gli applausi gli accordi
finali della Bohème, è un vero delitto di lesa
musica!
18 dicembre 2023 Bruno Busca
Thomas Guggeis
dirige Schumann e
Brahms in Auditorium
Un
impaginato tutto romantico, con importanti
lavori orchestrali quello offerto dall'Orchestra
Sinfonica di Milano per l'occasione diretta ieri
sera in Auditorium dal giovane direttore tedesco
Thomas Guggeis. In programma prima la
Sinfonia n.3 in Fa Maggiore op.90 di
Johannes Brahms, poi la Sinfonia n.3 in Mi
bem.
 Maggiore
op.97 "Renana" di Robert Schumann. Secondo
un ordine cronologico inverso, con una distanza
di oltre trent'anni dalle date di composizione -quella
brahmsiana del 1883 e quella schumanniana del
1850- abbiamo ascoltato prima la musica del
discepolo poi quella del Maestro in una
continuità di costruzioni armoniche ben
evidenziate dalla gestualità produttiva di
Guggeis. I quattro movimenti dell'Op.90
dell'amburghese, hanno trovato una valida resa
espressiva, maggiormente evidenziata nel noto
Poco allegretto e nell'incisivo e
scultoreo Maggiore
op.97 "Renana" di Robert Schumann. Secondo
un ordine cronologico inverso, con una distanza
di oltre trent'anni dalle date di composizione -quella
brahmsiana del 1883 e quella schumanniana del
1850- abbiamo ascoltato prima la musica del
discepolo poi quella del Maestro in una
continuità di costruzioni armoniche ben
evidenziate dalla gestualità produttiva di
Guggeis. I quattro movimenti dell'Op.90
dell'amburghese, hanno trovato una valida resa
espressiva, maggiormente evidenziata nel noto
Poco allegretto e nell'incisivo e
scultoreo
 Allegro
finale; mentre nell'Op.97, in cinque
movimenti, del sassone di Zwickau abbiamo
assistito ad una sintesi discorsiva ancora più
unitaria nell'evidenziare l'intreccio dei
diversi piani sonori che anticipano tutte le
architetture brahmsiane e che diventano
esemplari nella polifonia corale degli ultimi
due movimenti: il Solenne quarto
movimento e il Vivace-Presto quinto,
espressi con maestria e chiarezza dal gesto
sicuro di Guggeis e dagli ottimi orchestrali
della Sinfonica milanese, validi in tutte le
sezioni strumentali. Ricordiamo che Guggeis sarà
prossimamente alla direzione dell'orchestra
scaligera nel Ratto dal serraglio di
Mozart. La replica del concerto è per domenica
alle ore 16.00. Da non perdere!!! Allegro
finale; mentre nell'Op.97, in cinque
movimenti, del sassone di Zwickau abbiamo
assistito ad una sintesi discorsiva ancora più
unitaria nell'evidenziare l'intreccio dei
diversi piani sonori che anticipano tutte le
architetture brahmsiane e che diventano
esemplari nella polifonia corale degli ultimi
due movimenti: il Solenne quarto
movimento e il Vivace-Presto quinto,
espressi con maestria e chiarezza dal gesto
sicuro di Guggeis e dagli ottimi orchestrali
della Sinfonica milanese, validi in tutte le
sezioni strumentali. Ricordiamo che Guggeis sarà
prossimamente alla direzione dell'orchestra
scaligera nel Ratto dal serraglio di
Mozart. La replica del concerto è per domenica
alle ore 16.00. Da non perdere!!!
16 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
Luca Scarlini, Danae Rikos
e Maurizio Carnelli nel ricordo di una giovane
Maria Callas al MaMu
Un ottimo incontro quello cui
abbiamo assistito ieri nel tardo pomeriggio al
MaMu, il magazzino musica di via Soave 3. Luca
Scarlini, scrittore, drammaturgo e storyteller,
ha condotto l'incontro "Maria Callas.Ritratto
dell'artista da giovane" che prevedeva oltre
all'accurato intervento del simpatico attore,
anche l'ascolto di cinque
 brani tratti dal
repertorio giovanile della celebre cantante
di origine greca, nell'interpretazione del soprano
italo-greco Danae Rikos accompagnata al
pianoforte da Maurizio Carnelli. Gli efficaci
interventi di Scarlini, in alternanza ai brani,
hanno delineato ottimamente la figura della
Callas giovanissima, dal debutto ad Atene in
Cavalleria Rusticana nel 1938, all'età di 16
anni, sino al successo del '49 all'Arena di
Verona con Semiramide. Sono stati messi in luce
i problemi legati al suo pessimo rapporto con la
madre e le difficoltà iniziali nel trovare la
giusta strada per brani tratti dal
repertorio giovanile della celebre cantante
di origine greca, nell'interpretazione del soprano
italo-greco Danae Rikos accompagnata al
pianoforte da Maurizio Carnelli. Gli efficaci
interventi di Scarlini, in alternanza ai brani,
hanno delineato ottimamente la figura della
Callas giovanissima, dal debutto ad Atene in
Cavalleria Rusticana nel 1938, all'età di 16
anni, sino al successo del '49 all'Arena di
Verona con Semiramide. Sono stati messi in luce
i problemi legati al suo pessimo rapporto con la
madre e le difficoltà iniziali nel trovare la
giusta strada per il successo. La Rikos ha
cantato arie tratte da opere di Rossini, di
Suppé, di Beethoven, di Romberg e anche la
celebre e conclusiva "La Paloma" di Sebastián
Iradier . Accompagnata in modo disinvolto da
Carnelli ha rivelato un ottimo timbro, corposo,
ben particolareggiato e ricco di espressività.
Tra i brani più noti ottimi Bel raggio
lusinghier da Semiramide di Rossini, Hab
ich nur deine Liebe da Boccaccio di Suppé e
O wär ich schön dal Fidelio di Beethoven.
Un tardo pomeriggio interessante, piacevole e
molto applaudito dai numerosi intervenuti. il successo. La Rikos ha
cantato arie tratte da opere di Rossini, di
Suppé, di Beethoven, di Romberg e anche la
celebre e conclusiva "La Paloma" di Sebastián
Iradier . Accompagnata in modo disinvolto da
Carnelli ha rivelato un ottimo timbro, corposo,
ben particolareggiato e ricco di espressività.
Tra i brani più noti ottimi Bel raggio
lusinghier da Semiramide di Rossini, Hab
ich nur deine Liebe da Boccaccio di Suppé e
O wär ich schön dal Fidelio di Beethoven.
Un tardo pomeriggio interessante, piacevole e
molto applaudito dai numerosi intervenuti.
15 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
AL FESTIVAL CANTELLI DI
NOVARA TRA VIVALDI E BACH TRIONFA IL TANGO DI
ALESSANDRO QUARTA
Ieri sera, 14/12, al Teatro
Faraggiana di Novara, il nuovo appuntamento
della stagione del Festival Cantelli ha proposto
un concerto all’insegna dell’originalità, con
protagonisti musicisti tra i più noti nel mondo
italiano della ‘classica’, ma non solo, del
momento. Anzitutto i due fratelli Massimo e
Alessandro Quarta, entrambi violinisti, che da
qualche tempo hanno deciso di ‘fare coppia’.
Coppia che, già di per sé, si presenta come
piuttosto singolare, per formazione, personalità,
figura professionale. Massimo Quarta, già noto
al pubblico novarese, è uno dei violinisti più
quotati in Italia e all’estero, secondo (dopo
Accardo) a vincere, nel 1991, il prestigioso
premio Paganini. Da alcuni anni alterna i
recital al violino con la direzione d’orchestra,
con buon successo anche in quest’ultima.
Alessandro Quarta, di undici anni più giovane di
Massimo, è, oltre che un violinista, un ‘personaggio’,
che ha acquisito da qualche tempo anche in
Italia quella notorietà di cui già gode
all’estero. Fondamentalmente è la presenza di
questo ‘personaggio’ a imprimere alla serata
quel carattere di
 originalità
che l’ha contraddistinta. Alessandro Quarta
esibisce la propria personalità singolare già
col suo abbigliamento, poco ‘concertistico, a
differenza del fratello. Ma la particolarità che
più colpisce di Quarta junior è la varietà, che
sfiora l’eclettismo, della sua attività: oltre
che musicista (violinista e compositore),
Alessandro Quarta è anche attore, teatrale e
cinematografico, nonché doppiatore; tra l’altro,
dal 1995 è il doppiatore della voce di Topolino
di Disney. Infine la sua originalità sta anche
nella sua figura stessa di musicista: vanta
infatti una rigorosa formazione di violinista,
con studi con Salvatore Accardo e altri grandi
violinisti, accompagnata da severi studi di
filologia musicale e musica medievale a Cremona.
Ma su questa base di studi altamente qualificati,
Alessandro Quarta ha poi innestato l’apporto di
altre esperienze, dal jazz al rock alla
collaborazione con una cantautrice di razza come
Giovanna Marini. ‘Estro armonico’, il titolo
della raccolta di concerti di Vivaldi da cui è
tratto il primo brano in programma, ben si
adatta a presentare la personalità musicale di
Alessandro Quarta. Il terzo protagonista di
questo concerto è un musicista altrettanto
celebre dei primi due: Simonide Braconi,
violista tra i più grandi oggi in Italia, prima
viola alla Scala, e compositore, soprattutto, ma
non solo, per il suo strumento. A Novara era
presente in veste di Direttore cui per
l’occasione era affidata l’orchestra dei Solisti
Aquilani, che, nati con il contributo decisivo
di Goffredo Petrassi nel 1968, vantano ormai una
presenza consolidata e di ottimo livello sulla
scena musicale italiana. L’impaginato della
serata presentava due concerti tra i più belli e
famosi per due violini e orchestra, il Concerto
in La minore per due violini, archi e basso
continuo op.3 n.8 RV522 di Antonio Vivaldi
(1711) e il Concerto in Re minore per due
violini, archi e basso continuo BWV 1043, di
J.S. Bach (1718-23). Accanto a questi due
capolavori del passato, tre pezzi contemporanei,
anch’essi per due violini e archi, scritti da
due dei musicisti protagonisti della serata: S.
Braconi e Alessandro Quarta. I due fratelli
Quarta si avvicendano nel ruolo di primo e
secondo violino, mentre Braconi sale sul podio
per dirigere i tre pezzi contemporanei. Il
concerto di Vivaldi originalità
che l’ha contraddistinta. Alessandro Quarta
esibisce la propria personalità singolare già
col suo abbigliamento, poco ‘concertistico, a
differenza del fratello. Ma la particolarità che
più colpisce di Quarta junior è la varietà, che
sfiora l’eclettismo, della sua attività: oltre
che musicista (violinista e compositore),
Alessandro Quarta è anche attore, teatrale e
cinematografico, nonché doppiatore; tra l’altro,
dal 1995 è il doppiatore della voce di Topolino
di Disney. Infine la sua originalità sta anche
nella sua figura stessa di musicista: vanta
infatti una rigorosa formazione di violinista,
con studi con Salvatore Accardo e altri grandi
violinisti, accompagnata da severi studi di
filologia musicale e musica medievale a Cremona.
Ma su questa base di studi altamente qualificati,
Alessandro Quarta ha poi innestato l’apporto di
altre esperienze, dal jazz al rock alla
collaborazione con una cantautrice di razza come
Giovanna Marini. ‘Estro armonico’, il titolo
della raccolta di concerti di Vivaldi da cui è
tratto il primo brano in programma, ben si
adatta a presentare la personalità musicale di
Alessandro Quarta. Il terzo protagonista di
questo concerto è un musicista altrettanto
celebre dei primi due: Simonide Braconi,
violista tra i più grandi oggi in Italia, prima
viola alla Scala, e compositore, soprattutto, ma
non solo, per il suo strumento. A Novara era
presente in veste di Direttore cui per
l’occasione era affidata l’orchestra dei Solisti
Aquilani, che, nati con il contributo decisivo
di Goffredo Petrassi nel 1968, vantano ormai una
presenza consolidata e di ottimo livello sulla
scena musicale italiana. L’impaginato della
serata presentava due concerti tra i più belli e
famosi per due violini e orchestra, il Concerto
in La minore per due violini, archi e basso
continuo op.3 n.8 RV522 di Antonio Vivaldi
(1711) e il Concerto in Re minore per due
violini, archi e basso continuo BWV 1043, di
J.S. Bach (1718-23). Accanto a questi due
capolavori del passato, tre pezzi contemporanei,
anch’essi per due violini e archi, scritti da
due dei musicisti protagonisti della serata: S.
Braconi e Alessandro Quarta. I due fratelli
Quarta si avvicendano nel ruolo di primo e
secondo violino, mentre Braconi sale sul podio
per dirigere i tre pezzi contemporanei. Il
concerto di Vivaldi
 vede
il secondo violino (Alessandro Quarta) con una
funzione non solo di sostegno e accompagnamento,
ma con un sua voce ‘autonoma’, specie
nell’Allegro finale dove è proprio il secondo
violino ad imprimere, in uno dei principali
episodi melodici, il suo dolcissimo profilo
sonoro, con una vena di nobile pathos, mettendo
in luce le qualità interpretative del più
giovane dei due fratelli Quarta, mentre Massimo
dà prova ancora una volta della sublime eleganza
e della chiarezza della sua cavata di suono,
particolarmente adatta al luminoso mondo
musicale di Vivaldi. In generale è stato un
bellissimo Vivaldi, questo eseguito dai Solisti
aquilani e dai due Quarta, che del mondo sonoro
del grande veneziano hanno espresso al meglio la
solare vitalità, col ritmo trascinante dei
ritornelli dei tempi veloci, affidati al ‘tutto’
orchestrale, e con gli episodi eseguiti dai due
violini ( secondo la tipica struttura del
Concerto Grosso barocco), anch’essi su tempi
molto rapidi e con varie figurazioni di
abbellimento, per entrambi i violini solisti.,
eccellenti nel mettere a fuoco i dettagli
timbrici e nel calibrare le dinamiche, in
particolare nell’Allegretto, che è un autentico
duetto cantabile da brano d’opera, dove i due
violini raggiungono una dolcezza espressiva che
incanta l’ascoltatore. A Vivaldi è subito
seguito il pezzo di Braconi, che pure, nel
titolo sembra rimandare al mondo musicale
barocco: Suite, ma una Suite di Contrasti, come
sempre suggerisce il titolo. In effetti brusco è
il contrasto tra il primo movimento della
Suite,” Preludio”, in cui i due violini evocano
volute sonore di raffinata dolcezza, su un
accompagnamento quasi in sordina dell’orchestra,
e il successivo Danza. vede
il secondo violino (Alessandro Quarta) con una
funzione non solo di sostegno e accompagnamento,
ma con un sua voce ‘autonoma’, specie
nell’Allegro finale dove è proprio il secondo
violino ad imprimere, in uno dei principali
episodi melodici, il suo dolcissimo profilo
sonoro, con una vena di nobile pathos, mettendo
in luce le qualità interpretative del più
giovane dei due fratelli Quarta, mentre Massimo
dà prova ancora una volta della sublime eleganza
e della chiarezza della sua cavata di suono,
particolarmente adatta al luminoso mondo
musicale di Vivaldi. In generale è stato un
bellissimo Vivaldi, questo eseguito dai Solisti
aquilani e dai due Quarta, che del mondo sonoro
del grande veneziano hanno espresso al meglio la
solare vitalità, col ritmo trascinante dei
ritornelli dei tempi veloci, affidati al ‘tutto’
orchestrale, e con gli episodi eseguiti dai due
violini ( secondo la tipica struttura del
Concerto Grosso barocco), anch’essi su tempi
molto rapidi e con varie figurazioni di
abbellimento, per entrambi i violini solisti.,
eccellenti nel mettere a fuoco i dettagli
timbrici e nel calibrare le dinamiche, in
particolare nell’Allegretto, che è un autentico
duetto cantabile da brano d’opera, dove i due
violini raggiungono una dolcezza espressiva che
incanta l’ascoltatore. A Vivaldi è subito
seguito il pezzo di Braconi, che pure, nel
titolo sembra rimandare al mondo musicale
barocco: Suite, ma una Suite di Contrasti, come
sempre suggerisce il titolo. In effetti brusco è
il contrasto tra il primo movimento della
Suite,” Preludio”, in cui i due violini evocano
volute sonore di raffinata dolcezza, su un
accompagnamento quasi in sordina dell’orchestra,
e il successivo Danza.
 E’
questo un pezzo fatto di brevi incisi tematici,
nervoso ed inquieto, di una certa complessità
armonica e tecnica, ricco di passaggi in doppie
corde e pizzicati per i violini, da cui si viene
come delineando gradualmente un ritmo puntato di
danza, affidato all’orchestra, che presto
coinvolge i violini in una tensione agogica
crescente, con passaggi sempre più rapidi. La
bravura tecnica di Massimo e Alessandro Quarta,
unita alla perfetta direzione orchestrale di
Braconi, calibratissima nelle dinamiche, ha
offerto una bella interpretazione del pezzo. Si
torna di nuovo al passato con il concerto per
due violini BWV 1043 di J.S. Bach. Il modello
del concerto per violino di Bach è, notoriamente
quello vivaldiano, ma con un irrobustimento
contrappuntistico della parte orchestrale ignoto
a Vivaldi. Ne consegue un ritornello più
complesso strutturalmente e una sonorità più
compatta della composizione, in quanto
l’orchestra, a differenza di quanto avviene in
Vivaldi, non si ritira in buon ordine quando
vengono in primo piano gli strumenti solistici
coi loro episodi, ma intreccia le sue linee
musicali con quelle dei solisti, a loro volta
chiamati a confrontarsi con una scrittura più
densa di quella assegnata loro dal Maestro
veneziano e con un ruolo paritario, tanto che
Bach li chiama “violini concertanti”. Proprio
questa più robusta densità di scrittura
interpretano benissimo, ancora una volta I
Solisti Aquilani. Nel Vivace iniziale, che è
niente di meno che una Fuga, di cui i ritornelli
orchestrali presentano il soggetto, sono
bravissimi Massimo e Alessandro Quarta a dare
piena corposità al suono dei due violini,
sfruttando tutte le risorse della scrittura
imitativa loro assegnata, spesso inseguendosi a
canone e riprendendo materiale ‘fugato’ del
ritornello. Sempre secondo una tecnica
compositiva a canone, i due Quarta nel Largo, ma
non tanto centrale, intrecciano con perfetta
calibratura di tempi e dinamiche, le morbide
tessiture sonore di una melodia dalla tranquilla
cantabilità, accompagnati dalla pulsazione
ritmica dell’orchestra, centellinata con rara
finezza dai Solisti Aquilani. La fusione tra
stile contrappuntistico e quello concertante
raggiunge poi il suo culmine con l’Allegro
finale, ove l’intesa assoluta tra orchestra e
solisti, e la chiarezza luminosa del suono
dell’insieme, presentano all’ascoltatore un
mondo sonoro di compiuta coesione formale, E’
questo un pezzo fatto di brevi incisi tematici,
nervoso ed inquieto, di una certa complessità
armonica e tecnica, ricco di passaggi in doppie
corde e pizzicati per i violini, da cui si viene
come delineando gradualmente un ritmo puntato di
danza, affidato all’orchestra, che presto
coinvolge i violini in una tensione agogica
crescente, con passaggi sempre più rapidi. La
bravura tecnica di Massimo e Alessandro Quarta,
unita alla perfetta direzione orchestrale di
Braconi, calibratissima nelle dinamiche, ha
offerto una bella interpretazione del pezzo. Si
torna di nuovo al passato con il concerto per
due violini BWV 1043 di J.S. Bach. Il modello
del concerto per violino di Bach è, notoriamente
quello vivaldiano, ma con un irrobustimento
contrappuntistico della parte orchestrale ignoto
a Vivaldi. Ne consegue un ritornello più
complesso strutturalmente e una sonorità più
compatta della composizione, in quanto
l’orchestra, a differenza di quanto avviene in
Vivaldi, non si ritira in buon ordine quando
vengono in primo piano gli strumenti solistici
coi loro episodi, ma intreccia le sue linee
musicali con quelle dei solisti, a loro volta
chiamati a confrontarsi con una scrittura più
densa di quella assegnata loro dal Maestro
veneziano e con un ruolo paritario, tanto che
Bach li chiama “violini concertanti”. Proprio
questa più robusta densità di scrittura
interpretano benissimo, ancora una volta I
Solisti Aquilani. Nel Vivace iniziale, che è
niente di meno che una Fuga, di cui i ritornelli
orchestrali presentano il soggetto, sono
bravissimi Massimo e Alessandro Quarta a dare
piena corposità al suono dei due violini,
sfruttando tutte le risorse della scrittura
imitativa loro assegnata, spesso inseguendosi a
canone e riprendendo materiale ‘fugato’ del
ritornello. Sempre secondo una tecnica
compositiva a canone, i due Quarta nel Largo, ma
non tanto centrale, intrecciano con perfetta
calibratura di tempi e dinamiche, le morbide
tessiture sonore di una melodia dalla tranquilla
cantabilità, accompagnati dalla pulsazione
ritmica dell’orchestra, centellinata con rara
finezza dai Solisti Aquilani. La fusione tra
stile contrappuntistico e quello concertante
raggiunge poi il suo culmine con l’Allegro
finale, ove l’intesa assoluta tra orchestra e
solisti, e la chiarezza luminosa del suono
dell’insieme, presentano all’ascoltatore un
mondo sonoro di compiuta coesione formale,
 e
di sublime razionalità. Concludevano la serata
due pezzi di Alessandro Quarta. Il primo,
MassiTango, dove quel ‘Massi” sta per ‘Massimo’,
cui l’opera è affettuosamente dedicata., è un
pezzo di musica brillante, una sorta di ‘invito
alla danza’ rivolto a un numeroso pubblico.
Introdotto da una breve serie di accordi
strappati dell’orchestra, questa svolge poi un
motivo ostinato su cui i due violini intessono
le loro linee melodiche di sapiente varietà
agogica, ritmica e dinamica, in cui si esprime
tutta la bravura dei due fratelli Quarta. Il
secondo, la suite dal titolo vagamente alla
Dario Argento “Dysturbia”, è diviso in tre
movimenti. Nei due esterni, Dysturbia e
Tarantula (in quest’ultimo titolo è ovvia
l’allusione al delirante romanzo di Bob Dylan
del 1971) abbondano acrobazie virtuosistiche per
i due solisti, quasi una sfida tra i due
violinisti, all’insegna della spettacolarità,
mentre il brano centrale, “Romeo e Giulietta”, è
un Andante di melodiosa cantabilità, in cui il
G. A. Rocca 1840 di Massimo e non sappiamo se il
Gagliano 1723 o il Guadagnini 1761, i due
strumenti coi quali abitualmente suona
Alessandro, intrecciavano i loro limpidi e
calibrati fraseggi con finezza e alta
sensibilità espressiva. Il concerto è piaciuto
molto al pubblico, che ha applaudito a lungo
solisti, direttore e orchestra, che hanno
concesso un bis, naturalmente un altro tango (crediamo
di Alessandro Quarta), al termine del quale gli
applausi sono esplosi ancora più lunghi e
scroscianti. Un altro concerto di successo
offerto dagli Amici della musica al pubblico
novarese. e
di sublime razionalità. Concludevano la serata
due pezzi di Alessandro Quarta. Il primo,
MassiTango, dove quel ‘Massi” sta per ‘Massimo’,
cui l’opera è affettuosamente dedicata., è un
pezzo di musica brillante, una sorta di ‘invito
alla danza’ rivolto a un numeroso pubblico.
Introdotto da una breve serie di accordi
strappati dell’orchestra, questa svolge poi un
motivo ostinato su cui i due violini intessono
le loro linee melodiche di sapiente varietà
agogica, ritmica e dinamica, in cui si esprime
tutta la bravura dei due fratelli Quarta. Il
secondo, la suite dal titolo vagamente alla
Dario Argento “Dysturbia”, è diviso in tre
movimenti. Nei due esterni, Dysturbia e
Tarantula (in quest’ultimo titolo è ovvia
l’allusione al delirante romanzo di Bob Dylan
del 1971) abbondano acrobazie virtuosistiche per
i due solisti, quasi una sfida tra i due
violinisti, all’insegna della spettacolarità,
mentre il brano centrale, “Romeo e Giulietta”, è
un Andante di melodiosa cantabilità, in cui il
G. A. Rocca 1840 di Massimo e non sappiamo se il
Gagliano 1723 o il Guadagnini 1761, i due
strumenti coi quali abitualmente suona
Alessandro, intrecciavano i loro limpidi e
calibrati fraseggi con finezza e alta
sensibilità espressiva. Il concerto è piaciuto
molto al pubblico, che ha applaudito a lungo
solisti, direttore e orchestra, che hanno
concesso un bis, naturalmente un altro tango (crediamo
di Alessandro Quarta), al termine del quale gli
applausi sono esplosi ancora più lunghi e
scroscianti. Un altro concerto di successo
offerto dagli Amici della musica al pubblico
novarese.
15 dicembre 2023 Bruno Busca
L'orchestra
WPR di
Reutlingen diretta da Ariane Matiakh alla
Società dei Concerti
Doveva
esserci al pianoforte Antonio Chen Guag al
concerto di ieri sera in Conservatorio. Problemi
seri famigliari hanno costretto la Società
dei Concerti ad un urgente cambiamento
solistico trovando la disponibilità della
pianista Ying Li. Recentemente Ying Li ha
effettuato un giro concertistico in Italia e, a
Vercelli ha tenuto uno
 splendido
concerto recesinto nel nostro giornale nei
paragrafi sottostanti. Il programma classico di
Sala Verdi prevedeva musiche di Haydn, Mozart e
Beethoven, i maggiori esponenti del classicismo
musicale. La Württembergische Philharmonie
Reutlingen (WPR) ha dallo scorso anno il
nuovo direttore musicale in Ariane Matiakh, una
direttrice francese affermata e per la prima
volta in una direzione a Milano. Il brano
introduttivo di F.J. Haydn, l'Ouverture "L'isola
disabitata" (1779) ha introdotto il concerto
rivelando nello spirito classico di grande
equilibrio, le doti dell'orchestra e del
direttore. Il secondo brano di W.A.Mozart, tra i
più eseguiti al mondo, era il Concerto in re
minore K 466 per pianoforte e orchestra
(1785) . La notorietà di questo lavoro
interpretato dai più splendido
concerto recesinto nel nostro giornale nei
paragrafi sottostanti. Il programma classico di
Sala Verdi prevedeva musiche di Haydn, Mozart e
Beethoven, i maggiori esponenti del classicismo
musicale. La Württembergische Philharmonie
Reutlingen (WPR) ha dallo scorso anno il
nuovo direttore musicale in Ariane Matiakh, una
direttrice francese affermata e per la prima
volta in una direzione a Milano. Il brano
introduttivo di F.J. Haydn, l'Ouverture "L'isola
disabitata" (1779) ha introdotto il concerto
rivelando nello spirito classico di grande
equilibrio, le doti dell'orchestra e del
direttore. Il secondo brano di W.A.Mozart, tra i
più eseguiti al mondo, era il Concerto in re
minore K 466 per pianoforte e orchestra
(1785) . La notorietà di questo lavoro
interpretato dai più
 grandi
pianisti della storia, la si deve alla profonda
espressività dei temi nell'esprimere una
drammaticità che anticipa di alcuni decenni
modalità tipiche del romanticismo. Il taglio
iniziale, particolarmente riflessivo nella
direzione della Matiakh è stato accolto dalla
pianista attraverso un'esecuzione lineare,
chiara e ben articolata nell'adeguata
espressività. Di rilievo le corpose cadenze
solistiche dell' Allegro iniziale e del
Rondò finale, movimento quest'ultimo che
alternando il minore con il maggiore trova
frangenti d'ottimismo in contrasto con i primi
due movimenti. grandi
pianisti della storia, la si deve alla profonda
espressività dei temi nell'esprimere una
drammaticità che anticipa di alcuni decenni
modalità tipiche del romanticismo. Il taglio
iniziale, particolarmente riflessivo nella
direzione della Matiakh è stato accolto dalla
pianista attraverso un'esecuzione lineare,
chiara e ben articolata nell'adeguata
espressività. Di rilievo le corpose cadenze
solistiche dell' Allegro iniziale e del
Rondò finale, movimento quest'ultimo che
alternando il minore con il maggiore trova
frangenti d'ottimismo in contrasto con i primi
due movimenti.
 Ottima
l'interpretazione complessiva e di raffinato
virtuosismo il bis concesso da Ying Li con il
celebre Tic Toc Choc di François
Couperin. Dopo il breve intervallo l'arcinota
pacata Sinfonia n.6 in fa maggiore op.68
(1807-1808) di L.W. Beethoven ha trovato un
equilibrato sviluppo tra i cinque movimenti che
formano la celebre composizione. Applausi
calorosi in una serata che ha visto anche un
momento di piacevole intrattenimento con gli
eccellenti cioccolatini offerti dal maestro
pasticcere Enrico Rizzi. Ottima
l'interpretazione complessiva e di raffinato
virtuosismo il bis concesso da Ying Li con il
celebre Tic Toc Choc di François
Couperin. Dopo il breve intervallo l'arcinota
pacata Sinfonia n.6 in fa maggiore op.68
(1807-1808) di L.W. Beethoven ha trovato un
equilibrato sviluppo tra i cinque movimenti che
formano la celebre composizione. Applausi
calorosi in una serata che ha visto anche un
momento di piacevole intrattenimento con gli
eccellenti cioccolatini offerti dal maestro
pasticcere Enrico Rizzi.
14 dicembre 2023 Cesare Guzzardella
Il violinista Augustin
Hadelich alle Serate Musicali del
Conservatorio
Per la
prima volta a Serate Musicali, il
violinista Augustin Hadelich è nato in Italia da
genitori tedeschi. L'ottimo impaginato prevedeva
lateralmente due Partite per violino solo
di J.S. Bach e centralmente, due brani
contemporanei seguiti da una Sonata di Ysaýe. La
Partita n.3 in mi maggiore BWV 1006 ha
introdotto la serata rivelandoci da subito la
cifra stilistica del trentanovenne virtuoso che
abitualmente usa il violino Guarneri del Gesu
del 1744
 "Leduc ex Szeryng". Il primo brano
bachiano ha messo in evidenza non solo la
timbrica profonda del prezioso strumento, ma
anche le doti virtuosistiche di Hadelich,
giocate su una luminosità coloristica e una
discorsività di fraseggio che hanno esaltatato i
sette movimenti che compongono la Partita ad
iniziare del noto Preludio, per terminare
alla Giga. Il secondo brano,
interessantissimo, denominato Blue/s Forms
è un lavoro del 1972 dello statunitense
Coleridge-Taylor Perkinson (1932-2004), un
compositore-pianista classico molto legato al
jazz, che ha trovato nei tre momenti musicali -
Plain, Just e Jettin Blue/s- un modo per
delineare le marcate e raffinate sonorità di un
mondo apparentemente lontano dal classicismo ma
che invece, come già in passato fece Ravel col
suo celebre Blues dalla Sonata n.2 , è
particolarmente vicino alla musica colta.
Mirabili le raffinate timbriche esternate in
questo valido lavoro. Il successivo brano di
David Lang - statinitense del 1957- , Before
Sorrow, è estrapolato dalla Sonata n.3
"Mystery Sonatas" ( 2014) e rivela una
costruzione dal sapore minimalista che utilizza
poche note ripetute e variate. Un buon lavoro
che Hadelich ha voluto legare, senza
interruzione, alla più celebre Sonata n.3 in
re minore op.27- Ballade, del grande
compositore e virtuoso del violino Eugène Ysaýe. "Leduc ex Szeryng". Il primo brano
bachiano ha messo in evidenza non solo la
timbrica profonda del prezioso strumento, ma
anche le doti virtuosistiche di Hadelich,
giocate su una luminosità coloristica e una
discorsività di fraseggio che hanno esaltatato i
sette movimenti che compongono la Partita ad
iniziare del noto Preludio, per terminare
alla Giga. Il secondo brano,
interessantissimo, denominato Blue/s Forms
è un lavoro del 1972 dello statunitense
Coleridge-Taylor Perkinson (1932-2004), un
compositore-pianista classico molto legato al
jazz, che ha trovato nei tre momenti musicali -
Plain, Just e Jettin Blue/s- un modo per
delineare le marcate e raffinate sonorità di un
mondo apparentemente lontano dal classicismo ma
che invece, come già in passato fece Ravel col
suo celebre Blues dalla Sonata n.2 , è
particolarmente vicino alla musica colta.
Mirabili le raffinate timbriche esternate in
questo valido lavoro. Il successivo brano di
David Lang - statinitense del 1957- , Before
Sorrow, è estrapolato dalla Sonata n.3
"Mystery Sonatas" ( 2014) e rivela una
costruzione dal sapore minimalista che utilizza
poche note ripetute e variate. Un buon lavoro
che Hadelich ha voluto legare, senza
interruzione, alla più celebre Sonata n.3 in
re minore op.27- Ballade, del grande
compositore e virtuoso del violino Eugène Ysaýe.
 Un unico tempo che partendo da esperienze
paganiniane esalta sia le qualità del
compositore belga che quelle virtuosistiche
dell'interprete. Anche in questi brani, Hadelich
ha esternato un virtuosismo ridotto
all'essenziale da una leggerezza di cavata che
apporta sensibili contrasti ben delineati. Dopo
il breve intervallo, la Partita n.2 in re
minore BWV 1004, quella più nota di Bach per
via del geniale ultimo movimento - la
celeberrima Chaconne- ha concluso il
programma ufficiale. La limpida discorsività dei
primi quattro movimenti - Allemande,
Courante, Sarabande e Giga- ha
trovato conclusione con la contrastata e ricca
di variazioni Choconne, un lungo
movimento esaltato dalla pregnante resa
espressiva di Hadelich, attento ad ogni
dettaglio e perfetto nei minimi cambiamenti
coloristici. Un'interpretazione di altissimo
livello la sua, molto apprezzata dal pubblico,
purtroppo non numeroso in Sala Verdi, che al
termine ha tributato in piedi applausi
prolungati e calorosi. Di ottima qualità il bis
bachiano proposto con l'Andante dalla
Sonata n.2 in la minore. Un grande virtuoso
Augustin Hadelich. Un unico tempo che partendo da esperienze
paganiniane esalta sia le qualità del
compositore belga che quelle virtuosistiche
dell'interprete. Anche in questi brani, Hadelich
ha esternato un virtuosismo ridotto
all'essenziale da una leggerezza di cavata che
apporta sensibili contrasti ben delineati. Dopo
il breve intervallo, la Partita n.2 in re
minore BWV 1004, quella più nota di Bach per
via del geniale ultimo movimento - la
celeberrima Chaconne- ha concluso il
programma ufficiale. La limpida discorsività dei
primi quattro movimenti - Allemande,
Courante, Sarabande e Giga- ha
trovato conclusione con la contrastata e ricca
di variazioni Choconne, un lungo
movimento esaltato dalla pregnante resa
espressiva di Hadelich, attento ad ogni
dettaglio e perfetto nei minimi cambiamenti
coloristici. Un'interpretazione di altissimo
livello la sua, molto apprezzata dal pubblico,
purtroppo non numeroso in Sala Verdi, che al
termine ha tributato in piedi applausi
prolungati e calorosi. Di ottima qualità il bis
bachiano proposto con l'Andante dalla
Sonata n.2 in la minore. Un grande virtuoso
Augustin Hadelich.
12 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
Straordinario successo
alla seconda
rappresentazione di Don Carlo al Teatro alla
Scala
Si è
già molto parlato in questi giorni del Don Carlo
verdiano che il 7 dicembre ha inaugurato al
Teatro alla Scala la nuova stagione operistica:
le recensioni apparse già dalla mattina
successiva online e sui quotidiani cartacei non
ne hanno fornito opinioni univoche. Dopo aver
seguito l'ottima ripresa televisiva in diretta,
trasmessa in 4K e con un audio forse migliore
del solito ma ancora non adeguato, ed essere
stato presente alla Seconda rappresentazione,
nel
 pomeriggio
di domenica 10, di fronte al medesimo cast
vocale, in un teatro ancora al completo, ho
potuto cogliere aspetti differenti e al contempo
coesi. Ritengo che la versione italiana voluta
da Verdi nel 1884 in quattro atti, presentata
con la direzione musicale di Riccardo Chailly e
la regia di Lluìs Pasqual, sia stata ottima:
l'entusiasmo del pubblico di ieri, in un teatro
ancora al completo, non ha lasciato dubbi
sull'efficacia dell'orchestrazione di Chailly,
che ha esaltato, in questa non facile opera
dalle tinte scure, le timbriche più gravi
dell'eccellente compagine scaligera. Alcuni
aspetti non del tutto convincenti della
messinscena, oggetto di critiche eccessive di
qualche loggionista alla Prima, ieri sono stati
dimenticati; si è assistito ad un Don Carlo di
altissimo livello, con un cast di voci esemplare,
anche più sicuro rispetto al 7 dicembre. Il Coro
preparato da Alberto Malazzi è stato come sempre
straordinario. pomeriggio
di domenica 10, di fronte al medesimo cast
vocale, in un teatro ancora al completo, ho
potuto cogliere aspetti differenti e al contempo
coesi. Ritengo che la versione italiana voluta
da Verdi nel 1884 in quattro atti, presentata
con la direzione musicale di Riccardo Chailly e
la regia di Lluìs Pasqual, sia stata ottima:
l'entusiasmo del pubblico di ieri, in un teatro
ancora al completo, non ha lasciato dubbi
sull'efficacia dell'orchestrazione di Chailly,
che ha esaltato, in questa non facile opera
dalle tinte scure, le timbriche più gravi
dell'eccellente compagine scaligera. Alcuni
aspetti non del tutto convincenti della
messinscena, oggetto di critiche eccessive di
qualche loggionista alla Prima, ieri sono stati
dimenticati; si è assistito ad un Don Carlo di
altissimo livello, con un cast di voci esemplare,
anche più sicuro rispetto al 7 dicembre. Il Coro
preparato da Alberto Malazzi è stato come sempre
straordinario.
 La
direzione di Chailly, analitica,
particolareggiata, legata anche alla componente
recitativa degli attori-cantanti, ha trovato un
ottimo equilibrio nei tempi, nelle timbriche
ottenute in modo esaustivo da tutte le sezioni
orchestrali. Valido anche il contesto scenico di
Daniel Bianco, adeguati i costumi di Franca
Squarciapino perfettamente inseriti nel contesto
storico dei personaggi. L'operazione minimale
registica di Lluís Pasqual è da non
sottovalutare come scelta drammaturgica, in
grado di esaltare i singoli artisti, tutti con
lo stesso peso e con una suddivisione di parti
cantate molto equilibrate. Il risultato
complessivo è certamente dato dalla media di
tutte le componenti dello straordinario lavoro
collettivo, e ad ognuno si deve il merito di
aver realizzato un lavoro molto unitario, La
direzione di Chailly, analitica,
particolareggiata, legata anche alla componente
recitativa degli attori-cantanti, ha trovato un
ottimo equilibrio nei tempi, nelle timbriche
ottenute in modo esaustivo da tutte le sezioni
orchestrali. Valido anche il contesto scenico di
Daniel Bianco, adeguati i costumi di Franca
Squarciapino perfettamente inseriti nel contesto
storico dei personaggi. L'operazione minimale
registica di Lluís Pasqual è da non
sottovalutare come scelta drammaturgica, in
grado di esaltare i singoli artisti, tutti con
lo stesso peso e con una suddivisione di parti
cantate molto equilibrate. Il risultato
complessivo è certamente dato dalla media di
tutte le componenti dello straordinario lavoro
collettivo, e ad ognuno si deve il merito di
aver realizzato un lavoro molto unitario,
 cosa
che non sempre accade. Tra i validissimi
protagonisti, eccelle Anna Netrebko, una
Elisabetta di Valois dalla voce stupenda, di
grande naturalezza, con frangenti eccelsi ricchi
di sfumature nei due atti finali. Di grande
pregio le voci di Elina Garanča,
la principessa
d'Eboli e di Luca
Salsi, Rodrigo il Marchese di Posa.
Applausi meritatissimi a Michele Pertusi,
Filippo II , ieri in perfetta forma, e a
Francesco Meli, un Don Carlo di alto
livello. Migliore che alla Prima la voce di
Jongmin Park nel doppio ruolo del Grande
Inquisitore e del Frate. Naturalmente
bravissimi gli altri. Ricordiamo le prossime
repliche previste per il 13-16-19-22-30 dicembre
e 2 gennaio. Nelle ultime due recite Maria José
Siri sostituirà la Netrebko e Veronica Simeoni
la Garanča.
( Foto di Brescia e Amisano da Ufficio Stampa
Teatro alla Scala) cosa
che non sempre accade. Tra i validissimi
protagonisti, eccelle Anna Netrebko, una
Elisabetta di Valois dalla voce stupenda, di
grande naturalezza, con frangenti eccelsi ricchi
di sfumature nei due atti finali. Di grande
pregio le voci di Elina Garanča,
la principessa
d'Eboli e di Luca
Salsi, Rodrigo il Marchese di Posa.
Applausi meritatissimi a Michele Pertusi,
Filippo II , ieri in perfetta forma, e a
Francesco Meli, un Don Carlo di alto
livello. Migliore che alla Prima la voce di
Jongmin Park nel doppio ruolo del Grande
Inquisitore e del Frate. Naturalmente
bravissimi gli altri. Ricordiamo le prossime
repliche previste per il 13-16-19-22-30 dicembre
e 2 gennaio. Nelle ultime due recite Maria José
Siri sostituirà la Netrebko e Veronica Simeoni
la Garanča.
( Foto di Brescia e Amisano da Ufficio Stampa
Teatro alla Scala)
11 dicembre 2023
Cesare Guzzardella
PER
IL FESTIVALVIOTTI
A VERCELLI RECITAL DELLA PIANISTA YING LI
Ieri sera, 9 dicembre, il
Teatro Civico, abituale sala da concerto per il
FestivalViotti, ha visto il gradito ritorno a
Vercelli della venticinquenne pianista
sino-americana Ying Li. Nascita e formazione in
Cina, perfezionamento negli Usa, presso Istituti
di assoluto prestigio come il Curtis e la
Julliard School, Ying Li è stata ‘lanciata’ in
Italia dalla Società dei Concerti di Milano, che
due anni fa l’ha insignita del primo premio al
concorso Antonio Mormone. Da quel momento la sua
fama nel nostro Paese, e non solo, non ha fatto
che aumentare. Il programma con cui Ying Li si è
presentata al pubblico di Vercelli era vario e
ben assortito, abbracciando un arco temporale
che dal ‘700 di Couperin e G.B. Viotti,
attraverso l’800 di Liszt, si estendeva sino al
‘900 di Ravel, Prokofiev, Bartok .Ottimo il
biglietto di presentazione della giovane
pianista: i due Pieces de Clavecin di Couperin,
con cui è cominciato il recital, Soeur Monique e
Le Tic-Toc-Choc, entrambi dell’Ordre 18, sono
stati eseguiti da Ying Li con un fraseggio di
squisita limpidezza, di eleganza trasparente e
leggera, che ha interpretato alla perfezione
l’incantevole grazia e l’esprit de clarté che
sono i caratteri tipici di questa musica. Che Ying
Li abbia un suo stile interpretativo e non si
confonda con la folla crescente di pianisti
ipervirtuosi, ma privi di uno stile
interpretativo personale, è stato confermato dal
successivo Le Tombeau de Couperin di Ravel. Ying
Li
 con
un tocco di sorvegliata pulizia e centellinato
con sicurezza e precisione, ha messo a fuoco
ogni dettaglio di questa complessa partitura, da
quelli strutturali, come i nervosi incisi
ritmici del Prelude, a, soprattutto, quelli
timbrici, creati dalla meravigliosa
orchestrazione raveliana e presenti in ciascuno
dei sei pezzi che compongono il brano, in cui,
si può dire, quasi ogni soluzione armonica ha,
prima di tutto, una funzione essenzialmente
coloristica. Il fraseggio della Ying asseconda
perfettamente, con la sua finezza ed eleganza ,e
con uso assai espressivo del rubato, la
limpidezza neoclassica, quasi asciutta del
disegno tematico dei vari pezzi, senza però
rinunciare mai ad arricchire il suono con un uso
efficace del pedale di risonanza, che le
permette di realizzare un bellissimo legato,
fluido e nitido. L’interpretazione della giovane
pianista si carica anche di una sottile e
suggestiva espressività, dando voce a quella
venatura elegiaca che affiora soprattutto nella
Forlane e ancor più nel Menuet, un pezzo in cui
il rubato di Ying Li raggiunge vertici di rara
finezza. Una gran bella interpretazione, insomma,
di questo gioiello raveliano, che culmina nella
Toccata finale, ove la compostezza neoclassica
dei cinque pezzi precedenti lascia il posto
all’esuberanza scintillante, all’impulso ritmico
incessante e quasi ossessivo, in cui si mette in
mostra il virtuosismo di Ying Li, il suo
controllo perfetto della tastiera anche in
passaggi di ardua difficoltà tecnica. La
caratteristica di questa stagione del
ViottiFestival, consiste nell’omaggio a Viotti,
contenuto nel programma di ogni appuntamento
concertistico, in occasione del bicentenario
della morte del grande violinista e compositore
vercellese, che cadrà precisamente nell’ormai
imminente 2024. Come nel concerto inaugurale,
anche in questo, tale omaggio è consistito
nell’esecuzione di una trascrizione per
pianoforte, opera del pianista Jean Louis Adam
(1758-1848), dell’Adagio dal Concerto di Viotti
per violino e orchestra in re minoreWla:6. Dopo
un attacco marziale, questo Adagio si distende
in una melodia di pretto sapore violinistico,
ricca di abbellimenti, in cui risplende in tutta
la sua luminosa trasparenza il fraseggio di Ying
Li, brava, sul piano espressivo, nel cogliere
quella sottile venatura elegiaca che soffonde i
momenti più belli del pezzo. “Giulietta, giovane
ragazza”, “Mercuzio”, “Montecchi e Capuleti”,
sono tre dei Dieci pezzi per pianoforte op.75
che nel 1937 Prokofiev trasse dal balletto
“Romeo e Giulietta”, composto pochissimi anni
prima. Qui le virtù pianistiche di Ying Li
debbono fare i conti con una scrittura
pianistica assai lontana da quelle dei pezzi
precedenti, un mondo sonoro fatto di prorompente
vitalismo, di suoni taglienti, , che però non
ignora anche momenti di tenera cantabilità e di
‘descrittivismo sentimentale’ dei personaggi del
balletto. Sono inoltre composizioni dalla
tessitura armonica e tematica spesso molto
complessa, che in alcuni casi sembra rimandare a
Liszt, senz’altro uno dei compositori di
riferimento per il Prokofiev pianista. In
effetti Ying Li con
un tocco di sorvegliata pulizia e centellinato
con sicurezza e precisione, ha messo a fuoco
ogni dettaglio di questa complessa partitura, da
quelli strutturali, come i nervosi incisi
ritmici del Prelude, a, soprattutto, quelli
timbrici, creati dalla meravigliosa
orchestrazione raveliana e presenti in ciascuno
dei sei pezzi che compongono il brano, in cui,
si può dire, quasi ogni soluzione armonica ha,
prima di tutto, una funzione essenzialmente
coloristica. Il fraseggio della Ying asseconda
perfettamente, con la sua finezza ed eleganza ,e
con uso assai espressivo del rubato, la
limpidezza neoclassica, quasi asciutta del
disegno tematico dei vari pezzi, senza però
rinunciare mai ad arricchire il suono con un uso
efficace del pedale di risonanza, che le
permette di realizzare un bellissimo legato,
fluido e nitido. L’interpretazione della giovane
pianista si carica anche di una sottile e
suggestiva espressività, dando voce a quella
venatura elegiaca che affiora soprattutto nella
Forlane e ancor più nel Menuet, un pezzo in cui
il rubato di Ying Li raggiunge vertici di rara
finezza. Una gran bella interpretazione, insomma,
di questo gioiello raveliano, che culmina nella
Toccata finale, ove la compostezza neoclassica
dei cinque pezzi precedenti lascia il posto
all’esuberanza scintillante, all’impulso ritmico
incessante e quasi ossessivo, in cui si mette in
mostra il virtuosismo di Ying Li, il suo
controllo perfetto della tastiera anche in
passaggi di ardua difficoltà tecnica. La
caratteristica di questa stagione del
ViottiFestival, consiste nell’omaggio a Viotti,
contenuto nel programma di ogni appuntamento
concertistico, in occasione del bicentenario
della morte del grande violinista e compositore
vercellese, che cadrà precisamente nell’ormai
imminente 2024. Come nel concerto inaugurale,
anche in questo, tale omaggio è consistito
nell’esecuzione di una trascrizione per
pianoforte, opera del pianista Jean Louis Adam
(1758-1848), dell’Adagio dal Concerto di Viotti
per violino e orchestra in re minoreWla:6. Dopo
un attacco marziale, questo Adagio si distende
in una melodia di pretto sapore violinistico,
ricca di abbellimenti, in cui risplende in tutta
la sua luminosa trasparenza il fraseggio di Ying
Li, brava, sul piano espressivo, nel cogliere
quella sottile venatura elegiaca che soffonde i
momenti più belli del pezzo. “Giulietta, giovane
ragazza”, “Mercuzio”, “Montecchi e Capuleti”,
sono tre dei Dieci pezzi per pianoforte op.75
che nel 1937 Prokofiev trasse dal balletto
“Romeo e Giulietta”, composto pochissimi anni
prima. Qui le virtù pianistiche di Ying Li
debbono fare i conti con una scrittura
pianistica assai lontana da quelle dei pezzi
precedenti, un mondo sonoro fatto di prorompente
vitalismo, di suoni taglienti, , che però non
ignora anche momenti di tenera cantabilità e di
‘descrittivismo sentimentale’ dei personaggi del
balletto. Sono inoltre composizioni dalla
tessitura armonica e tematica spesso molto
complessa, che in alcuni casi sembra rimandare a
Liszt, senz’altro uno dei compositori di
riferimento per il Prokofiev pianista. In
effetti Ying Li
 si
dimostra non solo in possesso di un virtuosismo
superbo, ma anche, sul piano espressivo,
efficace e attenta nel mettere a fuoco i momenti
più seducenti di questi tre pezzi: in “Giulietta,
giovane ragazza”, l’interpretazione della Li
coglie, adattando il fraseggio al continuo
mutare ritmico e tematico del brano, il graduale
trasformarsi di Giulietta dalla freschezza e
vivacità dell’adolescenza alla maturità,
attraverso l’esperienza dell’amore. L’agile
fraseggio della pianista sinoamericana ha buon
gioco nel rendere la scrittura scintillante e
briosa di Mercuzio, e raggiunge il suo esito più
coinvolgente per l’ascoltatore con Montecchi e
Capuleti, ove il suono di Ying Li, di buon peso,
sa pennellare suggestivamente il martellante
ritmo ossessivo, che, col suo timbro grave,
esprime tutta la tragicità del destino ormai
incombente dei due giovani amanti. Dominio
virtuosistico di tutti i piani sonori, timbrici
e dinamici, valida tecnica del legato, ottima
pedalizzazione, sensibiltà espressiva raffinata
e suggestiva. Queste, in sintesi le qualità che
emergono a questo punto del concerto di Ying Li
e che il brano successivo, la Ballata n. 2 in si
minore S171 di Liszt ha confermato pienamente.
Anche questa composizione, come la precedente di
Prokofiev, e come molte dello stesso Listz, ha
un’ispirazione letteraria, in questo caso uno
dei racconti più celebri e toccanti della
mitologia greca, quello dei due infelici amanti
Ero e Leandro, e anche in questo caso il
musicista aspira a esprimere in forme musicali
situazioni e personaggi della fonte letteraria.
Il pezzo, notissimo, ruota, in forma rapsodica e
variata su due temi fondamentali: la lotta di
Leandro contro la tempesta di mare che
l’annegherà e il sentimento d’amore tra Ero e
Leandro. La tecnica perfetta di Ying Li, trova
modo di dare ulteriore prova di sé nei passaggi
dedicati al primo tema, con il solito listziano
vorticare di scale, ottave staccate e spezzate,
salti bruschi di ottava, incroci rapidissimi e
quant’altro, che la pianista domina addirittura
con disinvoltura, tornendo le note, anche nei
passaggi più rapidi, con precisione assoluta e
con un uso sempre misurato del pedale. Ma trova
anche modo di esprimere tutto il toccante
lirismo del tema degli amanti, con un tocco che
sa farsi di aggraziata dolcezza, senza esagerare
nell’effusione emotiva, con un senso davvero ‘classico’
della misura. Il concerto di Ying Li chiudeva
alla grande con il Bela Bartòk della Sonata per
pianoforte BB88 SZ 80. Ying Li ha dovuto
sfoderare tutta la sua capacità di controllo dei
ritmi e dell’attacco del suono per eseguire al
meglio una sonorità percussiva e massiccia quale
quella che caratterizza i due tempi esterni
della composizione, l’Allegro moderato e
l’Allegro Molro. In questi momenti della sonata
bartokiana la difficoltà tecnica, che Ying Li
supera con lode, consiste nel conciliare la
secca nettezza delle linee portanti della
scrittura, con l’ardua densità contrappuntistica
che la caratterizza. Col suo suono energico e
limpido a un tempo, Ying Li disegna con perizia
da consumata interprete, con il suo tocco
luminoso e incisivo, il tessuto ritmico,
armonico e tematico dei due Allegro della
sonata. Bellissima l’interpretazione del lunare
Sostenuto e pesante centrale, sviluppato su
larghi accordi, a sostegno di una melodia che si
ripete ossessiva e ostinata, secondo i moduli di
quella musica popolare di area magiaro-rumena,
carissima al compositore ungherese. Qui è
davvero brava la giovane pianista cinese a
variare i registri dinamici, con un gioco
chiaroscurale che avvolge il movimento in una
suggestiva aura di inquietante mistero, in cui
riecheggia qualcosa del sommo Bartok della “Musica
della notte”. Abbiamo dunque ascoltato ieri
sera, in un concerto degno di essere ricordato,
una pianista che, nonostante la giovane età è
già ben più di una promessa. I lunghi applausi
tributati dal pubblico accorso come sempre
numeroso al Teatro Civico di Vercelli hanno
espresso l’apprezzamento per il concerto, cui
Ying Li ha risposto con almeno due bis (l’avverbio’
almeno’ si deve al nostro timore per la nebbia
prevista dai meteorologi, che ci ha indotto a
lasciare il Civico a concerto non ancora
terminato): un pezzo di Chopin e un brano sulla
cui attribuzione siamo incerti. si
dimostra non solo in possesso di un virtuosismo
superbo, ma anche, sul piano espressivo,
efficace e attenta nel mettere a fuoco i momenti
più seducenti di questi tre pezzi: in “Giulietta,
giovane ragazza”, l’interpretazione della Li
coglie, adattando il fraseggio al continuo
mutare ritmico e tematico del brano, il graduale
trasformarsi di Giulietta dalla freschezza e
vivacità dell’adolescenza alla maturità,
attraverso l’esperienza dell’amore. L’agile
fraseggio della pianista sinoamericana ha buon
gioco nel rendere la scrittura scintillante e
briosa di Mercuzio, e raggiunge il suo esito più
coinvolgente per l’ascoltatore con Montecchi e
Capuleti, ove il suono di Ying Li, di buon peso,
sa pennellare suggestivamente il martellante
ritmo ossessivo, che, col suo timbro grave,
esprime tutta la tragicità del destino ormai
incombente dei due giovani amanti. Dominio
virtuosistico di tutti i piani sonori, timbrici
e dinamici, valida tecnica del legato, ottima
pedalizzazione, sensibiltà espressiva raffinata
e suggestiva. Queste, in sintesi le qualità che
emergono a questo punto del concerto di Ying Li
e che il brano successivo, la Ballata n. 2 in si
minore S171 di Liszt ha confermato pienamente.
Anche questa composizione, come la precedente di
Prokofiev, e come molte dello stesso Listz, ha
un’ispirazione letteraria, in questo caso uno
dei racconti più celebri e toccanti della
mitologia greca, quello dei due infelici amanti
Ero e Leandro, e anche in questo caso il
musicista aspira a esprimere in forme musicali
situazioni e personaggi della fonte letteraria.
Il pezzo, notissimo, ruota, in forma rapsodica e
variata su due temi fondamentali: la lotta di
Leandro contro la tempesta di mare che
l’annegherà e il sentimento d’amore tra Ero e
Leandro. La tecnica perfetta di Ying Li, trova
modo di dare ulteriore prova di sé nei passaggi
dedicati al primo tema, con il solito listziano
vorticare di scale, ottave staccate e spezzate,
salti bruschi di ottava, incroci rapidissimi e
quant’altro, che la pianista domina addirittura
con disinvoltura, tornendo le note, anche nei
passaggi più rapidi, con precisione assoluta e
con un uso sempre misurato del pedale. Ma trova
anche modo di esprimere tutto il toccante
lirismo del tema degli amanti, con un tocco che
sa farsi di aggraziata dolcezza, senza esagerare
nell’effusione emotiva, con un senso davvero ‘classico’
della misura. Il concerto di Ying Li chiudeva
alla grande con il Bela Bartòk della Sonata per
pianoforte BB88 SZ 80. Ying Li ha dovuto
sfoderare tutta la sua capacità di controllo dei
ritmi e dell’attacco del suono per eseguire al
meglio una sonorità percussiva e massiccia quale
quella che caratterizza i due tempi esterni
della composizione, l’Allegro moderato e
l’Allegro Molro. In questi momenti della sonata
bartokiana la difficoltà tecnica, che Ying Li
supera con lode, consiste nel conciliare la
secca nettezza delle linee portanti della
scrittura, con l’ardua densità contrappuntistica
che la caratterizza. Col suo suono energico e
limpido a un tempo, Ying Li disegna con perizia
da consumata interprete, con il suo tocco
luminoso e incisivo, il tessuto ritmico,
armonico e tematico dei due Allegro della
sonata. Bellissima l’interpretazione del lunare
Sostenuto e pesante centrale, sviluppato su
larghi accordi, a sostegno di una melodia che si
ripete ossessiva e ostinata, secondo i moduli di
quella musica popolare di area magiaro-rumena,
carissima al compositore ungherese. Qui è
davvero brava la giovane pianista cinese a
variare i registri dinamici, con un gioco
chiaroscurale che avvolge il movimento in una
suggestiva aura di inquietante mistero, in cui
riecheggia qualcosa del sommo Bartok della “Musica
della notte”. Abbiamo dunque ascoltato ieri
sera, in un concerto degno di essere ricordato,
una pianista che, nonostante la giovane età è
già ben più di una promessa. I lunghi applausi
tributati dal pubblico accorso come sempre
numeroso al Teatro Civico di Vercelli hanno
espresso l’apprezzamento per il concerto, cui
Ying Li ha risposto con almeno due bis (l’avverbio’
almeno’ si deve al nostro timore per la nebbia
prevista dai meteorologi, che ci ha indotto a
lasciare il Civico a concerto non ancora
terminato): un pezzo di Chopin e un brano sulla
cui attribuzione siamo incerti.
10 dicembre 2023 Bruno Busca
Un omaggio a Luciano
Chailly con
nuovi brani di giovani compositori al Museo del
Novecento
Ottima
l' iniziativa nel nome di SIGNUM-
L'umano, la poesia e il sogno nella scrittura
musicale, svoltasi ieri nella Sala Fontana
del Museo del Novecento milanese. Organizzata da
SIMC (Società italiana di musica
contemporanea) nel centenario della sua
fondazione, ha voluto omaggiare Luciano Chailly,
importante compositore del '900 al qual e
sono stati dedicati i brani dei giovani
compositori ascoltati ieri pomeriggio. Musiche
di Chailly erano state
 eseguite
nel luglio dello scorso anno sempre in un
concerto di SIMC. Andrea Talmelli,
Presidente della SIMC, e Michele Fredrigotti,
noto pianista e compositore, hanno presentato
cinque giovani musicisti e i numerosi
strumentisti e cantanti interpreti delle loro
composizioni. L'Achrome Ensemble, gruppo
cameristico specializzato in musica
contemporanea, ed alcuni allievi della Civica
Scuola di Musica "Claudio Abbado", con l'ausilio,
in alcuni lavori, delle voci di Eleonora Colaci,
soprano, Marco Pangalli, baritono e Bo Shimmin,
tenore, hanno eseguito complessivamente sei
nuovi brani. I compositori stessi li hanno
presentati, ad iniziare da Cristina Maria Noli
col suo Sogni che tramutano i pensieri,
per flauto, clarinetto e violoncello, un lavoro
costruito in modo efficace nel dialogo
espressivo dei tre strumenti, ottimamente
interpretato rispettivamente da Antonella Bini,
Stefano Merighi e Martina Rudic. Il brano
successivo di Giuseppe eseguite
nel luglio dello scorso anno sempre in un
concerto di SIMC. Andrea Talmelli,
Presidente della SIMC, e Michele Fredrigotti,
noto pianista e compositore, hanno presentato
cinque giovani musicisti e i numerosi
strumentisti e cantanti interpreti delle loro
composizioni. L'Achrome Ensemble, gruppo
cameristico specializzato in musica
contemporanea, ed alcuni allievi della Civica
Scuola di Musica "Claudio Abbado", con l'ausilio,
in alcuni lavori, delle voci di Eleonora Colaci,
soprano, Marco Pangalli, baritono e Bo Shimmin,
tenore, hanno eseguito complessivamente sei
nuovi brani. I compositori stessi li hanno
presentati, ad iniziare da Cristina Maria Noli
col suo Sogni che tramutano i pensieri,
per flauto, clarinetto e violoncello, un lavoro
costruito in modo efficace nel dialogo
espressivo dei tre strumenti, ottimamente
interpretato rispettivamente da Antonella Bini,
Stefano Merighi e Martina Rudic. Il brano
successivo di Giuseppe
 Gammino,
Planctus- dramma per ensemble, prevedeva
anche una regia per i movimenti del soprano
Eleonora Colaci e del baritono Marco Pangallo
realizzati nel contesto strumentale da Demetrio
Colaci. Un lavoro particolarmente incisivo,
molto attuale, che narra la triste vicenda di un
femminicidio. L'ottima voce della Colaci e la
parte, soprattutto recitata, di Pangallo, sono
state sottolineate dalle timbriche incisive e
suggestive dagli strumentisti dell' Achrome
Ensemble e dalle percussoni di Marco Martignoni,
tutto diretti con precisione di dettaglio da
Marcello Parolini. Una pièce musicale
particolarmente riuscita, quella di Gammino che
andrebbe certamente replicata in sale da
concerto o Gammino,
Planctus- dramma per ensemble, prevedeva
anche una regia per i movimenti del soprano
Eleonora Colaci e del baritono Marco Pangallo
realizzati nel contesto strumentale da Demetrio
Colaci. Un lavoro particolarmente incisivo,
molto attuale, che narra la triste vicenda di un
femminicidio. L'ottima voce della Colaci e la
parte, soprattutto recitata, di Pangallo, sono
state sottolineate dalle timbriche incisive e
suggestive dagli strumentisti dell' Achrome
Ensemble e dalle percussoni di Marco Martignoni,
tutto diretti con precisione di dettaglio da
Marcello Parolini. Una pièce musicale
particolarmente riuscita, quella di Gammino che
andrebbe certamente replicata in sale da
concerto o
 luoghi
adatti. Il terzo lavoro, di Diego Petrella,
pianista e compositore, era denominato Tre
frammenti di Zürau, per pianoforte, voce e
cordiera. I testi di Franz Kafka hanno trovato
l'ottima parte pianistica affidata alle decise
mani di Michele Rinaldi, mentre la voce e gli
effetti integrativi sulla cordiera del
pianoforte erano dello stesso Petrella. Una
performance, quella di Petrella, che trova
ispirazione dalle pièce di Sylvano
Bussotti e che riesce a piacere per l'ottima
integrazioni delle varie componenti, la valida
parte pianistica cui si aggiunge l'intonatissima
aria fischiata nel finale dallo stesso
compositore-interprete. I due brani successivi,
When I have fears e Three screenshots
erano di Giorgio F. Dalla Villa. Il primo
per tenore e pianoforte con la valida voce di Bo
Shimmin e l'ottima parte pianistica interpretata
con sicurezza ed incisività da Alessandro Lotto.
Il secondo con l'Achrome Ensemble nel duo
di clarinetto/clarinetto basso e violoncello che
ha sottolineato in modo efficace i tre quadri
musicali di Dalla Villa ben delineati dagli
ottimi strumentisti Merighi e Rudic. luoghi
adatti. Il terzo lavoro, di Diego Petrella,
pianista e compositore, era denominato Tre
frammenti di Zürau, per pianoforte, voce e
cordiera. I testi di Franz Kafka hanno trovato
l'ottima parte pianistica affidata alle decise
mani di Michele Rinaldi, mentre la voce e gli
effetti integrativi sulla cordiera del
pianoforte erano dello stesso Petrella. Una
performance, quella di Petrella, che trova
ispirazione dalle pièce di Sylvano
Bussotti e che riesce a piacere per l'ottima
integrazioni delle varie componenti, la valida
parte pianistica cui si aggiunge l'intonatissima
aria fischiata nel finale dallo stesso
compositore-interprete. I due brani successivi,
When I have fears e Three screenshots
erano di Giorgio F. Dalla Villa. Il primo
per tenore e pianoforte con la valida voce di Bo
Shimmin e l'ottima parte pianistica interpretata
con sicurezza ed incisività da Alessandro Lotto.
Il secondo con l'Achrome Ensemble nel duo
di clarinetto/clarinetto basso e violoncello che
ha sottolineato in modo efficace i tre quadri
musicali di Dalla Villa ben delineati dagli
ottimi strumentisti Merighi e Rudic.
 L'ultimo
brano in programma, Trasfigurazioni, di
Filippo Scaramucci, per cinque strumentisti
dell'Achrome Ensemble, sempre diretti da
Parolini, ha ritrovato ancora una valida resa
compositiva ed interpretativa. Tutti i brani
ascoltati ieri erano scritti con un linguaggio
articolato e chiaro nelle intenzioni, eseguiti
con grande professionalità e qualità di
restituzione, e -cosa non scontata nel mondo
della musica contemporanea- sono risultati
accessibili all'ascolto ottenendo meritati
applausi dal numeroso pubblico intervenuto in
Sala Fontana. Un'iniziativa di valore che
aggiunge un altro mattone alla maggiore
diffusione della musica contemporanea. L'ultimo
brano in programma, Trasfigurazioni, di
Filippo Scaramucci, per cinque strumentisti
dell'Achrome Ensemble, sempre diretti da
Parolini, ha ritrovato ancora una valida resa
compositiva ed interpretativa. Tutti i brani
ascoltati ieri erano scritti con un linguaggio
articolato e chiaro nelle intenzioni, eseguiti
con grande professionalità e qualità di
restituzione, e -cosa non scontata nel mondo
della musica contemporanea- sono risultati
accessibili all'ascolto ottenendo meritati
applausi dal numeroso pubblico intervenuto in
Sala Fontana. Un'iniziativa di valore che
aggiunge un altro mattone alla maggiore
diffusione della musica contemporanea.
06-12-23 Cesare Guzzardella
L'Orchestra di Stato
del Kazakistan
e Gabriele Carcano alle Serate
Musicali
Un
sabato diverso per Serate Musicali, la
società concertistica milanese che ha nel lunedì
il suo giorno privilegiato per i concerti. Un
sabato, quello di ieri sera in Conservatorio,
dove si è potuto ascoltare una compagine
strumentale di ottima qualità quale l'Orchestra
di Stato del Kazakistan diretta benissimo da
Kanat
 Omarov,
per tre lavori, ad iniziare dal rarissimo
Poema sinfonico Dudar-ay del compositore
Evgeny Grigorievich Brusilovsky ( 1905-1981),
autore, tra le numerose sue composizioni,
dell'Inno nazionale kazako. Un brano tonale
composto poco dopo il 1950 e diretto molto bene,
che ritrova nella musica folcloristica del suo
popolo le radici, partendo dalla canzone
popolare di Mariyam Zhagorkyzy e trovando spunti
nei canti della steppa euroasiatica. Gli altri
brani erano di Liszt e di Rachmaninov. Per il
non troppo frequentato Concerto n.2 in la
maggiore S.125 di Franz Liszt abbiamo
trovato come Omarov,
per tre lavori, ad iniziare dal rarissimo
Poema sinfonico Dudar-ay del compositore
Evgeny Grigorievich Brusilovsky ( 1905-1981),
autore, tra le numerose sue composizioni,
dell'Inno nazionale kazako. Un brano tonale
composto poco dopo il 1950 e diretto molto bene,
che ritrova nella musica folcloristica del suo
popolo le radici, partendo dalla canzone
popolare di Mariyam Zhagorkyzy e trovando spunti
nei canti della steppa euroasiatica. Gli altri
brani erano di Liszt e di Rachmaninov. Per il
non troppo frequentato Concerto n.2 in la
maggiore S.125 di Franz Liszt abbiamo
trovato come
 protagonista
il pianista torinese Gabriele Carcano. Il
concerto è in un unico ampio movimento suddiviso
in numerosi andamenti sviluppati nell'originale
lavoro, tutto lisztiano, dove l'influenze tra
Chopin e Wagner vengono assorbite per una
restituzione esemplare ricca di contrasti, tra
la dolcezza delle melodie pianistiche e gli
interventi di grande impatto sonoro sia
dell'orchestra che del solista. Eccellente il
pianoforte di Carcano, preciso, delicato e
sicuro, mai eccessivo nelle volumetrie e ottima
la direzione e l'esternazione orchestrale molto
importante in questo lavoro. Efficace per
leggerezza ed espressività il bis solistico
concesso da Gabriele Carcano con Zart und
singend ( tenero e canterino), N.14
dall'Op.6 di Robert protagonista
il pianista torinese Gabriele Carcano. Il
concerto è in un unico ampio movimento suddiviso
in numerosi andamenti sviluppati nell'originale
lavoro, tutto lisztiano, dove l'influenze tra
Chopin e Wagner vengono assorbite per una
restituzione esemplare ricca di contrasti, tra
la dolcezza delle melodie pianistiche e gli
interventi di grande impatto sonoro sia
dell'orchestra che del solista. Eccellente il
pianoforte di Carcano, preciso, delicato e
sicuro, mai eccessivo nelle volumetrie e ottima
la direzione e l'esternazione orchestrale molto
importante in questo lavoro. Efficace per
leggerezza ed espressività il bis solistico
concesso da Gabriele Carcano con Zart und
singend ( tenero e canterino), N.14
dall'Op.6 di Robert
 Schumann,
eseguito con dolcezza e passione. Dopo il breve
intervallo abbiamo assistito ad una coinvolgente
interpretazione della corposa Sinfonia n.2 in
mi minore op.27 di Sergei Rachmaninov.
Un'idea delle eccellenti qualità della compagine
orchestrale - con molti giovani strumentisti- e
del suo direttore, è stata riconfermata
all'ascolto di questo capolavoro purtroppo poco
eseguito ma di grande pregio per la forte
personalità espressa dal grande compositore
russo. Un concerto quello di ieri che meritava
una Sala Verdi al completo e che ha trovato
invece un pubblico limitato. Schumann,
eseguito con dolcezza e passione. Dopo il breve
intervallo abbiamo assistito ad una coinvolgente
interpretazione della corposa Sinfonia n.2 in
mi minore op.27 di Sergei Rachmaninov.
Un'idea delle eccellenti qualità della compagine
orchestrale - con molti giovani strumentisti- e
del suo direttore, è stata riconfermata
all'ascolto di questo capolavoro purtroppo poco
eseguito ma di grande pregio per la forte
personalità espressa dal grande compositore
russo. Un concerto quello di ieri che meritava
una Sala Verdi al completo e che ha trovato
invece un pubblico limitato.
3 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
AL CONSERVATORIO DI NOVARA
CONCERTO DEI VINCITORI DEL
CONCORSO“SERGIO FIORENTINO PIANO COMPETITION”
Tra le numerose iniziative di
cui si è fatto promotore in questi anni il
Conservatorio G. Cantelli di Novara, c’è, da tre
anni, un concorso pianistico intitolato a quello
che fu, nel breve giro d’anni tra il dopoguerra
e i primi anni ’50 uno dei più grandi pianisti
italiani, massimo rappresentante della gloriosa
‘scuola napoletana’: Sergio Fiorentino
(1927-1998) di cui pare che A. Benedetti
Michelangeli, dopo averlo ascoltato, abbia detto:
“E’ il solo altro pianista”. Il destino avverso
troncò assai presto la carriera, che si
annunciava folgorante, di questo grande Maestro:
nel 1953 scampò per miracolo ad un incidente
aereo, ma ne riportò uno schiacciamento
vertebrale, che, provocandogli lancinanti e
crescenti dolori alla schiena, gli impose di
lasciare le sale da concerto, dedicandosi
all’attività didattica presso il Conservatorio
di Napoli. Riprese, in verità, l’attività
concertistica nel 1991, riguadagnando una
qualche popolarità anche all’estero, ma ancora
la sorte si abbatté su di lui stroncandolo con
un infarto nel 1998. Di lui è rimasto molto
materiale registrato, ma certo il ricordo di
Sergio Fiorentino è sbiadito o addirittura
cancellato nella memoria dei più, e dunque
benissimo ha fatto il Cantelli a rinverdirlo,
istituendo la “Sergio Fiorentino Piano
Competition”. Tale concorso prevede due premi
distinti, lo Junior per gli under 19 e il Senior
per gli under 30 ( benché in questa edizione si
sia alzata l’asticella anagrafica a 32 anni): la
giuria, che contava al suo interno ben due
membri che furono tra gli ultimi allievi di
Fiorentino, Giuseppe Andaloro, presidente e
Mario Coppola, stimato e autorevole docente al
Cantelli, ha assegnato il primo premio della
categoria Junior a Massimo Urban, milanese
diciottenne e il secondo premio a Giulia
Falzarano, coetanea di Urban, da Airola,
 provincia
di Benevento, entrambi già con un’esperienza
significativa di concerti e concorsi. Il primo
premio per la categoria Senior non è stato
assegnato. Il vincitore, col secondo premio, è
risultato il trentaduenne ucraino, Danylo
Saienko, anche lui naturalmente con una
abbondante serie di concorsi, tra i quali il
prestigioso Horowitz di Kiev, in cui ha vinto un
premio, e certo non alle prime armi nelle sale
da concerto. Questi tre vincitori sono stati i
protagonisti del concerto di ieri, sabato 2/12,
all’auditorium del Conservatorio Cantelli. Ha
dato inizio al recital la Falzarano, che ha
presentato l’Andante spianato e grande polacca
brillante op.22: massima padronanza della
tastiera, uso assai sobrio del pedale, suono
elegante che sa passare efficacemente dalla
delicatezza dell’Andante, all’energia dirompente
della polacca. Un po’ rigido il fraseggio e non
sempre impeccabile la gestione delle dinamiche,
ma la sua è stata un’esecuzione nel complesso
più che apprezzabile. Urban ha invece puntato
tutto sul pianismo di scrittura più ardua e
acrobatica: Rachmaninov, con l’Etude Tableau
op.39 n.6 e Liszt con la notissima Rapsodia
ungherese n.12. C’è davvero da restare
stupefatti di fronte alla straordinaria tecnica
di questo ragazzo, in particolare
nell’esecuzione di Rachmaninov: Urban supera in
scioltezza i passaggi più impervi della
partitura, sgranando con perlacea precisione
raffiche di note o suonando provincia
di Benevento, entrambi già con un’esperienza
significativa di concerti e concorsi. Il primo
premio per la categoria Senior non è stato
assegnato. Il vincitore, col secondo premio, è
risultato il trentaduenne ucraino, Danylo
Saienko, anche lui naturalmente con una
abbondante serie di concorsi, tra i quali il
prestigioso Horowitz di Kiev, in cui ha vinto un
premio, e certo non alle prime armi nelle sale
da concerto. Questi tre vincitori sono stati i
protagonisti del concerto di ieri, sabato 2/12,
all’auditorium del Conservatorio Cantelli. Ha
dato inizio al recital la Falzarano, che ha
presentato l’Andante spianato e grande polacca
brillante op.22: massima padronanza della
tastiera, uso assai sobrio del pedale, suono
elegante che sa passare efficacemente dalla
delicatezza dell’Andante, all’energia dirompente
della polacca. Un po’ rigido il fraseggio e non
sempre impeccabile la gestione delle dinamiche,
ma la sua è stata un’esecuzione nel complesso
più che apprezzabile. Urban ha invece puntato
tutto sul pianismo di scrittura più ardua e
acrobatica: Rachmaninov, con l’Etude Tableau
op.39 n.6 e Liszt con la notissima Rapsodia
ungherese n.12. C’è davvero da restare
stupefatti di fronte alla straordinaria tecnica
di questo ragazzo, in particolare
nell’esecuzione di Rachmaninov: Urban supera in
scioltezza i passaggi più impervi della
partitura, sgranando con perlacea precisione
raffiche di note o suonando
 gli
accordi più complicati, con un virtuosismo da
pianista maturo. Anche da parte di Urban abbiamo
notato un uso molto contenuto del pedale.
Complimenti davvero al giovanissimo talento
milanese, ma ci piacerebbe risentirlo su pezzi
magari meno acrobatici, ma che sollecitano un
fraseggio a maggior tasso di espressività.
Infine, il senior Solienko, che proponeva un
programma più ampio rispetto a quello dei due
juniores. Solienko si presentava al pubblico con
due raffinatissime composizioni dai Pièces de
Clavecin di Couperin, La Couperin e l’Engageante,
che ha ben interpretato nel vario alternarsi dei
timbri e delle armonie, con suono preciso e
duttile nel restituire il mutevole spessore
sonoro dei due pezzi. Elegante e preciso, fluido
nel fraseggio nei due successivi Preludi op.80
del pianista e compositore polacco Ignaz
Friedman (1882-1948), per poi virare anche lui
sul virtuosismo di uno Studio Trascendentale di
Liszt, il n. 8 ( e non 12, come riportato dal
programma di sala) “Chasse Neige” (Caccia
selvaggia): Di questo scatenato Presto furioso
abbiamo ascoltato certamente interpretazioni più
coinvolgenti, ma diremmo che Solienko abbia
raggiunto l’obiettivo interpretativo di questo
complesso pezzo: con potenza fisica più che
rispettabile della mano e del polso, e un
controllo sempre adeguato del suono, porre in
evidenza le nervose e sovreccitate figure che
attraversano il fraseggio, con incalzante
progressione, a imitazione del caos che
accompagna la battuta di caccia, con qualcosa di
vagamente demoniaco. gli
accordi più complicati, con un virtuosismo da
pianista maturo. Anche da parte di Urban abbiamo
notato un uso molto contenuto del pedale.
Complimenti davvero al giovanissimo talento
milanese, ma ci piacerebbe risentirlo su pezzi
magari meno acrobatici, ma che sollecitano un
fraseggio a maggior tasso di espressività.
Infine, il senior Solienko, che proponeva un
programma più ampio rispetto a quello dei due
juniores. Solienko si presentava al pubblico con
due raffinatissime composizioni dai Pièces de
Clavecin di Couperin, La Couperin e l’Engageante,
che ha ben interpretato nel vario alternarsi dei
timbri e delle armonie, con suono preciso e
duttile nel restituire il mutevole spessore
sonoro dei due pezzi. Elegante e preciso, fluido
nel fraseggio nei due successivi Preludi op.80
del pianista e compositore polacco Ignaz
Friedman (1882-1948), per poi virare anche lui
sul virtuosismo di uno Studio Trascendentale di
Liszt, il n. 8 ( e non 12, come riportato dal
programma di sala) “Chasse Neige” (Caccia
selvaggia): Di questo scatenato Presto furioso
abbiamo ascoltato certamente interpretazioni più
coinvolgenti, ma diremmo che Solienko abbia
raggiunto l’obiettivo interpretativo di questo
complesso pezzo: con potenza fisica più che
rispettabile della mano e del polso, e un
controllo sempre adeguato del suono, porre in
evidenza le nervose e sovreccitate figure che
attraversano il fraseggio, con incalzante
progressione, a imitazione del caos che
accompagna la battuta di caccia, con qualcosa di
vagamente demoniaco.
 Meno
convincente ci è sembrato il fraseggio di
Solienko quando a questa ‘scena’ musicale ne
subentra un’altra di natura completamente
diversa, costruita su una sognante melodia, ove,
a nostro avviso, la scelta dinamica sugli
accordi ribattuti che sostengono la melodia non
ha reso in modo efficace l’estrema delicatezza,
quasi un pizzicato di un violino, che tali
accordi debbono presentare, sciupando l’effetto
espressivo che Liszt si proponeva. Ottima invece,
sotto il profilo tecnico ed espressivo
l’interpretazione de Los Requiebros dalle
Goyescas di Granados, così come quella dello
Studio op. 63 di Lutoslawski, una sorte di
Chopin rivisitato in chiave novecentesca. Un bel
concerto, con tre giovani concertisti
sicuramente dotati di talento, cui è aperto un
futuro ricco di soddisfazioni. Il lungo applauso
del folto pubblico che si assiepava
all’Auditorium testimoniava il successo del
recital. Meno
convincente ci è sembrato il fraseggio di
Solienko quando a questa ‘scena’ musicale ne
subentra un’altra di natura completamente
diversa, costruita su una sognante melodia, ove,
a nostro avviso, la scelta dinamica sugli
accordi ribattuti che sostengono la melodia non
ha reso in modo efficace l’estrema delicatezza,
quasi un pizzicato di un violino, che tali
accordi debbono presentare, sciupando l’effetto
espressivo che Liszt si proponeva. Ottima invece,
sotto il profilo tecnico ed espressivo
l’interpretazione de Los Requiebros dalle
Goyescas di Granados, così come quella dello
Studio op. 63 di Lutoslawski, una sorte di
Chopin rivisitato in chiave novecentesca. Un bel
concerto, con tre giovani concertisti
sicuramente dotati di talento, cui è aperto un
futuro ricco di soddisfazioni. Il lungo applauso
del folto pubblico che si assiepava
all’Auditorium testimoniava il successo del
recital.
3 dicembre 2023 Bruno Busca
Janine Jansen, Mischa
Maisky e Martha Argerich al Teatro alla Scala
Un
successo straordinario per un trio straordinario
nei nomi di Janine Jansen, Mischa Maisky e
Martha Argerich. Un violino, un violoncello e un
pianoforte per Haydn,
Šostakovič e Mendelssohn, tre grandissimi
musicisti interpretati come raramente si ascolta.
La disposizione non cronologica
dei brani, con il
Trio in sol
maggiore n.39
Hob XV:25
(1795) di
Joseph
Haydn seguito dal Trio in mi minore n.2 op.67
(1944)
di
Dmitrij
Šostakovič e, dopo l'intervallo,
 dal
Trio in re minore n.1 op.49 (1839) di
Felix
Mendelssohn, trova probabilmente senso nella
durata dei lavori, con quello mendelssohniano di
relativa
maggior lunghezza,
e nel contrasto complessivo tra i brani.
Certo passare dal perfetto classicismo del
compositore di Rohrau della bassa Austria, al
segno forte ed incisivo dello strepitoso trio
del russo di San Pietroburgo, composto in piena
guerra nel 1944, è
un bel salto stilistico ed emotivo. Ma la
duttilità del trio Jansen- Maisky-Argerich,
eccellente in tutti gli ambiti, ha permesso di
far apprezzare al pubblico, al completo nel
Teatro alla Scala, tutti e tre i noti lavori,
con standing ovation al termine della
celebre Op.49 dell'amburghese. Musica in
perfetto equilibrio di ruolo per i tre
interpreti, con le sicure mani
dell'ottantaduenne pianista argentina che
delineavano armonicamente i tre brani, dettando
spesso gli andamenti più rapidi, come il
coinvolgente Rondò all'Ongarese, finale
del trio di Haydn, eseguito rapidamente e in
modo esemplare, ma anche nel bellissimo
Scherzo del trio di Mendelssohn, ripetuto
anche nel terzo bis. Stupefacente l'intesa dei
due archi, entrambi con vibrato eccellente e
simmetrica espressività, e con i dosati volumi
timbrici della Argerich, capace, come i colleghi,
e ancor più, di passare da i pianissimo
impercettibili a dal
Trio in re minore n.1 op.49 (1839) di
Felix
Mendelssohn, trova probabilmente senso nella
durata dei lavori, con quello mendelssohniano di
relativa
maggior lunghezza,
e nel contrasto complessivo tra i brani.
Certo passare dal perfetto classicismo del
compositore di Rohrau della bassa Austria, al
segno forte ed incisivo dello strepitoso trio
del russo di San Pietroburgo, composto in piena
guerra nel 1944, è
un bel salto stilistico ed emotivo. Ma la
duttilità del trio Jansen- Maisky-Argerich,
eccellente in tutti gli ambiti, ha permesso di
far apprezzare al pubblico, al completo nel
Teatro alla Scala, tutti e tre i noti lavori,
con standing ovation al termine della
celebre Op.49 dell'amburghese. Musica in
perfetto equilibrio di ruolo per i tre
interpreti, con le sicure mani
dell'ottantaduenne pianista argentina che
delineavano armonicamente i tre brani, dettando
spesso gli andamenti più rapidi, come il
coinvolgente Rondò all'Ongarese, finale
del trio di Haydn, eseguito rapidamente e in
modo esemplare, ma anche nel bellissimo
Scherzo del trio di Mendelssohn, ripetuto
anche nel terzo bis. Stupefacente l'intesa dei
due archi, entrambi con vibrato eccellente e
simmetrica espressività, e con i dosati volumi
timbrici della Argerich, capace, come i colleghi,
e ancor più, di passare da i pianissimo
impercettibili a
 suoni
di grande intensità. Di notevole espressività le
timbriche di Janine Jansen e di Mischa Maisky,
soprattutto nel brano più difficile, per varietà
di contrasti e per molteplicità stilistica,
quello di
Šostakovič
, un capolavoro iniziato
con dei sorprendenti armonici del violoncello di
Maisky, che rivela in toto, insieme a
molta sua musica sinfonica, il suo tipico
linguaggio sempre denso di espressività, lontana
dal romanticismo e vicina al mondo reale della
sua terra. Un successo meritatissimo quello dei
tre grandi interpreti e artisti. Pienamente
soddisfatti degli infiniti applausi del pubblico
entusiasta, hanno concesso poi tre bis. Oltre al
ripetuto Scherzo mendelssohniano già
citato, le splendide melodie distribuite trai i
tre strumenti del celebre Du bist die Ruh' ,
lied di Franz Schubert adattato a trio, e
del Duetto dai Phantasiestücke op.88
di Robert Schumann. Un concerto certamente
memorabile! suoni
di grande intensità. Di notevole espressività le
timbriche di Janine Jansen e di Mischa Maisky,
soprattutto nel brano più difficile, per varietà
di contrasti e per molteplicità stilistica,
quello di
Šostakovič
, un capolavoro iniziato
con dei sorprendenti armonici del violoncello di
Maisky, che rivela in toto, insieme a
molta sua musica sinfonica, il suo tipico
linguaggio sempre denso di espressività, lontana
dal romanticismo e vicina al mondo reale della
sua terra. Un successo meritatissimo quello dei
tre grandi interpreti e artisti. Pienamente
soddisfatti degli infiniti applausi del pubblico
entusiasta, hanno concesso poi tre bis. Oltre al
ripetuto Scherzo mendelssohniano già
citato, le splendide melodie distribuite trai i
tre strumenti del celebre Du bist die Ruh' ,
lied di Franz Schubert adattato a trio, e
del Duetto dai Phantasiestücke op.88
di Robert Schumann. Un concerto certamente
memorabile!
2 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
Musica all'Archivio
di Stato di Milano
Una
valida iniziativa quella organizzata e
riproposta all'Archivio di Stato di Milano da
Annalisa Rossi, Soprintendente archivistico e
Direttore dell'Archivio stesso che ha introdotto
l'incontro, e da Silvia Leggio, docente di
pianoforte al Conservatorio milanese. Ieri nel
tardo pomeriggio alcuni allievi di Conservatorio
particolarmente dotati hanno tenuto un concerto
in via Senato 10 rivelando indubbie
 qualità
musicali. Tutti giovanissimi, con età tra i
dieci e i diciassette anni, frequentano corsi
musicali avanzati essendo già molto avanti negli
studi musicali. Francesco Avesio, Camilla
Stimolo, Anita e Beatrice Baldissin, Patrizia
Amane Di Lella e Martina Meola sono stati
presentati dalla prof.sa Leggio e hanno scelto
alcuni brani di notevole difficoltà tecnica per
rivelare le loro qualità strumentali. La
Fantasia Ungherese di J.K.Mertz qualità
musicali. Tutti giovanissimi, con età tra i
dieci e i diciassette anni, frequentano corsi
musicali avanzati essendo già molto avanti negli
studi musicali. Francesco Avesio, Camilla
Stimolo, Anita e Beatrice Baldissin, Patrizia
Amane Di Lella e Martina Meola sono stati
presentati dalla prof.sa Leggio e hanno scelto
alcuni brani di notevole difficoltà tecnica per
rivelare le loro qualità strumentali. La
Fantasia Ungherese di J.K.Mertz
 ha
trovato timbriche raffinate nella chitarra di F.
Avesio; la difficile post-romantica Sonata
n.2 op.19 (Andante) di Scriabin ha visto al
pianoforte l'ottima Patrizia Di Lella; molto
efficace la resa pianistica per Camilla Stimolo
nell'Introduzione e Rondò Capriccioso di
F. Mendelssohn; il primo movimento della
complessa Sonata n.1 op.105 di Robert
Schumann e Introduzione e Tarantella di
P.de Sarasate sono stati affrontati con grinta e
ottima resa dalle sorelle Anita, al pianoforte,
e Beatrice ha
trovato timbriche raffinate nella chitarra di F.
Avesio; la difficile post-romantica Sonata
n.2 op.19 (Andante) di Scriabin ha visto al
pianoforte l'ottima Patrizia Di Lella; molto
efficace la resa pianistica per Camilla Stimolo
nell'Introduzione e Rondò Capriccioso di
F. Mendelssohn; il primo movimento della
complessa Sonata n.1 op.105 di Robert
Schumann e Introduzione e Tarantella di
P.de Sarasate sono stati affrontati con grinta e
ottima resa dalle sorelle Anita, al pianoforte,
e Beatrice
 Baldissin
al violino. A conclusione, la più giovane, un
talento pianistico indiscutibile quello di
Martina Meola - undici anni compiuti il 28
novembre- ha eseguito i brani più virtuosistici
del programma con Allegro de Concerto di
Granados prima, la Rapsodia Ungherese n.11
di Liszt dopo, e in aggiunta al programma
ufficiale, anche il celebre Liebesträume n.3
(Sogno d'amore) sempre del grande ungherese.
Interpretazioni quest'ultime che superano di
gran lunga quelle di decine di pianisti, anche
di livello, in carriera da decenni. La Meola è
stata l'ultima vincitrice del Premio del
Conservatorio milanese e Baldissin
al violino. A conclusione, la più giovane, un
talento pianistico indiscutibile quello di
Martina Meola - undici anni compiuti il 28
novembre- ha eseguito i brani più virtuosistici
del programma con Allegro de Concerto di
Granados prima, la Rapsodia Ungherese n.11
di Liszt dopo, e in aggiunta al programma
ufficiale, anche il celebre Liebesträume n.3
(Sogno d'amore) sempre del grande ungherese.
Interpretazioni quest'ultime che superano di
gran lunga quelle di decine di pianisti, anche
di livello, in carriera da decenni. La Meola è
stata l'ultima vincitrice del Premio del
Conservatorio milanese e
 pur
avendo superato i dieci anni d'età solo due
giorni fa, è già in carriera concertistica anche
se gli ulteriori studi che deve fare non possono
che affinare ancor più le sue già eccellenti
qualità. Applausi meritatissimi dal numeroso
pubblico a tutti i giovani protagonisti e ottimo
aperitivo finale. pur
avendo superato i dieci anni d'età solo due
giorni fa, è già in carriera concertistica anche
se gli ulteriori studi che deve fare non possono
che affinare ancor più le sue già eccellenti
qualità. Applausi meritatissimi dal numeroso
pubblico a tutti i giovani protagonisti e ottimo
aperitivo finale.
1 dicembre 2023 Cesare
Guzzardella
AL FESTIVAL CANTELLI DI
NOVARA PROTAGONISTI L’ORCHESTRA FEMMINILE DEL
MEDITERRANEO E IL GIOVANE VIOLONCELLISTA ETTORE
PAGANO
Non
poteva cadere in un momento più opportuno il
secondo concerto della nuova stagione del
Festival Cantelli, tenutosi al Teatro Coccia
ieri sera 30/11. In un momento in cui, anche per
recenti tragici episodi di violenza, la
condizione delle donne nella società del nostro
tempo si è imposta al centro del dibattito
pubblico, l’Associazione Amici della musica V.
Cocito, quasi “di spirito profetico dotata”,
come il Gioacchino da Fiore dantesco, ha
affidato il secondo appuntamento del Festival
Cantelli 2023-24 ad un’orchestra formata da sole
donne, diretta da una donna. Parliamo
dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo (OFM),
fondata nel 2009 e diretta dalla sua fondatrice
Antonella De Angelis, flautista, diplomata in
direzione
 d’orchestra,
avendo avuto Donato Renzetti come suo mentore e
con un’esperienza ormai abbastanza lunga sul
podio, che ha messo pienamente in luce il suo
valore, non solo in Italia, ma in giro per il
mondo. L’OFM, residente in Abruzzo, è
un’orchestra dal marcato carattere
internazionale: una parte significativa delle
strumentiste proviene infatti, oltre
naturalmente che dall’Italia, da ogni angolo
della Terra, dalla Grecia alla Germania, dalla
Corea al Brasile, per menzionare solo una parte
di un elenco molto più lungo. Come riportato dal
programma di sala, il riferimento al
Mediterraneo, luogo per eccellenza di
contrastanti diversità culturali, è ispirato dal
desiderio di fare di quest’orchestra uno spazio
per il confronto e lo scambio di diverse
esperienze in campo musicale, sottolineando come
sulle sponde di questo mare si affacciano Paesi
in cui le donne sono vittime di gravi condizioni
di diseguaglianza. Insomma un’orchestra che è di
per sé simbolo di uno dei problemi più
importanti dei nostri non proprio felici tempi,
ma anche della volontà delle donne di affermarsi
e resistere ad ogni tentativo di emarginarle od
opprimerle. Il programma del concerto proposto
dall’OFM è stato di grande interesse e vedeva,
accanto a tre compositori, anche la presenza di
due compositrici: Marianna Martines apriva la
prima parte del concerto, con l’Ouverture in Do
maggiore per due oboi, due corni e archi, e
Grazyna Bacewicz apriva la seconda con il
Concerto per orchestra d’archi. Nella prima
parte del concerto alla composizione della
Martines seguiva di F. J. Haydn il Concerto n. 2
in Re maggiore per violoncello e orchestra
Hob:VIIb:4, in cui la parte solistica era
affidata ad uno dei migliori e più celebri
violoncellisti della ‘generazione zero’, il
ventenne Ettore Pagano. d’orchestra,
avendo avuto Donato Renzetti come suo mentore e
con un’esperienza ormai abbastanza lunga sul
podio, che ha messo pienamente in luce il suo
valore, non solo in Italia, ma in giro per il
mondo. L’OFM, residente in Abruzzo, è
un’orchestra dal marcato carattere
internazionale: una parte significativa delle
strumentiste proviene infatti, oltre
naturalmente che dall’Italia, da ogni angolo
della Terra, dalla Grecia alla Germania, dalla
Corea al Brasile, per menzionare solo una parte
di un elenco molto più lungo. Come riportato dal
programma di sala, il riferimento al
Mediterraneo, luogo per eccellenza di
contrastanti diversità culturali, è ispirato dal
desiderio di fare di quest’orchestra uno spazio
per il confronto e lo scambio di diverse
esperienze in campo musicale, sottolineando come
sulle sponde di questo mare si affacciano Paesi
in cui le donne sono vittime di gravi condizioni
di diseguaglianza. Insomma un’orchestra che è di
per sé simbolo di uno dei problemi più
importanti dei nostri non proprio felici tempi,
ma anche della volontà delle donne di affermarsi
e resistere ad ogni tentativo di emarginarle od
opprimerle. Il programma del concerto proposto
dall’OFM è stato di grande interesse e vedeva,
accanto a tre compositori, anche la presenza di
due compositrici: Marianna Martines apriva la
prima parte del concerto, con l’Ouverture in Do
maggiore per due oboi, due corni e archi, e
Grazyna Bacewicz apriva la seconda con il
Concerto per orchestra d’archi. Nella prima
parte del concerto alla composizione della
Martines seguiva di F. J. Haydn il Concerto n. 2
in Re maggiore per violoncello e orchestra
Hob:VIIb:4, in cui la parte solistica era
affidata ad uno dei migliori e più celebri
violoncellisti della ‘generazione zero’, il
ventenne Ettore Pagano.
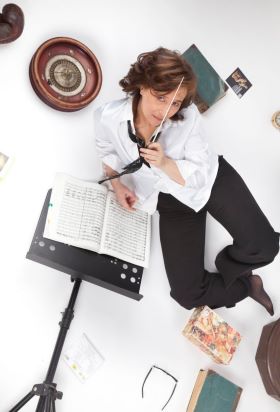 Nella
seconda parte, dopo il pezzo della Bacewicz,
seguiva Fratres di Arvo Part, nella versione per
violoncello, archi e percussioni, e di Giovanni
Sollima Aquilarco : Preludio per violoncello e
orchestra, in un arrangiamento dello stesso
Sollima per l’OFM (l’originale è per violoncello
solo) con, naturalmente Ettore Pagano ancora
solista al violoncello. Un programma, come si
vede, impaginato con un disegno logico rigoroso:
due compositrici al posto d’onore delle due
parti del concerto, la prima parte con due pezzi
del tardo settecento, la seconda tutta
novecentesca, entrambe chiuse da una
composizione per violoncello. Ma vi sono anche
legami meno evidenti, ad esempio quelli che
collegano le due composizioni della prima parte,
l’Ouverture di Martines, e il concerto di Haydn.
Marianna Martines, chi era costei? Sospettiamo
che non sarebbe solo don Abbondio a porsi questa
domanda, perché la Martines (1744-1812) è una
compositrice tanto celebre alla sua epoca,
quanto scivolata oggi nell’ombra. Figlia di un
alto diplomatico spagnolo, trascorse gran parte
della propria vita e morì a Vienna, ove divenne
una protagonista della vita musicale della città:
pupilla di Metastasio, e grazie a lui introdotta
a corte, ove fu assai apprezzata
dall’imperatrice Maria Teresa, amica di Haydn,
che le impartì i primi insegnamenti del
pianoforte (di qui il collegamento col concerto
di Haydn) e soprattutto di Mozart, col quale
suonava spesso il pianoforte a quattro mani e
che le dedicò, appunto, alcune composizioni per
pianoforte a quattro mani. Ammirata come
cantante, apprezzata come clavicembalista e
pianista, fu anche compositrice, e nel suo
catalogo, in cui prevalgono composizioni sacre,
quali Messe, oratori e mottetti, vi è anche
posto per composizioni profane, quali questa
Ouverture. In realtà più che di una Ouverture
nel significato che la parola assunse a partire
dall’800, si tratta di una sinfonia, divisa in
tre tempi, un Allegro moderato in forma sonata,
un Adagio centrale e un Rondò Allegro finale. E’
una composizione chiaramente improntata al
linguaggio musicale della Vienna di Haydn e
Mozart, ma con un tocco di sapienza compositiva
che si riconosce in particolare nei raffinati
impasti timbrici dell’Adagio tra oboi e corni,
sul tappeto sonoro degli archi, e sui
chiaroscuri con passaggi repentini al minore nel
Rondò finale. In generale si tratta di una
composizione di elegante grazia, opera di
un’autrice di gusto raffinato e che si è
appropriata con intelligenza del linguaggio
musicale della sua epoca. Ottima
l’interpretazione di De Angelis, che ha guidato
con finezza la sua orchestra nella resa migliore
delle qualità di questo pezzo, staccando i
giusti tempi per esprimere quella vena briosa e
brillante che impronta i tempi veloci e il
disteso lirismo, coi suoi effetti coloristici
piuttosto originali, del tempo lento. Con il
successivo concerto di Haydn entra in scena
Ettore Pagano, ormai affermatosi nelle nostre
sale da concerto e in un numero impressionante
di concorsi, di cui menzioniamo almeno il
prestigioso Khaciaturjan, come uno dei più
validi violoncellisti italiani del momento,
nonostante la sua giovanissima età. Il secondo
concerto per violoncello di Haydn (1783) è un
banco di prova ideale per consentire a Pagano di
esprimere il proprio talento, in tutti gli
aspetti, tecnici e interpretativi, della sua
personalità musicale. Subito, l’esposizione del
primo tema dell’Allegro moderato iniziale, un
aggraziato cantabile, affascina l’ascoltatore
per le qualità del suono di Nella
seconda parte, dopo il pezzo della Bacewicz,
seguiva Fratres di Arvo Part, nella versione per
violoncello, archi e percussioni, e di Giovanni
Sollima Aquilarco : Preludio per violoncello e
orchestra, in un arrangiamento dello stesso
Sollima per l’OFM (l’originale è per violoncello
solo) con, naturalmente Ettore Pagano ancora
solista al violoncello. Un programma, come si
vede, impaginato con un disegno logico rigoroso:
due compositrici al posto d’onore delle due
parti del concerto, la prima parte con due pezzi
del tardo settecento, la seconda tutta
novecentesca, entrambe chiuse da una
composizione per violoncello. Ma vi sono anche
legami meno evidenti, ad esempio quelli che
collegano le due composizioni della prima parte,
l’Ouverture di Martines, e il concerto di Haydn.
Marianna Martines, chi era costei? Sospettiamo
che non sarebbe solo don Abbondio a porsi questa
domanda, perché la Martines (1744-1812) è una
compositrice tanto celebre alla sua epoca,
quanto scivolata oggi nell’ombra. Figlia di un
alto diplomatico spagnolo, trascorse gran parte
della propria vita e morì a Vienna, ove divenne
una protagonista della vita musicale della città:
pupilla di Metastasio, e grazie a lui introdotta
a corte, ove fu assai apprezzata
dall’imperatrice Maria Teresa, amica di Haydn,
che le impartì i primi insegnamenti del
pianoforte (di qui il collegamento col concerto
di Haydn) e soprattutto di Mozart, col quale
suonava spesso il pianoforte a quattro mani e
che le dedicò, appunto, alcune composizioni per
pianoforte a quattro mani. Ammirata come
cantante, apprezzata come clavicembalista e
pianista, fu anche compositrice, e nel suo
catalogo, in cui prevalgono composizioni sacre,
quali Messe, oratori e mottetti, vi è anche
posto per composizioni profane, quali questa
Ouverture. In realtà più che di una Ouverture
nel significato che la parola assunse a partire
dall’800, si tratta di una sinfonia, divisa in
tre tempi, un Allegro moderato in forma sonata,
un Adagio centrale e un Rondò Allegro finale. E’
una composizione chiaramente improntata al
linguaggio musicale della Vienna di Haydn e
Mozart, ma con un tocco di sapienza compositiva
che si riconosce in particolare nei raffinati
impasti timbrici dell’Adagio tra oboi e corni,
sul tappeto sonoro degli archi, e sui
chiaroscuri con passaggi repentini al minore nel
Rondò finale. In generale si tratta di una
composizione di elegante grazia, opera di
un’autrice di gusto raffinato e che si è
appropriata con intelligenza del linguaggio
musicale della sua epoca. Ottima
l’interpretazione di De Angelis, che ha guidato
con finezza la sua orchestra nella resa migliore
delle qualità di questo pezzo, staccando i
giusti tempi per esprimere quella vena briosa e
brillante che impronta i tempi veloci e il
disteso lirismo, coi suoi effetti coloristici
piuttosto originali, del tempo lento. Con il
successivo concerto di Haydn entra in scena
Ettore Pagano, ormai affermatosi nelle nostre
sale da concerto e in un numero impressionante
di concorsi, di cui menzioniamo almeno il
prestigioso Khaciaturjan, come uno dei più
validi violoncellisti italiani del momento,
nonostante la sua giovanissima età. Il secondo
concerto per violoncello di Haydn (1783) è un
banco di prova ideale per consentire a Pagano di
esprimere il proprio talento, in tutti gli
aspetti, tecnici e interpretativi, della sua
personalità musicale. Subito, l’esposizione del
primo tema dell’Allegro moderato iniziale, un
aggraziato cantabile, affascina l’ascoltatore
per le qualità del suono di
 Pagano,
un bellissimo suono omogeneo e pieno, di
cristallina musicalità negli acuti, che nel
secondo tema, esposto su un registro grave, si
carica di una tinta calda e di seducente
morbidezza. Il particolare sviluppo di questo
movimento, molto libero, è eseguito dal giovane
solista con un fraseggio di estrema fluidità,
che sa essere elegante e al tempo stesso
intensamente espressivo, grazie alla sensibilità
raffinata della gamma variegata dei registri
dinamici, esplorata con rara perizia, in tutta
la ricchezza dele sue sfumature, ma sempre
guidata da una cantabilità ‘violinistica’ di
grande suggestione emotiva. Il violoncello di
Pagano sa raggiungere vertici espressivi di
grande suggestione nell’Adagio, che è in
sostanza un assolo per violoncello, in
particolare quando attinge le zone acute, in cui
il suono perde ogni ‘meccanicità’ di un
virtuosismo puramente tecnico, per farsi pathos
vibrante, scavato alle radici stesse del suono.
Il finale Rondò, col suo rapido tema danzante di
robusto sapore popolareggiante tipicamente
haydniano, fa emergere infine tutta l’energia di
suono e il controllo tecnico di cui Pagano è
capace: ardue doppie corde, spiccati e
quant’altro diventano, nelle arcate sempre
limpide e precise del giovane Maestro, non mero
esibizionismo esteriore, ma mezzi espressivi che
intensificano lo splendore sonoro di questo
movimento, coinvolgendo emotivamente
l’ascoltatore. Grazie anche ad un’intesa
perfetta con l’orchestra, impeccabilmente
guidata da De Angelis nella scelta dei tempi e
nell’accurato controllo dei colori orchestrali,
Ettore Pagano ha offerto al pubblico una
bellissima esecuzione di questo gioiello del
classicismo viennese, che ha suscitato gli
applausi scroscianti e prolungati del pubblico.
La seconda parte del concerto è stata nuovamente
introdotta da una compositrice, la polacca
Grazyna Bacewicz (1909-1969), poco conosciuta
fuori dei confini della Polonia, ove è al
contrario una delle musiciste più amate e
stimate del ‘900: notevole violinista e
compositrice, soprattutto di musica per il suo
strumento, ma ieri sera presente con il suo
Concerto per orchestra d’archi (1948).
Composizione aliena da ogni sperimentalismo
avanguardistico seriale, allora in gran voga,
che pure si veniva affacciando anche in Polonia
con Lutoslawsky, di impianto fondamentalmente
tonale, questo concerto, diviso nei tradizionali
tre tempi, si caratterizza per il sapiente gioco
timbrico tra le diverse sezioni degli archi, in
cui talvolta il gruppo degli archi gravi sembra
proporsi quasi come il concertino del Concerto
grosso barocco, mentre si staccano talora dal
tutto orchestrale delicati assoli del violino,
della viola e del violoncello. I tre tempi
disegnano una sorta di percorso spirituale
ascendente, con un primo tempo ricco di
contrasti, nei temi, nelle dinamiche e nei
timbri, col ripetersi di un breve inciso
tematico che sembra esprimere tensione e
angoscia, al tempo lento centrale che è un canto
elegiaco di dolore, al finale più disteso e
luminoso. Il raffinato trattamento delle varie
sezioni degli archi, il gioco stupendo di colori
che la compositrice polacca riesce a ottenere (forse
retaggio di certi capolavori del compatriota
Szymanowsky, quali la sua Sinfonia n.3) sono
stati realizzati al meglio dall’impeccabile
esecuzione dell’OFM, sotto la sapiente bacchetta
di De Angelis,. Un plauso particolare, oltre
alla direttrice, va tributato al primo violino,
Patrizia De Carlo, alla prima viola Olga Moryn e
al primo violoncello Elisa Pennica. A seguire
uno dei più noti brani, di uno dei più celebri
autori contemporanei: Fratres di Arvo Pärt, in
una delle sue tante versioni, quella per
violoncello, archi e percussioni. E’ nei suoi
momenti di più rarefatta ed estatica sospensione,
quando l’orchestra e il violoncello sembrano ‘sfiorare’
il suono, che la tintinnabulazione di Part
sortisce gli effetti di più alta suggestione,
quasi ipnotica, sull’ascoltatore. Il suono del
violoncello di Pagano, venando il tappeto sonoro
degli archi e il ritmo appena scandito delle
percussioni di un sommesso respiro dal timbro
vellutato e sfumato all’estremo, crea un ‘aura
di mistero, che avvolge lo spettatore in una
dimensione indefinita. Eccellente prova e del
solista e dell’OFM con la sua direttrice, per la
scelta dei tempi, delle dinamiche dei colori, di
questo capolavoro. Il concerto si chiudeva con
un pezzo di quello che attualmente è il
violoncello stesso in Italia, all’estremo limite
delle sue possibilità sonore, cioè Giovanni
Sollima di cui è stato proposto, come detto
sopra, il Preludio di Aquilarco, arrangiato per
orchestra e violoncello. Come spiega lo stesso
Sollima, aquilarco è una parola che nasce dalla
fusione (crasi) di due parole, aquilone e arco,
quello del violoncello. Indica dunque una musica
che si libra come in volo, simile ad un aquilone,
la storia musicale di un volo insomma.
Nell’interpretazione di questo pezzo, Pagano ci
dà un’altra prova delle sue straordinarie
qualità d’interprete cavando dal suo violoncello
un suono che è energia pura, ritmicamente
travolgente, sostenuta da uno stile compositivo,
qui adottato da Sollima, molto vicino al
minimalismo: non a caso l’opera nacque su
commissione di un’etichetta musicale diretta
allora (1998) da Philipp Glass, uno dei padri
del minimalismo. E proprio l’energia pura del
violoncello di Pagano, abbandonandosi al ritmo
incalzante nella sua iteratività minimalistica e
sostenuto dall’orchestra, sempre efficacemente
diretta da De Angelis, ha davvero evocato coi
suoni la forza di un volo che non conosce
ostacoli, che libero da ogni limite spazia in
una sorta di ‘quarta dimensione’, quella magica
del suono e delle emozioni che essa sola sa
suscitare nella mente dell’uomo, quando
l’ascolta. Davvero un bellissimo concerto, che
non dimenticheremo, tra i più affascinanti
ascoltati a Novara negli ultimi anni e che ha
ricevuto dal pubblico, affollato in platea, il
giusto tributo di applausi, premiato con un bis,
il primo movimento della Suite per violoncello e
orchestra della compositrice contemporanea finlandese Viktoria Yangling: un pezzo molto
bello, costruito su un tema melodico di
struggente dolcezza. Pagano,
un bellissimo suono omogeneo e pieno, di
cristallina musicalità negli acuti, che nel
secondo tema, esposto su un registro grave, si
carica di una tinta calda e di seducente
morbidezza. Il particolare sviluppo di questo
movimento, molto libero, è eseguito dal giovane
solista con un fraseggio di estrema fluidità,
che sa essere elegante e al tempo stesso
intensamente espressivo, grazie alla sensibilità
raffinata della gamma variegata dei registri
dinamici, esplorata con rara perizia, in tutta
la ricchezza dele sue sfumature, ma sempre
guidata da una cantabilità ‘violinistica’ di
grande suggestione emotiva. Il violoncello di
Pagano sa raggiungere vertici espressivi di
grande suggestione nell’Adagio, che è in
sostanza un assolo per violoncello, in
particolare quando attinge le zone acute, in cui
il suono perde ogni ‘meccanicità’ di un
virtuosismo puramente tecnico, per farsi pathos
vibrante, scavato alle radici stesse del suono.
Il finale Rondò, col suo rapido tema danzante di
robusto sapore popolareggiante tipicamente
haydniano, fa emergere infine tutta l’energia di
suono e il controllo tecnico di cui Pagano è
capace: ardue doppie corde, spiccati e
quant’altro diventano, nelle arcate sempre
limpide e precise del giovane Maestro, non mero
esibizionismo esteriore, ma mezzi espressivi che
intensificano lo splendore sonoro di questo
movimento, coinvolgendo emotivamente
l’ascoltatore. Grazie anche ad un’intesa
perfetta con l’orchestra, impeccabilmente
guidata da De Angelis nella scelta dei tempi e
nell’accurato controllo dei colori orchestrali,
Ettore Pagano ha offerto al pubblico una
bellissima esecuzione di questo gioiello del
classicismo viennese, che ha suscitato gli
applausi scroscianti e prolungati del pubblico.
La seconda parte del concerto è stata nuovamente
introdotta da una compositrice, la polacca
Grazyna Bacewicz (1909-1969), poco conosciuta
fuori dei confini della Polonia, ove è al
contrario una delle musiciste più amate e
stimate del ‘900: notevole violinista e
compositrice, soprattutto di musica per il suo
strumento, ma ieri sera presente con il suo
Concerto per orchestra d’archi (1948).
Composizione aliena da ogni sperimentalismo
avanguardistico seriale, allora in gran voga,
che pure si veniva affacciando anche in Polonia
con Lutoslawsky, di impianto fondamentalmente
tonale, questo concerto, diviso nei tradizionali
tre tempi, si caratterizza per il sapiente gioco
timbrico tra le diverse sezioni degli archi, in
cui talvolta il gruppo degli archi gravi sembra
proporsi quasi come il concertino del Concerto
grosso barocco, mentre si staccano talora dal
tutto orchestrale delicati assoli del violino,
della viola e del violoncello. I tre tempi
disegnano una sorta di percorso spirituale
ascendente, con un primo tempo ricco di
contrasti, nei temi, nelle dinamiche e nei
timbri, col ripetersi di un breve inciso
tematico che sembra esprimere tensione e
angoscia, al tempo lento centrale che è un canto
elegiaco di dolore, al finale più disteso e
luminoso. Il raffinato trattamento delle varie
sezioni degli archi, il gioco stupendo di colori
che la compositrice polacca riesce a ottenere (forse
retaggio di certi capolavori del compatriota
Szymanowsky, quali la sua Sinfonia n.3) sono
stati realizzati al meglio dall’impeccabile
esecuzione dell’OFM, sotto la sapiente bacchetta
di De Angelis,. Un plauso particolare, oltre
alla direttrice, va tributato al primo violino,
Patrizia De Carlo, alla prima viola Olga Moryn e
al primo violoncello Elisa Pennica. A seguire
uno dei più noti brani, di uno dei più celebri
autori contemporanei: Fratres di Arvo Pärt, in
una delle sue tante versioni, quella per
violoncello, archi e percussioni. E’ nei suoi
momenti di più rarefatta ed estatica sospensione,
quando l’orchestra e il violoncello sembrano ‘sfiorare’
il suono, che la tintinnabulazione di Part
sortisce gli effetti di più alta suggestione,
quasi ipnotica, sull’ascoltatore. Il suono del
violoncello di Pagano, venando il tappeto sonoro
degli archi e il ritmo appena scandito delle
percussioni di un sommesso respiro dal timbro
vellutato e sfumato all’estremo, crea un ‘aura
di mistero, che avvolge lo spettatore in una
dimensione indefinita. Eccellente prova e del
solista e dell’OFM con la sua direttrice, per la
scelta dei tempi, delle dinamiche dei colori, di
questo capolavoro. Il concerto si chiudeva con
un pezzo di quello che attualmente è il
violoncello stesso in Italia, all’estremo limite
delle sue possibilità sonore, cioè Giovanni
Sollima di cui è stato proposto, come detto
sopra, il Preludio di Aquilarco, arrangiato per
orchestra e violoncello. Come spiega lo stesso
Sollima, aquilarco è una parola che nasce dalla
fusione (crasi) di due parole, aquilone e arco,
quello del violoncello. Indica dunque una musica
che si libra come in volo, simile ad un aquilone,
la storia musicale di un volo insomma.
Nell’interpretazione di questo pezzo, Pagano ci
dà un’altra prova delle sue straordinarie
qualità d’interprete cavando dal suo violoncello
un suono che è energia pura, ritmicamente
travolgente, sostenuta da uno stile compositivo,
qui adottato da Sollima, molto vicino al
minimalismo: non a caso l’opera nacque su
commissione di un’etichetta musicale diretta
allora (1998) da Philipp Glass, uno dei padri
del minimalismo. E proprio l’energia pura del
violoncello di Pagano, abbandonandosi al ritmo
incalzante nella sua iteratività minimalistica e
sostenuto dall’orchestra, sempre efficacemente
diretta da De Angelis, ha davvero evocato coi
suoni la forza di un volo che non conosce
ostacoli, che libero da ogni limite spazia in
una sorta di ‘quarta dimensione’, quella magica
del suono e delle emozioni che essa sola sa
suscitare nella mente dell’uomo, quando
l’ascolta. Davvero un bellissimo concerto, che
non dimenticheremo, tra i più affascinanti
ascoltati a Novara negli ultimi anni e che ha
ricevuto dal pubblico, affollato in platea, il
giusto tributo di applausi, premiato con un bis,
il primo movimento della Suite per violoncello e
orchestra della compositrice contemporanea finlandese Viktoria Yangling: un pezzo molto
bello, costruito su un tema melodico di
struggente dolcezza.
1 dicembre 2023 Bruno Busca
NOVEMBRE 2023 -
La Nürnberger
Symphoniker di Darlington e il pianista Masleev
in Conservatorio
La
Nürnberger Symphoniker diretta da Jonathan
Darlington è stata protagonista della serata
organizzata dalla Società dei Concerti
con brani di Stravinskij, Rachmaninov e
Schumann. Il neoclassicismo stravinskijano, uno
dei molti modi di esprimersi del grande
 compositore
russo, ha introdotto il concerto attraverso
Jeu de Cartes- Ballet en trois Donnes, una
musica per balletto scritta per il grande
coreografo Balanchine nel 1936 che rivela
l'abilità di Stravinskij nell' utilizzare le
esperienze passate per ricostruire un mondo
musicale fatto di timbriche geometriche,
oggettive nello sviluppo architettonico, adatte
agli equilibri simmetrici dei danzatori. Una
resa ricca di energia quella fornita da
Darlington e dalla sua
orchestra. Il secondo brano in programma, la
celebre Rapsodia su un tema di Paganini per
pianoforte e orchestra op.43 ha trovato un
protagonista d'eccezione nel nome di Dmitry
Masleev, compositore
russo, ha introdotto il concerto attraverso
Jeu de Cartes- Ballet en trois Donnes, una
musica per balletto scritta per il grande
coreografo Balanchine nel 1936 che rivela
l'abilità di Stravinskij nell' utilizzare le
esperienze passate per ricostruire un mondo
musicale fatto di timbriche geometriche,
oggettive nello sviluppo architettonico, adatte
agli equilibri simmetrici dei danzatori. Una
resa ricca di energia quella fornita da
Darlington e dalla sua
orchestra. Il secondo brano in programma, la
celebre Rapsodia su un tema di Paganini per
pianoforte e orchestra op.43 ha trovato un
protagonista d'eccezione nel nome di Dmitry
Masleev,
 un
virtuoso del pianoforte venuto alla ribalta dopo
la prestigiosa vittoria del Concorso
Internazionale
Čaikovskij di Mosca nel 2015. Le 24
variazioni sul noto tema paganiniano, che il
secondo grande musicista russo della serata
prese da uno dei più
celebri Capricci
del virtuoso genovese, sono state esaltate
dall'incredibile tecnica del giovane pianista
russo che sembra rendere semplice ogni difficile
passaggio del brano. Coadiuvato dall'ottima
orchestra e dal direttore, Masleev ha deliniato
con chiarezza ogni dettaglio delle variazioni,
esprimendo, oltre che sicurezza, palpabile
espressività. Ancora in ambito virtuosistico il
bis solistico concesso con un noto brano di
Nicolai Kapustin: uno dei suoi studi più noti
tra il classico e il jazz, un
virtuoso del pianoforte venuto alla ribalta dopo
la prestigiosa vittoria del Concorso
Internazionale
Čaikovskij di Mosca nel 2015. Le 24
variazioni sul noto tema paganiniano, che il
secondo grande musicista russo della serata
prese da uno dei più
celebri Capricci
del virtuoso genovese, sono state esaltate
dall'incredibile tecnica del giovane pianista
russo che sembra rendere semplice ogni difficile
passaggio del brano. Coadiuvato dall'ottima
orchestra e dal direttore, Masleev ha deliniato
con chiarezza ogni dettaglio delle variazioni,
esprimendo, oltre che sicurezza, palpabile
espressività. Ancora in ambito virtuosistico il
bis solistico concesso con un noto brano di
Nicolai Kapustin: uno dei suoi studi più noti
tra il classico e il jazz, il Concert Étude op.40 n.1, eseguito
senza un minimo cedimento nella rapida
successione ritmica e con rigore stilistico
impeccabile. Applausi fragorosi dal numeroso
pubblico presente in Sala Verdi. Dopo
l'intervallo, andando a ritroso nel tempo di
oltre cento anni dal brano di Rachmaninov, siamo
arrivati a Robert Schumann con la sua
Sinfonia n.2 in do magg. op.61.
Un'interpretazione chiara, dettagliata e ancora
energica quella di Darlington, tra i rapidi
movimenti laterali, due Allegri, un
delizioso Scherzo di grande equilibrio
formale e un intenso Adagio espressivo,
il movimento più caratterizzante dello splendido
ampio lavoro. Ancora intensi gli applausi e come
bis orchestrale la celebre Danza ungherese
n.5 di Johannes Brahms. Grande successo.
il Concert Étude op.40 n.1, eseguito
senza un minimo cedimento nella rapida
successione ritmica e con rigore stilistico
impeccabile. Applausi fragorosi dal numeroso
pubblico presente in Sala Verdi. Dopo
l'intervallo, andando a ritroso nel tempo di
oltre cento anni dal brano di Rachmaninov, siamo
arrivati a Robert Schumann con la sua
Sinfonia n.2 in do magg. op.61.
Un'interpretazione chiara, dettagliata e ancora
energica quella di Darlington, tra i rapidi
movimenti laterali, due Allegri, un
delizioso Scherzo di grande equilibrio
formale e un intenso Adagio espressivo,
il movimento più caratterizzante dello splendido
ampio lavoro. Ancora intensi gli applausi e come
bis orchestrale la celebre Danza ungherese
n.5 di Johannes Brahms. Grande successo.
29 novembre
2023 Cesare Guzzardella
Le compositrici
da ri-scoprire al
Museo del Novecento milanese
Un
pomeriggio musicale di grande interesse quello
di ieri a Milano, nella Sala Fontana del Museo
del Novecento: musiche "al femminile" di
compositrici da scoprire o riscoprire, che ci
hanno rivelato qualità di scrittura musicale
assai importante, sono state eseguite in
occasione della Giornata internazionale contro
la violenza
 sulle
donne. Brani di Mélanie Bonis (1858-1937) e
Cécile Chaminade (1857-1944), e della vivente
Simona Simonini (1943) sono stati interpretati
con espressività da Katia Caradonna e Silvia
Leggio, al pianoforte, e da Sergio Bonetti al
flauto. Un impaginato introdotto dal prof.
Enrico Reggiani, dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, il quale ha evidenziato
l'importante ruolo delle prime due compositrici
francesi nel contesto musicale del periodo
storico nel quale sono vissute, avendo spesso
anticipato modalità di scrittura di musicisti
entrati nella storia quali Debussy, Ravel,
Franck, Fauré ed altri ancora. Partendo da due
Valzer per sulle
donne. Brani di Mélanie Bonis (1858-1937) e
Cécile Chaminade (1857-1944), e della vivente
Simona Simonini (1943) sono stati interpretati
con espressività da Katia Caradonna e Silvia
Leggio, al pianoforte, e da Sergio Bonetti al
flauto. Un impaginato introdotto dal prof.
Enrico Reggiani, dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, il quale ha evidenziato
l'importante ruolo delle prime due compositrici
francesi nel contesto musicale del periodo
storico nel quale sono vissute, avendo spesso
anticipato modalità di scrittura di musicisti
entrati nella storia quali Debussy, Ravel,
Franck, Fauré ed altri ancora. Partendo da due
Valzer per
 pianoforte
a quattro mani da "Suite en forme de valses"
della Bonis e continuando con i "6 Pièces
romantiques" della Chaminade, sempre a
quattro mani, si è passati poi al duo per flauto
e pianoforte di Bonetti-Caradonna (duo col nome
d'arte Art Music Youkali) per la "Sérénade
aux etoilés", sempre della Chaminade. Valido
il brano "Lamento" in Prima Esecuzione
Italiana della compositrice Simonini. Per
concludere, una più complessa "Sonata in do
diesis minore per flauto e pianoforte" della
Bonis. pianoforte
a quattro mani da "Suite en forme de valses"
della Bonis e continuando con i "6 Pièces
romantiques" della Chaminade, sempre a
quattro mani, si è passati poi al duo per flauto
e pianoforte di Bonetti-Caradonna (duo col nome
d'arte Art Music Youkali) per la "Sérénade
aux etoilés", sempre della Chaminade. Valido
il brano "Lamento" in Prima Esecuzione
Italiana della compositrice Simonini. Per
concludere, una più complessa "Sonata in do
diesis minore per flauto e pianoforte" della
Bonis.
 Le
valide interpretazioni dei brani francesi, hanno
rivelato una musica abilmente costruita,
particolarmente delicata e trasparente,
rivelatrice di una forma d'eleganza tipicamente
francese che noi conosciamo dai compositori più
celebrati. Costruito molto bene, il lavoro di
Simona Simonini è un esempio di ottima scrittura
musicale con un segno forte nel dialogo tra
pianoforte e flauto mirabilmente interpretato
dal duo. Rilevante il bis con un Notturno
per flauto e pianoforte di Lili Boulanger
preceduto dalla lettura di due poesie di Emily
Dickinson. Applausi fragorosi dal folto pubblico. Le
valide interpretazioni dei brani francesi, hanno
rivelato una musica abilmente costruita,
particolarmente delicata e trasparente,
rivelatrice di una forma d'eleganza tipicamente
francese che noi conosciamo dai compositori più
celebrati. Costruito molto bene, il lavoro di
Simona Simonini è un esempio di ottima scrittura
musicale con un segno forte nel dialogo tra
pianoforte e flauto mirabilmente interpretato
dal duo. Rilevante il bis con un Notturno
per flauto e pianoforte di Lili Boulanger
preceduto dalla lettura di due poesie di Emily
Dickinson. Applausi fragorosi dal folto pubblico.
28 novembre 2023 Cesare
Guzzardella
Giovanni Sollima
e le Suites per violoncello solo di Bach alle
Serate Musicali
Siamo
abituati ad ascoltare il violoncellista
palermitano Giovanni Sollima in programmi
diversificati, con brani classici in alternanza
a rivisitazioni o a suoi brani, essendo, oltre
che tra i migliori violoncellisti sulla scena
internazionale, anche rinomato compositore. Ieri
sera, al concerto di Serate Musicali, ha
voluto
 impaginare
un programma tutto dedicato a J.S.Bach, con una
delle opere più note del genio tedesco, le
Sei Suites per Violoncello solo, lavori
composti presumibilmente nel periodo di Köthen
tra il 1717 e il 1723. Un concerto impegnativo
di circa due ore e tranta minuti di musica, dove
i sei brani sono stati eseguiti con una non
breve interruzione dopo le prime tre suites.
Questi capolavori rappresentano un cavallo di
battaglia per tutti i grandi interpreti, oltre
ad essere brani di importante valenza didattica
per gli studenti dei conservatori di musica. La
forte personalità interpretativa di Sollima non
è mai disgiunta dalla sua voglia di ri-creare. impaginare
un programma tutto dedicato a J.S.Bach, con una
delle opere più note del genio tedesco, le
Sei Suites per Violoncello solo, lavori
composti presumibilmente nel periodo di Köthen
tra il 1717 e il 1723. Un concerto impegnativo
di circa due ore e tranta minuti di musica, dove
i sei brani sono stati eseguiti con una non
breve interruzione dopo le prime tre suites.
Questi capolavori rappresentano un cavallo di
battaglia per tutti i grandi interpreti, oltre
ad essere brani di importante valenza didattica
per gli studenti dei conservatori di musica. La
forte personalità interpretativa di Sollima non
è mai disgiunta dalla sua voglia di ri-creare.
 Anche
eseguendo Bach ha voluto dire qualcosa di suo,
sia introducendo prima di ogni suite una
sorta di sua aria introduttiva di poche note,
sia mediante una linea interpretativa dove la
personalizzazione del materiale bachiano risulta
evidente. La sua sintesi discorsiva, con tempi
spesso rapidi, ha rivelato un Bach perfettamente
interiorizzato per un'esecuzione tutta a memoria
e per una restituzione di particolare valore
espressivo. La capacità di Sollima di ritrovare
colori antichi, con una tecnica atta a produrre
un carattere improvvisatorio risulta evidente.
Seguendo le direttive del grande di Eisenach,
Sollima ha eseguito la penultima suite,
quella in Anche
eseguendo Bach ha voluto dire qualcosa di suo,
sia introducendo prima di ogni suite una
sorta di sua aria introduttiva di poche note,
sia mediante una linea interpretativa dove la
personalizzazione del materiale bachiano risulta
evidente. La sua sintesi discorsiva, con tempi
spesso rapidi, ha rivelato un Bach perfettamente
interiorizzato per un'esecuzione tutta a memoria
e per una restituzione di particolare valore
espressivo. La capacità di Sollima di ritrovare
colori antichi, con una tecnica atta a produrre
un carattere improvvisatorio risulta evidente.
Seguendo le direttive del grande di Eisenach,
Sollima ha eseguito la penultima suite,
quella in
 do
minore utilizzando una "scordatura" delle
corde più basse ed interpretando l'ultima
suite, quella in re maggiore, con un
violoncello a cinque corde, ritrovando qui
colori diversi in registri più alti e mettendoci
ogni tanto qualcosa di suo. L'originalità delle
sue interpretazioni non si discute e
l'apprezzamento del pubblico è risultato
caloroso con applausi fragorosi continuativi.
Dopo il lungo Bach, il cellista siciliano ha
voluto omaggiare i numerosi presenti in Sala
Verdi con due sorprendenti bis, il primo un
Fandango di Sollima-Boccherini e il secondo
un classico di Sollima con un' antica melodia
popolare resa in modo straordinario
dall'infinita quantità di abbellimenti. Un
grande. (prime due foto di Alberto Panzani
Uff.stampa Serate Musicali) do
minore utilizzando una "scordatura" delle
corde più basse ed interpretando l'ultima
suite, quella in re maggiore, con un
violoncello a cinque corde, ritrovando qui
colori diversi in registri più alti e mettendoci
ogni tanto qualcosa di suo. L'originalità delle
sue interpretazioni non si discute e
l'apprezzamento del pubblico è risultato
caloroso con applausi fragorosi continuativi.
Dopo il lungo Bach, il cellista siciliano ha
voluto omaggiare i numerosi presenti in Sala
Verdi con due sorprendenti bis, il primo un
Fandango di Sollima-Boccherini e il secondo
un classico di Sollima con un' antica melodia
popolare resa in modo straordinario
dall'infinita quantità di abbellimenti. Un
grande. (prime due foto di Alberto Panzani
Uff.stampa Serate Musicali)
28 novembre 2023 Cesare
Guzzardella
Ai Lieti Calici
milanesi Andrea
Trovato e Michele Fontana interpretano Galuppi
Una
mattinata molto interessante quella seguita ieri
agli Amici del Loggione del Teatro alla Scala
di via Silvio Pellico 6. La musica del
veneziano Baldassare Galuppi (1706-1785) è stata
evidenziata da due ottimi pianisti quali Andrea
Trovato e Michele Fontana alla rassegna Lieti
Calici. Attualmente i due interpreti sono
impegnati in un'integrale d'incisioni del
musicista di Burano per strumenti a tastiera.
Due incisioni sono già recentemente uscite con
alcune sonate eseguite al pianoforte da Fontana
e all'organo da Trovato. Il
 concerto,
organizzato da Mario Marcarini, è stato
anticipato da una sua introduzione alla musica
del grande compositore-tastierista, quindi
alcune sonate sono state eseguite al pianoforte
prima da Fontana e poi da Trovato, con rilevanti
qualità interpretative. concerto,
organizzato da Mario Marcarini, è stato
anticipato da una sua introduzione alla musica
del grande compositore-tastierista, quindi
alcune sonate sono state eseguite al pianoforte
prima da Fontana e poi da Trovato, con rilevanti
qualità interpretative.
 Ascolti
registrati di alcune di esse sono stati anche
presentati nella versione organistica,
completate da una particolareggiata spiegazione
di Trovato che ha reso ancor più completa la
presentazione alla musica di Baldassare Galuppi.
Compositore fecondo nel campo strumentale e
operistico è purtroppo
molto trascurato ai giorni nostri. Un importante
musicista che andrebbe recuperato alle
esecuzioni in sala da concerto. I due interpreti
hanno anche concesso un fuori-programma con una
Sonata sempre di Galuppi eseguita a quattro mani.
Applausi calorosi e, come al solito, al termine
un brindisi con ottimi vini ben accompagnati da
cibi caldi. Ascolti
registrati di alcune di esse sono stati anche
presentati nella versione organistica,
completate da una particolareggiata spiegazione
di Trovato che ha reso ancor più completa la
presentazione alla musica di Baldassare Galuppi.
Compositore fecondo nel campo strumentale e
operistico è purtroppo
molto trascurato ai giorni nostri. Un importante
musicista che andrebbe recuperato alle
esecuzioni in sala da concerto. I due interpreti
hanno anche concesso un fuori-programma con una
Sonata sempre di Galuppi eseguita a quattro mani.
Applausi calorosi e, come al solito, al termine
un brindisi con ottimi vini ben accompagnati da
cibi caldi.
27-11-23 Cesare Guzzardella
ORGANO E MUSICA DA CAMERA PER
I CONCERTI DEL SABATO DEL CONSERVATORIO G.
CANTELLI DI NOVARA
I ‘Concerti
del Sabato’, la lunga stagione, da novembre a
maggio, di concerti del Conservatorio G.
Cantelli di Novara, ha come sua caratteristica
accattivante quella di proporre all’ascolto
opere e autori in genere non molto eseguiti
nelle nostre sale da concerto ,ma, quasi sempre,
di notevole interesse e valore musicale. Così è
stato anche per il concerto di ieri, Sabato
25/11, impaginato su due composizioni di
sorprendente qualità, cui non ci pare
corrispondere adeguata fama presso il pubblico.
Parliamo della Sonata per organo n.11 in re min.
op.148, una delle venti sonate composte da
quello che fu uno dei più grandi organisti e
compositori per organo del secondo ‘800, Josef
Gabriel Rheinberger (1839-1901), nativo del
Lichtenstein, ma la cui vita musicale si svolse
prevalentemente in Germania. A suo tempo, fu
considerato il miglior compositore ottocentesco
per organo, dopo Mendelssohn. L’esecuzione della
sua Sonata n.11 era affidata al giovane
organista Giulio De Consoli, uno dei migliori
allievi della classe di organo del Cantelli, che
ha fornito un’ottima interpretazione di questo
gioiello della musica per organo a canne. Si
tratta di una composizione complessa, in quattro
movimenti, che riproducono lo schema classico
della Sinfonia che, sul tappeto sonoro di un
 contrappunto
talora denso e complesso armonicamente, svolge
una trama musicale inquieta, ricca di contrasti,
tipicamente romantica, ma sempre espressa con
quella particolare nobiltà di suono che è
caratteristica di questo strumento. De Consoli,
con una gestione notevole, per sensibilità e
gusto, dell’agogica, dei piani dinamici e della
timbrica, unita ad una padronanza completa della
tecnica organistica, ha interpretato al meglio
questo pezzo, dall’Allegro molto iniziale, col
suo ritmo inquieto e incalzante, smorzato da
rare pause di quieta meditazione, e il cui tema
principale, variamente trasformato, ritorna in
tutta la sonata, alla bellissima Cantilena del
secondo tempo, il momento più affascinante della
sonata, un tempo lento (come vuole appunto, lo
schema della Sinfonia) in cui si sviluppa una
melodia di estatica cantabilità, che sembra
espandersi all’infinito e a cui
l’interpretazione di De Consoli ha dato il
carattere di una dolcissima preghiera.
Impeccabili, per precisione tecnica e finezza di
gusto interpretativo, anche l’esecuzione
dell’Intermezzo ( lo Scherzo della sinfonia),
con un Trio particolarmente suggestivo per il
carattere spigoloso e nervoso che lo impronta, e
infine quella della bella Fuga conclusiva, in
cui culmina il tessuto contrappuntistico della
Sonata. Si tratta, secondo una tendenza tipica
dell’800, di una fuga che subisce fortemente
l’influsso della forma sonata, sia per gli
sviluppi armonici, esclusi dalla forma classica,
bachiana, della fuga, sia per il maggior spazio
che acquistano materiali tematici e motivici
estranei allo schema
soggetto-risposta-contrasoggetto. Tutto questo
complesso mondo sonoro è stato evocato da De
Consoli con limpidezza nel disegno formale
dell’architettura del movimento, riscuotendo un
notevole successo di pubblico, che gli ha
tributato un lungo applauso. La seconda parte
del concerto ha invece proposto un Trio di Carl
Maria von Weber, quello in Sol min. op. 63, per
pianoforte, flauto e violoncello. Al pianoforte
sedeva Sofia Ripoldi, al flauto Martina Soffiati,
al violoncello Eleonora Sassone, tutte, anche
loro, apprezzate allieve del Cantelli. Questo
Trio op.63 (1819) di von Weber è un delizioso
cammeo zampillante di melodie ispirate da grazia
e da garbata eleganza, con qualche sentore
schubertiano qua e là: il sol minore di Weber è
certo altra cosa dal sol minore mozartiano. Le
tre giovani esecutrici, molto precise e sicure
nelle entrate e nel vario intreccio dei
rispettivi strumenti, sono state decisamente
brave nella resa dei suggestivi impasti timbrici
della composizione, che raggiungono il risultato
più alto nel Finale Allegro, di impagabile
felicità melodica. Bravi tutti e tre, ma un
plauso particolare va rivolto a Martina Soffiati,
davvero eccellente nelle parti in assolo che le
toccano nella sezione centrale dello Scherzo,
con un tema tra i più luminosi dell’intero pezzo,
e nel successivo Andante espressivo, lo Shlafer
Klage, il lamento del pastore, un’aria bucolica
di stampo francese, eseguita da Soffiati con
finezza ed eleganza perfette. Un piacevolissimo
concerto, che ha strappato prolungati applausi
al pubblico di fedeli frequentatori dei Sabati
del Cantelli, non ripagati da alcun bis. contrappunto
talora denso e complesso armonicamente, svolge
una trama musicale inquieta, ricca di contrasti,
tipicamente romantica, ma sempre espressa con
quella particolare nobiltà di suono che è
caratteristica di questo strumento. De Consoli,
con una gestione notevole, per sensibilità e
gusto, dell’agogica, dei piani dinamici e della
timbrica, unita ad una padronanza completa della
tecnica organistica, ha interpretato al meglio
questo pezzo, dall’Allegro molto iniziale, col
suo ritmo inquieto e incalzante, smorzato da
rare pause di quieta meditazione, e il cui tema
principale, variamente trasformato, ritorna in
tutta la sonata, alla bellissima Cantilena del
secondo tempo, il momento più affascinante della
sonata, un tempo lento (come vuole appunto, lo
schema della Sinfonia) in cui si sviluppa una
melodia di estatica cantabilità, che sembra
espandersi all’infinito e a cui
l’interpretazione di De Consoli ha dato il
carattere di una dolcissima preghiera.
Impeccabili, per precisione tecnica e finezza di
gusto interpretativo, anche l’esecuzione
dell’Intermezzo ( lo Scherzo della sinfonia),
con un Trio particolarmente suggestivo per il
carattere spigoloso e nervoso che lo impronta, e
infine quella della bella Fuga conclusiva, in
cui culmina il tessuto contrappuntistico della
Sonata. Si tratta, secondo una tendenza tipica
dell’800, di una fuga che subisce fortemente
l’influsso della forma sonata, sia per gli
sviluppi armonici, esclusi dalla forma classica,
bachiana, della fuga, sia per il maggior spazio
che acquistano materiali tematici e motivici
estranei allo schema
soggetto-risposta-contrasoggetto. Tutto questo
complesso mondo sonoro è stato evocato da De
Consoli con limpidezza nel disegno formale
dell’architettura del movimento, riscuotendo un
notevole successo di pubblico, che gli ha
tributato un lungo applauso. La seconda parte
del concerto ha invece proposto un Trio di Carl
Maria von Weber, quello in Sol min. op. 63, per
pianoforte, flauto e violoncello. Al pianoforte
sedeva Sofia Ripoldi, al flauto Martina Soffiati,
al violoncello Eleonora Sassone, tutte, anche
loro, apprezzate allieve del Cantelli. Questo
Trio op.63 (1819) di von Weber è un delizioso
cammeo zampillante di melodie ispirate da grazia
e da garbata eleganza, con qualche sentore
schubertiano qua e là: il sol minore di Weber è
certo altra cosa dal sol minore mozartiano. Le
tre giovani esecutrici, molto precise e sicure
nelle entrate e nel vario intreccio dei
rispettivi strumenti, sono state decisamente
brave nella resa dei suggestivi impasti timbrici
della composizione, che raggiungono il risultato
più alto nel Finale Allegro, di impagabile
felicità melodica. Bravi tutti e tre, ma un
plauso particolare va rivolto a Martina Soffiati,
davvero eccellente nelle parti in assolo che le
toccano nella sezione centrale dello Scherzo,
con un tema tra i più luminosi dell’intero pezzo,
e nel successivo Andante espressivo, lo Shlafer
Klage, il lamento del pastore, un’aria bucolica
di stampo francese, eseguita da Soffiati con
finezza ed eleganza perfette. Un piacevolissimo
concerto, che ha strappato prolungati applausi
al pubblico di fedeli frequentatori dei Sabati
del Cantelli, non ripagati da alcun bis.
25-11-23
Bruno Busca
Arthur & Lucas Jussen in
Auditorium per il concerto di Roukens
L'ottima serata musicale dell'Auditorium con
l'Orchestra Sinfonica di Milano ha visto
protagonisti una coppia di pianisti di fama
internazionale quali Arthur & Lucas Jussen per
un concerto in prima esecuzione italiana di Joey
Roukens denominato In Unison: Concerto per
due pianoforti e orchestra. Alla direzione
orchestrale Martijn Dendievel si è impegnato
successivamente anche nella Sinfonia n.4 in
fa minore op.36 di
Čajkovskij. L'olandese Roukens
 ha composto il
concerto nel 2017 dedicandolo ai due fratelli
che lo eseguirono l'anno successivo.
È un brano in tre parti
che rivela influenze variegate da ricercarsi nel
mondo musicale classico, contemporaneo e anche
pop. L'impatto volumetrico iniziale di forte
resa, con i due pianoforti spesso all'unisono
contrapposti alle timbriche coinvolgenti
dell'orchestra, ha rivelato sonorità che
ricordano certa musica da film statunitense, pur
esprimendo il lavoro una qualità costruttiva ed
espressiva rilevante, giocata non solo sul
virtuosismo dei due pianisti ma anche sulle
timbriche spesso percussive dell'orchestra e sui
continui cambiamenti ritmici e di tempo.
Particolarmente significativo ha composto il
concerto nel 2017 dedicandolo ai due fratelli
che lo eseguirono l'anno successivo.
È un brano in tre parti
che rivela influenze variegate da ricercarsi nel
mondo musicale classico, contemporaneo e anche
pop. L'impatto volumetrico iniziale di forte
resa, con i due pianoforti spesso all'unisono
contrapposti alle timbriche coinvolgenti
dell'orchestra, ha rivelato sonorità che
ricordano certa musica da film statunitense, pur
esprimendo il lavoro una qualità costruttiva ed
espressiva rilevante, giocata non solo sul
virtuosismo dei due pianisti ma anche sulle
timbriche spesso percussive dell'orchestra e sui
continui cambiamenti ritmici e di tempo.
Particolarmente significativo il riflessivo
movimento centrale costruito su un gioco di
risonanze ottenute con poche note sovrapposte
dei pianoforti. Un brano nel complesso di grande
effetto, molto coinvolgente, che è piaciuto al
numeroso pubblico presente in Auditorium. Valido
il bis solistico concesso da Arthur & Lucas
Jussen con un Bach trascritto per pianoforte a
quattro mani, precisamente Schafe können
sicher weiden BWV 208. Ancora fragorosi
applausi al termine del riuscito brano . Dopo il
breve intervallo, valida l'esecuzione della
Sinfonia n.4 op.36 di
Čajkovskij mediata dall'ottima direzione di
Martijn Dendievel e con una resa rilevante
d'insieme e di ogni sezione orchestrale.
Domenica alle 16.00 ci sarà
la replica. Da non
perdere. il riflessivo
movimento centrale costruito su un gioco di
risonanze ottenute con poche note sovrapposte
dei pianoforti. Un brano nel complesso di grande
effetto, molto coinvolgente, che è piaciuto al
numeroso pubblico presente in Auditorium. Valido
il bis solistico concesso da Arthur & Lucas
Jussen con un Bach trascritto per pianoforte a
quattro mani, precisamente Schafe können
sicher weiden BWV 208. Ancora fragorosi
applausi al termine del riuscito brano . Dopo il
breve intervallo, valida l'esecuzione della
Sinfonia n.4 op.36 di
Čajkovskij mediata dall'ottima direzione di
Martijn Dendievel e con una resa rilevante
d'insieme e di ogni sezione orchestrale.
Domenica alle 16.00 ci sarà
la replica. Da non
perdere.
25 novembre 2023 Cesare
Guzzardella
Ultime repliche per Onegin
al Teatro alla Scala
Penultima replica quella vista ieri sera al
Teatro alla Scala di Onegin, balletto in tre
atti ispirato al poema di Aleksandr Puškin
su musica di
 Cajkovskij
per la coreografia di John Cranko. L'avvincente
coreografia di Cranko
è presente alla Scala dal
1993 e da allora per molti cicli di
rappresentazioni ha ottenuto sempre un meritato
successo per la classicità della messinscena -
costruita sulle scene di Pierluigi Samaritani e
con i costumi di Samaritani e Roberta Guidi Di
Bagno - che trova sempre una rinnovata
freschezza di stile. Tra i protagonisti
dell'ottava rappresentazione, tutti bravi,
segnaliamo: Gabriele Corrado, Onegin,
Mattia Semperboni, Lenskij, Francesca
Podini, la Vedova Larina, Alice Mariani,
Tat'jana, Alessandra Vassallo, Ol'ga
Edoardo Capolaretti, Il Principe Gremin,
Serena Sarnataro, La nutrice.
Interessante ricordare che le musiche di scena
di
Čajkovskij sono rialaborazioni orchestrali di
Kurt-Heinz Stolze, collaboratore di Cranko
tratte soprattutto da brani pianistici
del grande russo come le Stagioni, ma
anche su poemi sinfonici quali Francesca da
Rimini e Romeo e Giulietta oltre che
dall’opera Cajkovskij
per la coreografia di John Cranko. L'avvincente
coreografia di Cranko
è presente alla Scala dal
1993 e da allora per molti cicli di
rappresentazioni ha ottenuto sempre un meritato
successo per la classicità della messinscena -
costruita sulle scene di Pierluigi Samaritani e
con i costumi di Samaritani e Roberta Guidi Di
Bagno - che trova sempre una rinnovata
freschezza di stile. Tra i protagonisti
dell'ottava rappresentazione, tutti bravi,
segnaliamo: Gabriele Corrado, Onegin,
Mattia Semperboni, Lenskij, Francesca
Podini, la Vedova Larina, Alice Mariani,
Tat'jana, Alessandra Vassallo, Ol'ga
Edoardo Capolaretti, Il Principe Gremin,
Serena Sarnataro, La nutrice.
Interessante ricordare che le musiche di scena
di
Čajkovskij sono rialaborazioni orchestrali di
Kurt-Heinz Stolze, collaboratore di Cranko
tratte soprattutto da brani pianistici
del grande russo come le Stagioni, ma
anche su poemi sinfonici quali Francesca da
Rimini e Romeo e Giulietta oltre che
dall’opera
 I
capricci di Oksana
o Vakula il fabbro.
La sintonia tra danza e musica risulta sempre
perfetta e i momenti topici sono rappresentati
dalle
musiche più
celebri. Di ottima
qualità la direzione orchestrale di Simon Hewett
alla guida dell'Orchestra del Teatro alla Scala.
Ultima rappresentazione per il 25 novembre. Lo
spettacolo risulta già tutto esaurito. ( Foto di
Brescia e Amisano dall'Archivio Scala) I
capricci di Oksana
o Vakula il fabbro.
La sintonia tra danza e musica risulta sempre
perfetta e i momenti topici sono rappresentati
dalle
musiche più
celebri. Di ottima
qualità la direzione orchestrale di Simon Hewett
alla guida dell'Orchestra del Teatro alla Scala.
Ultima rappresentazione per il 25 novembre. Lo
spettacolo risulta già tutto esaurito. ( Foto di
Brescia e Amisano dall'Archivio Scala)
23-11-2023 Cesare Guzzardella
Alessandro Bonato
e Federico Colli ai
Pomeriggi del Dal Verme
Di
ottima qualità l'anteprima del concerto
sinfonico ascoltata questa mattina al Teatro Dal
Verme con I Pomeriggi Musicali diretti da
Alessandro Bonato. In programma brani di
Rossini,
Šostakovič e Mozart. Una
scelta classica con lavori molto differenti che
hanno messo certamente in risalto le qualità
del giovane direttore d'orchestra. Dopo il brano
introduttivo, con una trasparente ed equilibrata
Sinfonia dall'opera La Cenerentola
di Gioachino Rossini,
 è
entrato in palcoscenico il pianista bresciano
Federico Colli che insieme al trombettista
Sergio Casesi, ha sostenuto l'importante parte
pianistica del Concerto per pianoforte,
tromba ed archi in do minore op.35 di Dmitri
Šostakovič, non disgiunta dai fondamentali e
pregnanti interventi solistici di Casesi. Le
ottime sinergie dei due solisti con la direzione
di Bonato e gli ottimi è
entrato in palcoscenico il pianista bresciano
Federico Colli che insieme al trombettista
Sergio Casesi, ha sostenuto l'importante parte
pianistica del Concerto per pianoforte,
tromba ed archi in do minore op.35 di Dmitri
Šostakovič, non disgiunta dai fondamentali e
pregnanti interventi solistici di Casesi. Le
ottime sinergie dei due solisti con la direzione
di Bonato e gli ottimi
 I
Pomeriggi, hanno permesso una resa
espressiva complessiva di alto livello estetico.
La minuziosa e dettagliata resa del pianoforte
di Colli, ha rilevato una cura timbrica precisa
per un lavoro molto contrastato sia
melodicamente che ritmicamente, ma risolto con
efficace e luminosa
discorsività e
resa sonora
dall'interprete. Efficaci anche le inserzioni
melodiche della tromba di Sergio Casesi nel
contesto orchestrale altrettanto curato e anche
nel dialogo con il pianoforte di Colli. Applausi
calorosi al termine. Valida poi
l'interpretazione della celebre Sinfonia n.41
in do maggiore K.551 "Jupiter" , sostenuta
con accurato equilibrio delle sezioni
orchestrali e con una ottima resa nel celebre
Molto allegro finale, apoteosi
contrappuntistica nella vasta produzione
sinfonica mozartiana. Questa sera alle 20.00 il
concerto ufficiale e Sabato alle 17.00 la
replica. Da non perdere. I
Pomeriggi, hanno permesso una resa
espressiva complessiva di alto livello estetico.
La minuziosa e dettagliata resa del pianoforte
di Colli, ha rilevato una cura timbrica precisa
per un lavoro molto contrastato sia
melodicamente che ritmicamente, ma risolto con
efficace e luminosa
discorsività e
resa sonora
dall'interprete. Efficaci anche le inserzioni
melodiche della tromba di Sergio Casesi nel
contesto orchestrale altrettanto curato e anche
nel dialogo con il pianoforte di Colli. Applausi
calorosi al termine. Valida poi
l'interpretazione della celebre Sinfonia n.41
in do maggiore K.551 "Jupiter" , sostenuta
con accurato equilibrio delle sezioni
orchestrali e con una ottima resa nel celebre
Molto allegro finale, apoteosi
contrappuntistica nella vasta produzione
sinfonica mozartiana. Questa sera alle 20.00 il
concerto ufficiale e Sabato alle 17.00 la
replica. Da non perdere.
23
novembre 2023
Cesare Guzzardella
Il
pianoforte di
Viacheslav Shelepov all'Accademia
di Musica Antica di Milano
Di qualità il concerto
ascoltato ieri sera, nella bellissima Sala del
Cenacolo del Museo "Leonardo da Vinci", in una
serata avente come protagonista il pianista
russo Viacheslav Shelepov , con
 indiscusse
qualità d'interpretazione e con una scelta d'
impaginato che oltre al barocco italiano di
Cimorosa e Scarlatti inseriva, all'inizio e alla
fine del concerto, due ampie sonate di un'altro
italiano molto importante per l'evoluzione della
scuola tastieristica quale Muzio Clementi. Nelle
opere dei citati compositori, la prevalenza
musicale era quella legata a timbriche dal
sapore antico, in linea con la serie di concerti
organizzati dall'Accademia di Musica Antica di
Milano. Una scelta che ha cercato di esprimere
un percorso adatto al luogo e certamente
rappresentativo dei modi interpretativi del
trentaduenne pianista, nato a Barnaul in Russia
nel 1991 e allievo anche di Alexei Lubimov
importante interprete e didatta. Abituato
all'uso dei pianoforti storici, con i quali ha
vinto prestigiosi concorsi internazionali, qui
si è trovato invece con uno strumento recente di
ottima qualità, il classico Steinway & Sons.
Clementi, Cimarosa e Scarlatti si sono alternati
in un'ambiente particolare, dove la ridondanza
acustica della sala favoriva le sonorità più "semplici",
definite da linee melodiche non coperte da più
complesse armonie, conferendole quel senso "antico"
particolarmente godibile. Le armonizzazioni più
complesse di indiscusse
qualità d'interpretazione e con una scelta d'
impaginato che oltre al barocco italiano di
Cimorosa e Scarlatti inseriva, all'inizio e alla
fine del concerto, due ampie sonate di un'altro
italiano molto importante per l'evoluzione della
scuola tastieristica quale Muzio Clementi. Nelle
opere dei citati compositori, la prevalenza
musicale era quella legata a timbriche dal
sapore antico, in linea con la serie di concerti
organizzati dall'Accademia di Musica Antica di
Milano. Una scelta che ha cercato di esprimere
un percorso adatto al luogo e certamente
rappresentativo dei modi interpretativi del
trentaduenne pianista, nato a Barnaul in Russia
nel 1991 e allievo anche di Alexei Lubimov
importante interprete e didatta. Abituato
all'uso dei pianoforti storici, con i quali ha
vinto prestigiosi concorsi internazionali, qui
si è trovato invece con uno strumento recente di
ottima qualità, il classico Steinway & Sons.
Clementi, Cimarosa e Scarlatti si sono alternati
in un'ambiente particolare, dove la ridondanza
acustica della sala favoriva le sonorità più "semplici",
definite da linee melodiche non coperte da più
complesse armonie, conferendole quel senso "antico"
particolarmente godibile. Le armonizzazioni più
complesse di
 Clementi
probabilmente meritavano un ambiente meno
riverberante. Estrapolando le situazioni
acustiche migliori per il pianoforte, abbiamo
comunque assistito ad un eccellente concerto
iniziato con Muzio Clementi e la sua Sonata
in fa minore op.13 n.6, proseguento con tre
Sonate di Domenico Cimarosa ( in Sol min., La
min. e Si bem.maggiore) alternate a quelle
di Domenico Scarlatti (K 35, K 147, K 77)
e terminando con l' evoluta Sonata in Sol
minore op.34 n.2 di Clementi, lavoro questo
- ma anche la prima - non minore per qualità
della produzione sonatistica beethoveniana.
Ottimo il pianismo di Shelepov, giocato su una
sintesi discorsiva ottenuta da una totale
interiorizzazione di ogni elemento musicale, con
contrasti volumetrici e dinamici adeguati e
approfondita esternazione nei momenti più
riflessivi, unita ad una cura dei dettagli non
comune. Di valore le due più corpose e
contrastate sonate di Clementi, autentici
capolavori che andrebbero eseguiti spesso nelle
sale da concerto. Applausi sostenuti e come bis
un'ottima interpretazione di un brano del russo
Michail Ivanovi Clementi
probabilmente meritavano un ambiente meno
riverberante. Estrapolando le situazioni
acustiche migliori per il pianoforte, abbiamo
comunque assistito ad un eccellente concerto
iniziato con Muzio Clementi e la sua Sonata
in fa minore op.13 n.6, proseguento con tre
Sonate di Domenico Cimarosa ( in Sol min., La
min. e Si bem.maggiore) alternate a quelle
di Domenico Scarlatti (K 35, K 147, K 77)
e terminando con l' evoluta Sonata in Sol
minore op.34 n.2 di Clementi, lavoro questo
- ma anche la prima - non minore per qualità
della produzione sonatistica beethoveniana.
Ottimo il pianismo di Shelepov, giocato su una
sintesi discorsiva ottenuta da una totale
interiorizzazione di ogni elemento musicale, con
contrasti volumetrici e dinamici adeguati e
approfondita esternazione nei momenti più
riflessivi, unita ad una cura dei dettagli non
comune. Di valore le due più corpose e
contrastate sonate di Clementi, autentici
capolavori che andrebbero eseguiti spesso nelle
sale da concerto. Applausi sostenuti e come bis
un'ottima interpretazione di un brano del russo
Michail Ivanovi č
Glinka.
23-11-2023
Cesare Guzzardella
Successo per gli "Artisti
in Residenza" della Società Dei Concerti
milanese
Grande successo per il
progetto Artisti in Residenza all'estero
promosso dalla Fondazione La Società dei
Concerti, che prosegue il proprio impegno a
sostegno delle nuove generazioni di musicisti.
Dopo i concerti in Germania, Islanda, Marocco, è
stata l'Arabia Saudita a ospitare per quattro
concerti tra Gedda (11 e 12 novembre) e Riad (14
e 15 novembre) gli Artisti in Residenza e in
particolare i giovanissimi componenti del
Quartetto Goldberg. Il tour è
 stato
possibile grazie all' accordo con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale e al lavoro congiunto con
l'Ambasciata d'Italia a Riad e il Consolato
Generale d'Italia a Gedda. A dare ancor più
valore ai concerti del quartetto Goldberg è
stata la partecipazione alla European Music Week
che ha riunito musicisti e ensemble europei
durante una settimana di grande musica nel
prestigioso contesto del Saudi Music Hub a Riad.
La European Music Week, organizzata dalla
Delegazione dell'Unione Europea in
collaborazione con le Ambasciate europee in
Arabia Saudita è novità assolta e fin con la sua
prima edizione, vuole introdurre e diffondere la
ricchezza musicale europea al pubblico Saudita,
ponendo le basi per collaborazioni culturali
future tra Europa e Riad.Applauditissimi i
musicisti del Goldberg, richiamati più volte sul
palco dal numeroso pubblico presente e che hanno
eseguito, tra l'altro, brani di importanti
autori italiani da Boccherini a Verdi. La
trasferta in Arabia Saudita è solo uno dei tanti
momenti artistici che i ragazzi si trovano ad
affrontare in questo percorso: ogni lunedì al
Teatro Rosetum di Milano ospita a turno le
esibizioni di questi giovani e promettenti
talenti che si esercitano al contatto con il
pubblico. Un grande successo anche per la
Fondazione La società dei concerti che da oltre
40 anni lavora per la promozione e visibilità
dei giovani talenti italiani. Una missione che
ormai è il carattere fondamentale
dell’organizzazione guidata con grandissimo
impegno da Enrica Ciccarelli Mormone. (
Dall'Ufficio
Stampa Società dei Concerti ) stato
possibile grazie all' accordo con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale e al lavoro congiunto con
l'Ambasciata d'Italia a Riad e il Consolato
Generale d'Italia a Gedda. A dare ancor più
valore ai concerti del quartetto Goldberg è
stata la partecipazione alla European Music Week
che ha riunito musicisti e ensemble europei
durante una settimana di grande musica nel
prestigioso contesto del Saudi Music Hub a Riad.
La European Music Week, organizzata dalla
Delegazione dell'Unione Europea in
collaborazione con le Ambasciate europee in
Arabia Saudita è novità assolta e fin con la sua
prima edizione, vuole introdurre e diffondere la
ricchezza musicale europea al pubblico Saudita,
ponendo le basi per collaborazioni culturali
future tra Europa e Riad.Applauditissimi i
musicisti del Goldberg, richiamati più volte sul
palco dal numeroso pubblico presente e che hanno
eseguito, tra l'altro, brani di importanti
autori italiani da Boccherini a Verdi. La
trasferta in Arabia Saudita è solo uno dei tanti
momenti artistici che i ragazzi si trovano ad
affrontare in questo percorso: ogni lunedì al
Teatro Rosetum di Milano ospita a turno le
esibizioni di questi giovani e promettenti
talenti che si esercitano al contatto con il
pubblico. Un grande successo anche per la
Fondazione La società dei concerti che da oltre
40 anni lavora per la promozione e visibilità
dei giovani talenti italiani. Una missione che
ormai è il carattere fondamentale
dell’organizzazione guidata con grandissimo
impegno da Enrica Ciccarelli Mormone. (
Dall'Ufficio
Stampa Società dei Concerti )
22 novembre 2023 dalla
redazione
|

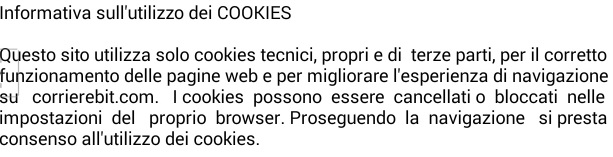

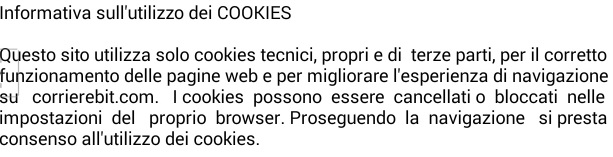

 più
contenuta per il concerto violoncellistico, che
data 1783, e una compagine sinfonica ampia per
la penultima sinfonia del compositore russo,
composta nel 1888 e indicativa dello sviluppo
creativo dell'autore portato ai suoi vertici
espressivi. Lo straordinario concerto di Haydn,
nei classici tre movimenti, è stato sostenuto
con evidente chiarezza timbrica da Moreau. Il
suo violoncello, sempre in risalto con
un'intonazione voluminosa ed elegante, era
sottolineato dalle discrete timbriche
orchestrali organizzate ottimamente da Blacher
per esaltare la profonda voce dello strumento ad
arco. Moreau, attento ad ogni particolare del
brano, ha anche sottolineato con chiarezza
espressiva la lunga cadenza solistica dell'Allegro
moderato iniziale. L'eccellente intesa
d'insieme ha delineato un'interpretazione
complessiva di alta qualità, molto apprezzata
dal numeroso pubblico presente in Auditorium.
Applausi fragorosi al protagonista e di profonda
resa il bis bachiano solistico concesso dal
cellista.
più
contenuta per il concerto violoncellistico, che
data 1783, e una compagine sinfonica ampia per
la penultima sinfonia del compositore russo,
composta nel 1888 e indicativa dello sviluppo
creativo dell'autore portato ai suoi vertici
espressivi. Lo straordinario concerto di Haydn,
nei classici tre movimenti, è stato sostenuto
con evidente chiarezza timbrica da Moreau. Il
suo violoncello, sempre in risalto con
un'intonazione voluminosa ed elegante, era
sottolineato dalle discrete timbriche
orchestrali organizzate ottimamente da Blacher
per esaltare la profonda voce dello strumento ad
arco. Moreau, attento ad ogni particolare del
brano, ha anche sottolineato con chiarezza
espressiva la lunga cadenza solistica dell'Allegro
moderato iniziale. L'eccellente intesa
d'insieme ha delineato un'interpretazione
complessiva di alta qualità, molto apprezzata
dal numeroso pubblico presente in Auditorium.
Applausi fragorosi al protagonista e di profonda
resa il bis bachiano solistico concesso dal
cellista.
 Dopo
l'intervallo, la celebre Quinta Sinfonia
di
Čaikovskij ha trovato una riuscita
interpretazione dell'Orchestra Sinfonica di
Milano, sempre molto disponibile e preparata con
i compositori russi. Il direttore Blacher ha
rivelato estrema sintonia con la musica di
Čaikovskij, attraverso una scelta eccellente
nelle andature che danno equilibrio ai quattro
movimenti del corposo brano. Ottime le timbriche
elargite con espressività
da ogni sezione
orchestrale, e ben rilevati l'impasto dei colori
nei riconoscibili piani sonori che trovano la
massima elargizione nell'originale Finale.
Andante maestoso, ultimo movimento del brano.
Interpretazione complessiva di evidente qualità.
Applausi sostenuti e di lunga durata a Blacher e
ai bravissimi orchestrali. Domenica alle ore
16.00 la replica. Da non perdere.
Dopo
l'intervallo, la celebre Quinta Sinfonia
di
Čaikovskij ha trovato una riuscita
interpretazione dell'Orchestra Sinfonica di
Milano, sempre molto disponibile e preparata con
i compositori russi. Il direttore Blacher ha
rivelato estrema sintonia con la musica di
Čaikovskij, attraverso una scelta eccellente
nelle andature che danno equilibrio ai quattro
movimenti del corposo brano. Ottime le timbriche
elargite con espressività
da ogni sezione
orchestrale, e ben rilevati l'impasto dei colori
nei riconoscibili piani sonori che trovano la
massima elargizione nell'originale Finale.
Andante maestoso, ultimo movimento del brano.
Interpretazione complessiva di evidente qualità.
Applausi sostenuti e di lunga durata a Blacher e
ai bravissimi orchestrali. Domenica alle ore
16.00 la replica. Da non perdere.
 coloristica
più raffinata e con una modalità interpretativa
molto "polacca". La presenza di molte "variazioni"
ha caratterizzato gran parte della serata.
Prima le rarissime Variazioni su "Come un
agnello" K 460 attribuite a Mozart, ma con
il tema iniziale di Giuseppe Sarti (1729-1802),
eseguite dal pianista macedone con una calibrata
ricerca delle timbriche nelle numerose
possibilità dinamiche. Poi la virtuosistica
Suite da "Lo Schiaccianoci" di
Čaikovskij nella splendida
trascrizione di Pletnev, approciata con notevole
sicurezza. I temi dei sette movimenti estratti
dal celebre balletto del grande russo subiscono
continue variazioni, ben rilevate
dall'interprete nei differenti piani sonori.
Ottime le
coloristica
più raffinata e con una modalità interpretativa
molto "polacca". La presenza di molte "variazioni"
ha caratterizzato gran parte della serata.
Prima le rarissime Variazioni su "Come un
agnello" K 460 attribuite a Mozart, ma con
il tema iniziale di Giuseppe Sarti (1729-1802),
eseguite dal pianista macedone con una calibrata
ricerca delle timbriche nelle numerose
possibilità dinamiche. Poi la virtuosistica
Suite da "Lo Schiaccianoci" di
Čaikovskij nella splendida
trascrizione di Pletnev, approciata con notevole
sicurezza. I temi dei sette movimenti estratti
dal celebre balletto del grande russo subiscono
continue variazioni, ben rilevate
dall'interprete nei differenti piani sonori.
Ottime le
 variazioni
di Beethoven: prima le rarissime Variazioni
su una Danza Russa WoO 71 su un tema
Allegretto e poi le celebri 32 Variazioni
su un Tema originale in do minore WoO 80.
Quest'ultime di grande resa espressiva nella
corretta e precisa scelta dei tempi e negli
eccellenti contrasti. L'ultimo brano in
programma, la Sonata n.7 in si bem. maggiore
op.83 di Sergej Prokof'ev
è nota
soprattutto per il terzo e ultimo movimento, un
sorprendente Precipitato eseguito con
virtuosismo eccelso da Trpčeski
nell'esternazione dei contrastati elementi
ritmici
percussivi.
Applausi calorosissimi pienamente meritati e
quattro brevi bis concessi dal pianista
visibilmente soddisfatto: prima un breve ritmico
brano folcloristico macedone, poi una
trascrizione pianistica dello Scherzo per 4
fagotti di Prokof'ev, poi l' Humoresque
del russo
Rodion Shchedrin
(1932)
e,
a conclusione,
un recente brano particolarmente melodico di un
compositore croato in stile jazz molto americano.
Ottima serata.
variazioni
di Beethoven: prima le rarissime Variazioni
su una Danza Russa WoO 71 su un tema
Allegretto e poi le celebri 32 Variazioni
su un Tema originale in do minore WoO 80.
Quest'ultime di grande resa espressiva nella
corretta e precisa scelta dei tempi e negli
eccellenti contrasti. L'ultimo brano in
programma, la Sonata n.7 in si bem. maggiore
op.83 di Sergej Prokof'ev
è nota
soprattutto per il terzo e ultimo movimento, un
sorprendente Precipitato eseguito con
virtuosismo eccelso da Trpčeski
nell'esternazione dei contrastati elementi
ritmici
percussivi.
Applausi calorosissimi pienamente meritati e
quattro brevi bis concessi dal pianista
visibilmente soddisfatto: prima un breve ritmico
brano folcloristico macedone, poi una
trascrizione pianistica dello Scherzo per 4
fagotti di Prokof'ev, poi l' Humoresque
del russo
Rodion Shchedrin
(1932)
e,
a conclusione,
un recente brano particolarmente melodico di un
compositore croato in stile jazz molto americano.
Ottima serata.
 del
Novecento e contemporanea. L'alternanza tra i
registri alti della limpida voce di Serena Sáenz,
sia nel canto che nella lettura del testo di
Nono tratto dal poema di Julio Huasi Luciano, e
l'incisiva componente percussiva dove anche il
pianoforte, suonato in modo impeccabile da
Aimard soprattutto nei registri gravi in modo da
fondersi con i roboanti effetti delle
percussioni, ha ricreato quell'atmosfera magica
e rivoluzionaria di quel particolare periodo
storico del quale Nono fu tra i più autorevoli
rappresentanti. Splendida esecuzione. Dopo il
breve intervallo, un'esemplare interpretazione
della Quarta Sinfonia di
Šostakovič in Do minore op.43 (1937) ha
rivelato il personalissimo linguaggio del
compositore russo. Il lungo brano in quattro
movimenti - Allegretto poco moderato,
Moderato con moto, Largo e Allegretto -
ricco di contrasti, cambiamenti di tempo,
momenti raccolti e altri di fragorose
esternazioni timbriche,
è stato espresso con
maestria dalla Filarmonica della Scala e dalla
dettagliata direzione di Metzmacher. Successo
inevitabile.
del
Novecento e contemporanea. L'alternanza tra i
registri alti della limpida voce di Serena Sáenz,
sia nel canto che nella lettura del testo di
Nono tratto dal poema di Julio Huasi Luciano, e
l'incisiva componente percussiva dove anche il
pianoforte, suonato in modo impeccabile da
Aimard soprattutto nei registri gravi in modo da
fondersi con i roboanti effetti delle
percussioni, ha ricreato quell'atmosfera magica
e rivoluzionaria di quel particolare periodo
storico del quale Nono fu tra i più autorevoli
rappresentanti. Splendida esecuzione. Dopo il
breve intervallo, un'esemplare interpretazione
della Quarta Sinfonia di
Šostakovič in Do minore op.43 (1937) ha
rivelato il personalissimo linguaggio del
compositore russo. Il lungo brano in quattro
movimenti - Allegretto poco moderato,
Moderato con moto, Largo e Allegretto -
ricco di contrasti, cambiamenti di tempo,
momenti raccolti e altri di fragorose
esternazioni timbriche,
è stato espresso con
maestria dalla Filarmonica della Scala e dalla
dettagliata direzione di Metzmacher. Successo
inevitabile.
 "CANTI
DI PACE IN TEMPI DI GUERRA" aveva come polo
centrale la Missa Brevis di
Benjamin Britten, brano liturgico adattato per
l'occasione agli spazi luminosi della
panoramica Sala Fontana.
Non solo Britten però, anche una serie di brani
cameristici di György Kurtág, di Andrea Grossi,
di Shervin Hajipour, di Maurice Ravel, di Richie
Beirach, di Gilberto Mendes e un Canto
Tradizionale Índios Kanamari del Brasile. Tutti
i brani sono stati eseguiti all'interno di un
percorso preciso ottimamente costruito che ha
visto alternarsi lavori cameristici a brani
corali. L'eccellente interpretazione della
Missa Brevis
"CANTI
DI PACE IN TEMPI DI GUERRA" aveva come polo
centrale la Missa Brevis di
Benjamin Britten, brano liturgico adattato per
l'occasione agli spazi luminosi della
panoramica Sala Fontana.
Non solo Britten però, anche una serie di brani
cameristici di György Kurtág, di Andrea Grossi,
di Shervin Hajipour, di Maurice Ravel, di Richie
Beirach, di Gilberto Mendes e un Canto
Tradizionale Índios Kanamari del Brasile. Tutti
i brani sono stati eseguiti all'interno di un
percorso preciso ottimamente costruito che ha
visto alternarsi lavori cameristici a brani
corali. L'eccellente interpretazione della
Missa Brevis dell'inglese Benjamin Britten trascritta per
voci, coro, pianoforte e contrabbasso
dall'originale per voci, coro e organo, è stata
diretta molto bene da Tais Conte Renzetti con la
precisa esternazione del Coro Didone, la
partecipazione del baritono Davide Rocca, voce
pregnante ed incisiva, e le armonizzazioni della
pianista Gledis Zjusi e del contrabbassista
Andrea Grossi. Tra gli altri brani segnaliamo
almeno l'espressivo brano Baraje di
Shervin Hajipour con l'intensa voce del
contralto Giulia Taccagni sostenuta dal
contrabbasso di Andrea Grossi. Di rilievo
Wahanararai, canto tradizionale Indios
Kanamari del Brasile inserito benissimo in un
contesto ambientale con suoni di uccelli ed
dell'inglese Benjamin Britten trascritta per
voci, coro, pianoforte e contrabbasso
dall'originale per voci, coro e organo, è stata
diretta molto bene da Tais Conte Renzetti con la
precisa esternazione del Coro Didone, la
partecipazione del baritono Davide Rocca, voce
pregnante ed incisiva, e le armonizzazioni della
pianista Gledis Zjusi e del contrabbassista
Andrea Grossi. Tra gli altri brani segnaliamo
almeno l'espressivo brano Baraje di
Shervin Hajipour con l'intensa voce del
contralto Giulia Taccagni sostenuta dal
contrabbasso di Andrea Grossi. Di rilievo
Wahanararai, canto tradizionale Indios
Kanamari del Brasile inserito benissimo in un
contesto ambientale con suoni di uccelli ed
 effetti
naturali; d'intensa incisività Kaddish di
Maurice Ravel con la voce baritonale di Rocca e
con la Zjusi al pianoforte; particolarmente
espressivo il brano jazz Elm di Richie
Beirach nella versione per pianoforte e
contrabbasso con la Zjusi e Grossi. Di
ispirazione anche gestuale l'iniziale brano per
pianoforte a quattro mano di Andrea Grossi,
valido nella sua semplicità. Un pomeriggio di
qualità introdotto da Paola Bonara del Coro
Polifonico Cantosospeso e terminato con la
reinterpretazione del bellissimo Vila Socó
Meu Amor di Gilberto Mendes. Successo e
fragorosi applausi nella Sala Fontana colma di
pubblico.
effetti
naturali; d'intensa incisività Kaddish di
Maurice Ravel con la voce baritonale di Rocca e
con la Zjusi al pianoforte; particolarmente
espressivo il brano jazz Elm di Richie
Beirach nella versione per pianoforte e
contrabbasso con la Zjusi e Grossi. Di
ispirazione anche gestuale l'iniziale brano per
pianoforte a quattro mano di Andrea Grossi,
valido nella sua semplicità. Un pomeriggio di
qualità introdotto da Paola Bonara del Coro
Polifonico Cantosospeso e terminato con la
reinterpretazione del bellissimo Vila Socó
Meu Amor di Gilberto Mendes. Successo e
fragorosi applausi nella Sala Fontana colma di
pubblico.
 con
una limpidezza strutturale assai rara nella sua
sintesi discorsiva ben delineata. La giovane
interprete ha trovato poi, nell'altrettanto
stupendo Quintetto per pianoforte e archi in
mi bem. maggiore op. 44, il quartetto
d'archi Goldberg come compagni. Un gruppo
cameristico certamente di alta qualità, in
perfetta sinergia con la parte pianistica.
L'ottimo equilibrio tra i violini di Jingzhi
Zhang e Giacomo Lucato, la viola di Matilde
Simionato e il violoncello di Martino Simionato,
con le valide armonizzazioni della pianista, ha
portato ad una resa estetica equilibrata tra le
parti e soprattutto di grande espressività in
ogni movimento. Applausi calorosissimi agli
interpreti dal numeroso pubblico intervenuto in
Sala Verdi. Il concerto della sera ha
rappresentato una doppia novità: poco conosciuti
erano gli eccellenti interpreti e altrettanto
poco conosciuti molti dei compositori inseriti
nel diversificato e originale impaginato. La
componente "americana" ascoltata, con influenze
di spirituals e blues, l'abbiamo ritrovata in
ben quattro compositori.
con
una limpidezza strutturale assai rara nella sua
sintesi discorsiva ben delineata. La giovane
interprete ha trovato poi, nell'altrettanto
stupendo Quintetto per pianoforte e archi in
mi bem. maggiore op. 44, il quartetto
d'archi Goldberg come compagni. Un gruppo
cameristico certamente di alta qualità, in
perfetta sinergia con la parte pianistica.
L'ottimo equilibrio tra i violini di Jingzhi
Zhang e Giacomo Lucato, la viola di Matilde
Simionato e il violoncello di Martino Simionato,
con le valide armonizzazioni della pianista, ha
portato ad una resa estetica equilibrata tra le
parti e soprattutto di grande espressività in
ogni movimento. Applausi calorosissimi agli
interpreti dal numeroso pubblico intervenuto in
Sala Verdi. Il concerto della sera ha
rappresentato una doppia novità: poco conosciuti
erano gli eccellenti interpreti e altrettanto
poco conosciuti molti dei compositori inseriti
nel diversificato e originale impaginato. La
componente "americana" ascoltata, con influenze
di spirituals e blues, l'abbiamo ritrovata in
ben quattro compositori.
 L'inglese
Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) duranti i
suoi soggiorni negli Stati Uniti assimilò quel
mondo musicale producendo brani melodicissimi
come la bellissima Suite per violino e
pianoforte n.3; lo statunitense W.Grant
Still (1895-1978) con la sua Suite per
violino e pianoforte ha riportato il mondo
africano e le influenze jazz nel suo lavoro
costituito di tre parti: African dancer,
Mother and Child e Gamin; la
compositrice statunitense Florence Price
(1887-1853), di origine africana, nelle sue due
Fantasie per violino e pianoforte, la
n.1 in sol minore e la n.2 in fa diesis
minore, ha trovato un modo più complesso e
virtuosistico di esprimersi facendo una sintesi
originale tra idiomi romantici europei e ritmi
indo-americani; il ceco Antonin Dvořák
è debitore della musica statunitense per via
della sua lunga permanenza oltre oceano e per
certi colori di quel mondo ibrido tra Europa ed
L'inglese
Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) duranti i
suoi soggiorni negli Stati Uniti assimilò quel
mondo musicale producendo brani melodicissimi
come la bellissima Suite per violino e
pianoforte n.3; lo statunitense W.Grant
Still (1895-1978) con la sua Suite per
violino e pianoforte ha riportato il mondo
africano e le influenze jazz nel suo lavoro
costituito di tre parti: African dancer,
Mother and Child e Gamin; la
compositrice statunitense Florence Price
(1887-1853), di origine africana, nelle sue due
Fantasie per violino e pianoforte, la
n.1 in sol minore e la n.2 in fa diesis
minore, ha trovato un modo più complesso e
virtuosistico di esprimersi facendo una sintesi
originale tra idiomi romantici europei e ritmi
indo-americani; il ceco Antonin Dvořák
è debitore della musica statunitense per via
della sua lunga permanenza oltre oceano e per
certi colori di quel mondo ibrido tra Europa ed
 Africa
individuabili nella deliziosa Sonatina per
violino e pianoforte op.100. Gli eccellenti
interpreti Randoll Goosby e Zhu Wang hanno
rivelato una chiarezza espressiva di raro
ascolto in tutti i lavori, nei quali
l'equilibrio tra il melodicissimo violino con un
vibrato di pregio, e la luminosa parte
pianistica ha portato ad un' interpretazione
analitica, precisa in ogni dettaglio e molto
espressiva. Le escursioni dinamiche, con
volumetrie centellinate in minimi cambiamenti,
hanno rivelato poi la statura interpretativa del
duo. L'ultimo brano d'impaginato con la
Sonata in mi bemolle maggiore op.18 del
tedesco Richard Strauss (1864-1949) ci ha
portato in un clima tardo romantico ben diverso
con influssi wagneriani.
Africa
individuabili nella deliziosa Sonatina per
violino e pianoforte op.100. Gli eccellenti
interpreti Randoll Goosby e Zhu Wang hanno
rivelato una chiarezza espressiva di raro
ascolto in tutti i lavori, nei quali
l'equilibrio tra il melodicissimo violino con un
vibrato di pregio, e la luminosa parte
pianistica ha portato ad un' interpretazione
analitica, precisa in ogni dettaglio e molto
espressiva. Le escursioni dinamiche, con
volumetrie centellinate in minimi cambiamenti,
hanno rivelato poi la statura interpretativa del
duo. L'ultimo brano d'impaginato con la
Sonata in mi bemolle maggiore op.18 del
tedesco Richard Strauss (1864-1949) ci ha
portato in un clima tardo romantico ben diverso
con influssi wagneriani. Una sonata costruita benissimo dal grande
compositore, restituita con indubbia bravura dal
duo, con la parte pianistica dominante per
armonizzazione e virtuosismo. Bravissimi!
Pubblico entusiasta e calorosi applausi al
termine. Due i bis concessi: prima il melodico
Cantabile di Niccolò Paganini e poi
Estrellita del messicano Manuel Ponce nella
celebre trascrizione di Jascha Heifetz. Entrambi
ottimi. Ricordiamo il "Concerto per Antonio"
di sabato 20 gennaio alle ore 18.00 con il
grande pianista Evgeny Kissin che eseguirà
musiche di Beethoven, Chopin. Brahms e
Prokofiev. Da non perdere.
Una sonata costruita benissimo dal grande
compositore, restituita con indubbia bravura dal
duo, con la parte pianistica dominante per
armonizzazione e virtuosismo. Bravissimi!
Pubblico entusiasta e calorosi applausi al
termine. Due i bis concessi: prima il melodico
Cantabile di Niccolò Paganini e poi
Estrellita del messicano Manuel Ponce nella
celebre trascrizione di Jascha Heifetz. Entrambi
ottimi. Ricordiamo il "Concerto per Antonio"
di sabato 20 gennaio alle ore 18.00 con il
grande pianista Evgeny Kissin che eseguirà
musiche di Beethoven, Chopin. Brahms e
Prokofiev. Da non perdere.
 marcia, un celebre Valzer
dei fiori oltre all'Ouverture introduttiva. Brani
celebri che facilmente si ricordano al primo
ascolto. Altrettanto celebre L'oiseau de feu
del secondo russo; è del 1909, in diciannove
momenti perfettamente collegati per un unicum
discorsivo; ha trovato la prima esecuzione nel
1910 a Parigi. Lavoro già evoluto del primo
Novecento, rappresenta un momento di splendore
per Stravinskij per il superamento del
linguaggio del passato e l'inizio di una
personale forma espressiva. Segna poi la
fondamentale collaborazione del compositore con
l'impresario Sergej Diaghilev per i famosi
Balletti Russi. Axelrod, bacchetta molto
conosciuta dal pubblico per le numerose
collaborazioni con l'Orchestra Sinfonica di
Milano, risalenti anche al periodo de "LaVerdi",
ha mostrato di essere
marcia, un celebre Valzer
dei fiori oltre all'Ouverture introduttiva. Brani
celebri che facilmente si ricordano al primo
ascolto. Altrettanto celebre L'oiseau de feu
del secondo russo; è del 1909, in diciannove
momenti perfettamente collegati per un unicum
discorsivo; ha trovato la prima esecuzione nel
1910 a Parigi. Lavoro già evoluto del primo
Novecento, rappresenta un momento di splendore
per Stravinskij per il superamento del
linguaggio del passato e l'inizio di una
personale forma espressiva. Segna poi la
fondamentale collaborazione del compositore con
l'impresario Sergej Diaghilev per i famosi
Balletti Russi. Axelrod, bacchetta molto
conosciuta dal pubblico per le numerose
collaborazioni con l'Orchestra Sinfonica di
Milano, risalenti anche al periodo de "LaVerdi",
ha mostrato di essere
 tra i migliori direttori
di questa compagine orchestrale, una formazione
che conosce molto bene e con la quale trova una
sintonia speciale. Eccellenti prima i delicati e
trasparenti brani de Lo Schiaccianoci e
di ottima qualità
L'oiseau de feu,
ampio lavoro ricco di contrasti timbrici e
dinamici, in crescendo anche per la qualità
innovativa della musica. Un esempio di grande
orchestrazione che richiede una visione unitaria
perfettamente ritrovata da Axelrod. Un successo
annunciato con un riscontro nel volto del
direttore, negli orchestrali e nell'entusiasmo
del numeroso pubblico presente. Applausi
fragorosi e ripetuti. Questa sera alle ore 20.00
si replica. Da non perdere.
tra i migliori direttori
di questa compagine orchestrale, una formazione
che conosce molto bene e con la quale trova una
sintonia speciale. Eccellenti prima i delicati e
trasparenti brani de Lo Schiaccianoci e
di ottima qualità
L'oiseau de feu,
ampio lavoro ricco di contrasti timbrici e
dinamici, in crescendo anche per la qualità
innovativa della musica. Un esempio di grande
orchestrazione che richiede una visione unitaria
perfettamente ritrovata da Axelrod. Un successo
annunciato con un riscontro nel volto del
direttore, negli orchestrali e nell'entusiasmo
del numeroso pubblico presente. Applausi
fragorosi e ripetuti. Questa sera alle ore 20.00
si replica. Da non perdere.
 eseguite
nel luglio dello scorso anno sempre in un
concerto di SIMC. Andrea Talmelli,
Presidente della SIMC, e Michele Fredrigotti,
noto pianista e compositore, hanno presentato
cinque giovani musicisti e i numerosi
strumentisti e cantanti interpreti delle loro
composizioni. L'Achrome Ensemble, gruppo
cameristico specializzato in musica
contemporanea, ed alcuni allievi della Civica
Scuola di Musica "Claudio Abbado", con l'ausilio,
in alcuni lavori, delle voci di Eleonora Colaci,
soprano, Marco Pangalli, baritono e Bo Shimmin,
tenore, hanno eseguito complessivamente sei
nuovi brani. I compositori stessi li hanno
presentati, ad iniziare da Cristina Maria Noli
col suo Sogni che tramutano i pensieri,
per flauto, clarinetto e violoncello, un lavoro
costruito in modo efficace nel dialogo
espressivo dei tre strumenti, ottimamente
interpretato rispettivamente da Antonella Bini,
Stefano Merighi e Martina Rudic. Il brano
successivo di Giuseppe
eseguite
nel luglio dello scorso anno sempre in un
concerto di SIMC. Andrea Talmelli,
Presidente della SIMC, e Michele Fredrigotti,
noto pianista e compositore, hanno presentato
cinque giovani musicisti e i numerosi
strumentisti e cantanti interpreti delle loro
composizioni. L'Achrome Ensemble, gruppo
cameristico specializzato in musica
contemporanea, ed alcuni allievi della Civica
Scuola di Musica "Claudio Abbado", con l'ausilio,
in alcuni lavori, delle voci di Eleonora Colaci,
soprano, Marco Pangalli, baritono e Bo Shimmin,
tenore, hanno eseguito complessivamente sei
nuovi brani. I compositori stessi li hanno
presentati, ad iniziare da Cristina Maria Noli
col suo Sogni che tramutano i pensieri,
per flauto, clarinetto e violoncello, un lavoro
costruito in modo efficace nel dialogo
espressivo dei tre strumenti, ottimamente
interpretato rispettivamente da Antonella Bini,
Stefano Merighi e Martina Rudic. Il brano
successivo di Giuseppe
 Gammino,
Planctus- dramma per ensemble, prevedeva
anche una regia per i movimenti del soprano
Eleonora Colaci e del baritono Marco Pangallo
realizzati nel contesto strumentale da Demetrio
Colaci. Un lavoro particolarmente incisivo,
molto attuale, che narra la triste vicenda di un
femminicidio. L'ottima voce della Colaci e la
parte, soprattutto recitata, di Pangallo, sono
state sottolineate dalle timbriche incisive e
suggestive dagli strumentisti dell' Achrome
Ensemble e dalle percussoni di Marco Martignoni,
tutto diretti con precisione di dettaglio da
Marcello Parolini. Una pièce musicale
particolarmente riuscita, quella di Gammino che
andrebbe certamente replicata in sale da
concerto o
Gammino,
Planctus- dramma per ensemble, prevedeva
anche una regia per i movimenti del soprano
Eleonora Colaci e del baritono Marco Pangallo
realizzati nel contesto strumentale da Demetrio
Colaci. Un lavoro particolarmente incisivo,
molto attuale, che narra la triste vicenda di un
femminicidio. L'ottima voce della Colaci e la
parte, soprattutto recitata, di Pangallo, sono
state sottolineate dalle timbriche incisive e
suggestive dagli strumentisti dell' Achrome
Ensemble e dalle percussoni di Marco Martignoni,
tutto diretti con precisione di dettaglio da
Marcello Parolini. Una pièce musicale
particolarmente riuscita, quella di Gammino che
andrebbe certamente replicata in sale da
concerto o
 luoghi
adatti. Il terzo lavoro, di Diego Petrella,
pianista e compositore, era denominato Tre
frammenti di Zürau, per pianoforte, voce e
cordiera. I testi di Franz Kafka hanno trovato
l'ottima parte pianistica affidata alle decise
mani di Michele Rinaldi, mentre la voce e gli
effetti integrativi sulla cordiera del
pianoforte erano dello stesso Petrella. Una
performance, quella di Petrella, che trova
ispirazione dalle pièce di Sylvano
Bussotti e che riesce a piacere per l'ottima
integrazioni delle varie componenti, la valida
parte pianistica cui si aggiunge l'intonatissima
aria fischiata nel finale dallo stesso
compositore-interprete. I due brani successivi,
When I have fears e Three screenshots
erano di Giorgio F. Dalla Villa. Il primo
per tenore e pianoforte con la valida voce di Bo
Shimmin e l'ottima parte pianistica interpretata
con sicurezza ed incisività da Alessandro Lotto.
Il secondo con l'Achrome Ensemble nel duo
di clarinetto/clarinetto basso e violoncello che
ha sottolineato in modo efficace i tre quadri
musicali di Dalla Villa ben delineati dagli
ottimi strumentisti Merighi e Rudic.
luoghi
adatti. Il terzo lavoro, di Diego Petrella,
pianista e compositore, era denominato Tre
frammenti di Zürau, per pianoforte, voce e
cordiera. I testi di Franz Kafka hanno trovato
l'ottima parte pianistica affidata alle decise
mani di Michele Rinaldi, mentre la voce e gli
effetti integrativi sulla cordiera del
pianoforte erano dello stesso Petrella. Una
performance, quella di Petrella, che trova
ispirazione dalle pièce di Sylvano
Bussotti e che riesce a piacere per l'ottima
integrazioni delle varie componenti, la valida
parte pianistica cui si aggiunge l'intonatissima
aria fischiata nel finale dallo stesso
compositore-interprete. I due brani successivi,
When I have fears e Three screenshots
erano di Giorgio F. Dalla Villa. Il primo
per tenore e pianoforte con la valida voce di Bo
Shimmin e l'ottima parte pianistica interpretata
con sicurezza ed incisività da Alessandro Lotto.
Il secondo con l'Achrome Ensemble nel duo
di clarinetto/clarinetto basso e violoncello che
ha sottolineato in modo efficace i tre quadri
musicali di Dalla Villa ben delineati dagli
ottimi strumentisti Merighi e Rudic.
 L'ultimo
brano in programma, Trasfigurazioni, di
Filippo Scaramucci, per cinque strumentisti
dell'Achrome Ensemble, sempre diretti da
Parolini, ha ritrovato ancora una valida resa
compositiva ed interpretativa. Tutti i brani
ascoltati ieri erano scritti con un linguaggio
articolato e chiaro nelle intenzioni, eseguiti
con grande professionalità e qualità di
restituzione, e -cosa non scontata nel mondo
della musica contemporanea- sono risultati
accessibili all'ascolto ottenendo meritati
applausi dal numeroso pubblico intervenuto in
Sala Fontana. Un'iniziativa di valore che
aggiunge un altro mattone alla maggiore
diffusione della musica contemporanea.
L'ultimo
brano in programma, Trasfigurazioni, di
Filippo Scaramucci, per cinque strumentisti
dell'Achrome Ensemble, sempre diretti da
Parolini, ha ritrovato ancora una valida resa
compositiva ed interpretativa. Tutti i brani
ascoltati ieri erano scritti con un linguaggio
articolato e chiaro nelle intenzioni, eseguiti
con grande professionalità e qualità di
restituzione, e -cosa non scontata nel mondo
della musica contemporanea- sono risultati
accessibili all'ascolto ottenendo meritati
applausi dal numeroso pubblico intervenuto in
Sala Fontana. Un'iniziativa di valore che
aggiunge un altro mattone alla maggiore
diffusione della musica contemporanea.