Ha vinto nel maggio scorso la Palma d’Oro al Festival di Cannes questo ultimo film del pluripremiato regista iraniano Jafar Panahi, sessantacinquenne, con alle spalle tre condanne da parte del Tribunale della Rivoluzione di Teheran – la più recente, di pochi giorni fa, a un anno di prigione, in contumacia – e due incarcerazioni, in quanto critico del regime e sostenitore delle manifestazioni di dissenso. Un semplice incidente è un potente messaggio rivolto sia alla dittatura islamica teocratica che governa col terrore, che a tutti gli iraniani e, alla fine, a ogni essere umano sulla Terra.
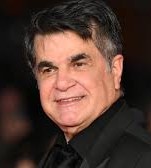
Realizzato senza autorizzazioni e in modo semiclandestino, girato alla periferia della capitale e nel deserto iraniano, il film ha una prima parte quasi surreale, con personaggi dai comportamenti improbabili e aggressivi; compaiono riferimenti teatrali, di cui uno esplicitato chiaramente (Aspettando Godot di Samuel Beckett), e altri meno evidenti, per quanto allo spettatore possa venire in mente qualche dramma shakespeariano, o addirittura il tema pirandelliano delle maschere e del “giuoco delle parti”.

Al meccanico Vahid (Vahid Mobasseri) basta sentire casualmente il passo di un uomo che si è fermato, per un guasto all’automobile dopo un incidente – l’investimento di un cane – per riconoscere in lui quello che anni prima lo aveva torturato in carcere: Eghbal, detto “Gambalesta”, zoppicante perché portatore di una protesi dopo aver perso la gamba destra in Siria. Lo segue di nascosto e riesce a sequestrarlo; sta per seppellirlo vivo – e da vittima si è trasformato quindi in un crudele assassino – quando gli sorge il dubbio di aver commesso un errore di persona, visto che l’uomo (Ebrahim Azizi) dice di chiamarsi Rashid e nega di essere Eghbal.

Vahid non lo ha mai visto in faccia, essendo bendato durante le torture.

Decide quindi di portarlo, legato e imbavagliato dentro una cassa, sul suo furgone, da un amico che potrebbe riconoscerlo; e da quel momento inizia un giro assurdo e grottesco che lo porta a far salire sul veicolo insieme a lui altre quattro persone, due uomini (Ali e Hamid) e due donne (Goli e Shiva).

Ali (Majid Panahi) e Goli (Hadis Pakbaten) sono una coppia alla vigilia delle nozze; la ragazza indossa l’abito da sposa, lui un completo elegante. Sono figure che appaiono stravaganti nella vicenda, ma in realtà sono molto simboliche, perfino nella contrapposizione dei colori, il bianco e il nero, come il bene e il male. Rappresentano anche il futuro, coloro che potranno dare vita a una nuova generazione. Sono vestiti da cerimonia perché si stavano facendo riprendere per l’album di matrimonio da Shiva (Mariam Afshari), brava fotografa, donna moderna e concreta.

Hamid (Mohammad Ali Elyasmehr), come Goli e Shiva, è stato torturato da Eghbal, e crede di riconoscerlo toccandogli le gambe, come faceva in prigione. Diventa anche lui assetato di vendetta. Shiva ritiene che il sudore dell’uomo abbia lo stesso odore che lei ricorda. Ma nessuno lo ha mai visto: come Vahid, anche loro erano sempre bendati. Ali resta una figura a parte, non avendo subìto le torture descritte dagli altri, e sembra quasi non comprendere neppure il dramma di Goli.

Shiva è l’unica che riesce a pronunciare parole diverse: parla di giustizia, di etica, non vorrebbe fare lei stessa quello che Eghbal ha fatto ad altri. E sarà proprio lei, in una scena finale, immersa in una luce rossa come il sangue, in ginocchio davanti all’uomo legato a un albero, a pronunciare il più forte, lungo e accorato j’accuse che Panahi poteva gridare tramite la sua voce. Affermazioni e domande terribili, indimenticabili, che rievocano lo strazio e la sofferenza di troppi in Iran, e la spaventosa responsabilità individuale di chi agisce in modo sadico, senza pietà, affermando di dover ubbidire così alle “leggi del sistema” e al “volere di Dio”: ma merita solo di essere chiamato, più e più volte, “verme schifoso”.
La voce dell’innocenza in tutto questo è solo quella di una bambina, la figlia del presunto torturatore, che chiede aiuto al cellulare del padre: la madre sta male, sta per partorire ed è svenuta. Ed ecco che la volontà di morte del gruppo diventa volontà di vita, un riscatto morale per tutti, un gesto di grande umanità, al di sopra di ogni miseria. Ma il passo zoppicante, il ricordo dell’orrore, incombe.
Da vedere assolutamente.


