L’immagine del Golem, figura complessa e sicuramente affascinante, appartenente alla mitologia ebraica, ha ispirato in passato diversi autori, in ambito sia letterario che cinematografico e teatrale, a partire dall’inizio del ‘900: e certo anche il famoso film Frankenstein del regista James Whale (1931) prese spunto da questi lavori.
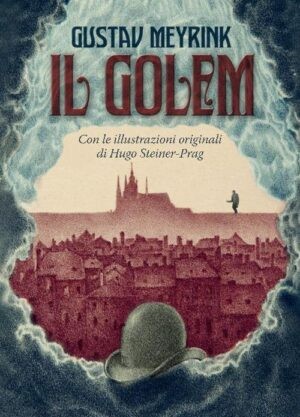
Golem significa “materia grezza”, “embrione”; in ebraico moderno ha assunto anche il significato di “robot”. Si tratta, per la leggenda, di un gigante d’argilla dalla forza straordinaria, privo di anima, sempre ubbidiente, una specie di schiavo potentissimo, che ogni ebreo poteva fabbricare purché fosse a conoscenza dei segreti della Cabala – la dottrina ebraica dell’interpretazione simbolica del senso profondo della Bibbia – e delle parole associate ai poteri divini.

Famoso il golem di Praga, che si racconta fosse stato creato dal rabbino Löw nel XVI secolo: la parola “verità” in ebraico, scritta in fronte, lo aveva reso “vivo”. Il gigante a un certo punto divenne pericoloso e distruttivo, senza più controllo; il rabbino riuscì a cancellare la lettera iniziale di “verità” (emet), che divenne la parola “morto” (met). Il golem, ormai inerte e innocuo, giace da allora nella soffitta dell’antica Sinagoga di Praga…

Juan Mayorga, sessantenne drammaturgo e filosofo madrileno, nonché matematico e traduttore, ha voluto intitolare Il Golem questo suo lavoro del 2022, che vuole mettere la parola al centro dell’opera. Al Parenti è in scena dal 9 al 14 dicembre in Sala Grande, con la regia di Jacopo Gassmann, sul testo tradotto da Pino Tierno. Tre personaggi si muovono sul palcoscenico (altri sono invisibili ma spesso citati e “richiamati” dai medesimi): Ismaele (Francesco Sferrazza Papa), sua moglie Felicia (Monica Piseddu), e una donna misteriosa che si fa chiamare Salinas (Elena Bucci) e dice di essere una traduttrice. “Conosco un numero di lingue tale che potrei essere scambiata per il diavolo” afferma a un certo punto.

La vicenda si svolge in un edificio che viene presentato come ospedale (“Ma non sembra un ospedale”, viene ripetuto più volte) dove è ricoverato Ismaele per una malattia molto grave, non meglio identificata; Felicia è presente per assisterlo, ma Salinas annuncia che lui deve essere dimesso, come molti altri, per ragioni legate a questioni amministrative (così almeno pare di capire). Propone però a Felicia un patto, evidentemente molto simbolico in quanto totalmente senza senso: se riesce a imparare tre parole al giorno – in una lingua a lei incomprensibile, da un libro che le viene fornito – Ismaele può continuare a essere curato. Felicia accetta. Da questo momento in avanti tutto diventa piuttosto incomprensibile anche per gli spettatori.

La figura del “matematico”, con il quale Felicia dice di incontrarsi, e quella di una donna, Lois, che dovrebbe essere una sorta di direttore medico, spesso citata da Salinas, restano dietro le quinte, senza un ruolo chiarificatore. Anche Ismaele non è un personaggio delineato; spesso si reca nel Paradiso, come viene chiamata una sala dell’ospedale, ma non si sa bene che cosa vi succeda.

I dialoghi sono astrusi, si fa fatica a seguirli e si finisce per perdere facilmente sia il filo della narrazione che il messaggio di fondo di Mayorga, che dovrebbe essere in realtà una domanda: “Quello che dico mi trasforma in quello che sono?”, questione che comunque è senza risposta. Brevi favole, simili a parabole, raccontate da Felicia, non contribuiscono né a chiarire né ad alleggerire il tutto. Il Golem viene citato da Salinas, ma appare quasi fuori contesto.
La scena monotona, geometrica, tutta grigia e buia, con qualche guizzo dinamico e luminoso che la fa talvolta assomigliare a una sorta di installazione di arte contemporanea, dove anche chi recita è vestito di grigio e di nero, non aiuta a mantenere la concentrazione indispensabile per cercare di cogliere eventuali nessi e significati. Anche il monologo finale di Felicia – che inizia quando il pubblico aveva già ipotizzato la conclusione del lavoro – resta oscuro e appare delirante: esordisce con un “Non sono un profeta” per poi parlare di “guerra civile”, di battaglie anche contro se stessi… Si è trasformata, grazie alle parole apprese e all’ ”esperimento” di Salinas, in una sorta di rivoluzionario? È diventata Pablo, che è morto? È forse Felicia una specie di Golem al femminile? Si è perplessi. Il linguaggio appare ermetico, indecifrabile, come il contenuto del lavoro complessivo, reso purtroppo ostico e pesante. Fiacchi gli applausi del pubblico.


